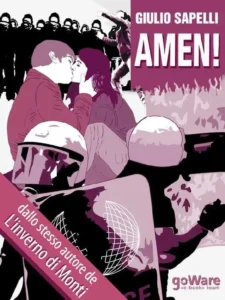1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Chi comanda in Italia” di Giulio Sapelli è un libro che ti prende e ti sbatte in faccia la realtà di come è cambiato il potere nel nostro paese, e non solo. Se ti sei mai chiesto chi tira davvero i fili dietro le quinte, questo libro prova a darti una risposta, partendo dal dopoguerra fino ai giorni nostri. Sapelli ci racconta di come i vecchi partiti, che una volta erano fortissimi e quasi sostituivano lo Stato, siano stati smantellati, anche con l’aiuto della magistratura e della finanza globale. Non è più una questione di politici e burocrati, ma di gruppi di interesse, banche, e poteri internazionali che si muovono in un sistema politico italiano sempre più frammentato e instabile. Il libro esplora le radici di questa trasformazione politica, tornando indietro al fascismo e all’epoca Giolitti per capire perché la borghesia italiana ha sempre fatto fatica a creare un potere stabile, finendo per affidarsi a compromessi o a forze esterne. Viene fuori un quadro di un capitalismo italiano spesso “senza mercato”, basato su rendita, clientelismo e quello che Sapelli chiama “familismo amorale”, dove l’interesse del gruppo viene prima di tutto. È un viaggio attraverso la crisi dei partiti, l’ascesa di nuovi attori come la magistratura e la finanza, e le conseguenze sulla legalità e sulla società italiana, che sembra sempre più disgregata. Sapelli non si limita a descrivere il problema, ma cerca anche di capire cosa servirebbe per ricostruire un sistema più solido, basato sul lavoro e sul bene comune, in un’Europa che pure sta cambiando faccia. È una lettura che ti fa riflettere un sacco su come funzionano davvero le cose e su quanto sia complessa la lotta per il potere in Italia.Riassunto Breve
Dopo la guerra, in Italia lo Stato era debole e i partiti lo sostituivano, controllando l’economia con tecnici e politici. Mediobanca teneva in equilibrio pubblico e privato, ma le perdite erano socializzate e i guadagni privati, con l’appoggio degli Stati Uniti. Chi minacciava questo sistema veniva messo da parte. I rapporti tra i settori sociali erano basati su accordi tra gruppi, non sulla produzione, e questo portò a problemi, come l’accordo sulla scala mobile nel 1974 che indebolì sindacati e industriali. Poi arrivò il mercato senza regole e le privatizzazioni. I partiti furono smantellati, anche con azioni legali, perché erano diventati un ostacolo alle privatizzazioni e avevano sfidato l’influenza americana su certe decisioni. Dagli anni Novanta, in Italia manca un punto di riferimento stabile per il potere. Non ci sono più i partiti a sostituire lo Stato, ma gruppi di interesse che cambiano e cercano appoggi fuori dall’Italia. Il potere dei partiti è diviso. Il potere dei giudici è cresciuto molto, sia in Italia che nel mondo, diventando di fatto il potere principale in una società senza strutture solide. Anche gli attacchi al Presidente della Repubblica mostrano questa mancanza di stabilità. La nuova struttura di potere, con imprese e banche meno forti, non ha basi solide ed è rischiosa. Intanto, in Europa, dopo la fine della Guerra Fredda, si è diffuso il capitalismo di tipo americano e inglese. L’unificazione dei mercati ha trovato resistenze, soprattutto dalle banche centrali che proteggevano interessi particolari. La Germania ha imposto le regole della sua banca centrale alla Banca Centrale Europea. Per avere un sistema stabile in Italia servirebbe un accordo tra chi produce, appoggiato da gruppi autonomi (come associazioni di categoria), per avere più legalità e crescita. Un grande cambiamento nel rapporto tra politica ed economia in Italia è avvenuto all’inizio degli anni Novanta, proprio mentre il capitalismo internazionale diventava meno controllato, usando strumenti finanziari complessi che favoriscono chi vive di rendita. L’Italia era più esposta per la sua posizione e per la presenza di gruppi legati al potere americano. Questo cambiamento si è visto nell’azione di alcuni magistrati, soprattutto a Milano, che hanno indagato sui partiti. Questi giudici hanno avuto l’appoggio di una parte dell’alta finanza italiana, legata a gruppi internazionali, e dei mezzi di comunicazione. Questa azione ha rotto con una tradizione politica che risaliva al fascismo. Il fascismo aveva unito la borghesia in un partito-Stato, creando un sistema basato sul controllo del partito e sulla divisione dell’amministrazione pubblica. Solo la Chiesa e l’alta finanza tecnica erano un po’ indipendenti. Prima del fascismo, con Giolitti, il governo agiva per la borghesia, ma questo creava divisioni e il “trasformismo”, un modo per gestire i tanti interessi diversi. Questo sistema non ha retto all’arrivo dei partiti di massa e dei conflitti sociali dopo la Prima Guerra Mondiale. La borghesia non riusciva a creare un potere stabile, e questo ha portato al fascismo, visto come una reazione. Il fascismo ha unito il sistema politico con la forza e ha governato insieme alla società economica, creando un capitalismo con grandi gruppi statali e privati, ma senza un vero mercato. Nonostante questo, la società civile e politica è rimasta divisa. Il consenso al fascismo veniva soprattutto dalle classi medie e alte, mentre le classi popolari accettavano la dittatura per necessità ma tenevano i loro valori. Il sistema autoritario fascista non è riuscito a unire la società perché mancava il libero confronto delle idee, che invece c’era, anche se con difficoltà, nell’epoca di Giolitti. Le idee politiche di prima del fascismo sono sopravvissute e sono tornate forti durante la lotta contro la dittatura e nella ricostruzione politica dopo. La Resistenza ha cambiato molto la politica italiana, soprattutto nel modo in cui si formava la classe dirigente. Prima, i politici venivano da famiglie importanti del posto o da interessi economici e statali. Il fascismo aveva scelto i potenti direttamente tramite il partito unico. Con la Resistenza è emerso un gruppo politico diverso, che veniva dalla lotta armata, dalle prigioni, da movimenti internazionali e religiosi. Questa nuova classe dirigente non veniva dai vecchi centri di potere o dalla società civile che esprimeva i valori comuni. Ha trovato nei partiti di massa il posto per crescere. Dove i partiti di massa non erano forti, sono tornati i vecchi politici e i vecchi gruppi sociali legati alla terra e alla finanza. I partiti di massa, invece, hanno creato una politica nuova, quasi contro la società civile, fatta da una minoranza che aveva rischiato molto per ideali futuri, non per vantaggi immediati. Questa classe politica era innovativa perché riusciva a controllare, almeno in parte, gli interessi economici locali e nazionali, non essendo completamente sotto il loro controllo. L’Italia è entrata nel mercato comune europeo grazie a persone come De Gasperi e La Malfa, che avevano una visione di controllo statale dell’economia e legami con l’alto capitalismo internazionale, superando l’opposizione di chi rappresentava il vecchio capitalismo chiuso e anche di una parte della sinistra che, pur avendo educato le masse alla democrazia, all’inizio era contraria. Però, anche in questa fase di novità, è tornata una vecchia abitudine: il trasformismo. Nella democrazia parlamentare, questo si è manifestato in due modi: un sistema di favori legato alla spesa pubblica, gestito dalle correnti interne ai partiti, e un rapporto diretto tra le grandi imprese e i politici. Le imprese cercavano di influenzare i partiti con pressioni e corruzione, saltando la mediazione politica e indebolendo anche il ruolo della Confindustria, finché le grandi aziende non hanno preso il controllo diretto dell’associazione degli industriali. Un nuovo tipo di trasformismo, basato sui favori di massa, mostra le profonde divisioni nella società e nella politica. Questo sistema porta i partiti e i gruppi di interesse a prendersi continuamente lo Stato, creando un rapporto di scambio di vantaggi attraverso la gestione dei soldi pubblici. Mentre uno Stato con un partito unico può usare esperti (tecnici), una democrazia parlamentare con una burocrazia debole e classi politiche in crescita considera i tecnici inutili per mantenere il potere e il consenso. Così, i tecnici vengono messi da parte. Questo è successo in Italia in modo definitivo, a partire dagli anni dei governi di centro-sinistra. La magistratura ha avuto un ruolo fondamentale in questo cambiamento. Sono state colpite persone importanti nel campo tecnico e scientifico: è stato arrestato Felice Ippolito, distruggendo il CNEN, è stato minacciato il presidente del CNR, è stato accusato il direttore dell’Istituto Nazionale della Sanità. Negli anni Settanta, è stato ritirato il passaporto al governatore della Banca d’Italia ed è stato arrestato un direttore generale. Questo ha spaventato i tecnici, ha bloccato la loro azione e ha aperto la strada a un grande sistema basato sull’uso privato delle risorse pubbliche. Negli anni Ottanta si è diffuso questo sistema, dove mercati, politica e partiti sono controllati dalle grandi imprese. Questo dominio basato su accordi segreti ha distrutto la fiducia nella legalità. Questo sistema è una forma nuova del trasformismo. Unisce gli interessi economici e politici di un capitalismo che non compete, controllando in modo capillare la spesa pubblica. Questo controllo garantisce vantaggi economici con la corruzione, ma dà anche alle classi politiche un potere enorme, arbitrario e basato sul ricatto. Le classi politiche di prima erano autonome dalla società civile. Le nuove classi, invece, vengono dalla società e mostrano i tratti di una “modernizzazione senza sviluppo”. La caratteristica principale è il “familismo amorale”: l’interesse del proprio gruppo viene prima dell’interesse generale o del bene comune. Le classi politiche diventano il veicolo di questo “familismo amorale”. La fine della vecchia classe politica porta a una circolazione di élite che pensano al proprio gruppo invece che al bene comune. Questo sembra un fenomeno che non si può cambiare. La società civile e politica è cambiata molto in questo senso. Anche i rinnovamenti successivi non hanno cambiato questa caratteristica. Il crollo dei partiti di massa sposta il potere di distribuire le risorse dai partiti a gruppi come massonerie, famiglie e “amici degli amici”, creando un sistema nuovo e forte basato sullo “status” e le conoscenze personali, non sul “contratto”. Il rapporto tra politica, economia e potere dello Stato è un processo necessario per l’ordine sociale. I primi anni Novanta segnano un grande cambiamento nel sistema politico italiano, soprattutto dopo le elezioni del 1994 e le indagini di “Mani pulite”. Partiti storici come DC e PSI spariscono, mentre nascono Lega Nord e Forza Italia. Questo periodo vede la fine di un ciclo nei rapporti tra potere economico e politico. Il potere economico non cerca più solo di influenzare la politica, ma vuole distruggerla, anche usando il potere dei giudici, che colpiscono soprattutto la classe politica. Emerge un potere più ristretto, dominato da chi fa parte di un “capitalismo senza mercato”. Dopo che i tentativi di governi tecnici falliscono, emerge una leadership basata su una sola persona, rappresentata dal “partito-azienda” Forza Italia. Questa forza politica nasce per contrastare la crescita del PDS dopo la crisi dei partiti di centro. Forza Italia rappresenta una rottura tra la vecchia società politica e il nuovo sistema di partiti, unendo elementi della moderazione della DC e del socialismo di Craxi. Si vede un cambiamento nel tipo di persone che fanno politica: gli imprenditori entrano direttamente in Parlamento. Il ruolo storico della DC di portare gruppi sociali di destra verso il centro del sistema dei partiti viene meno. Questo contribuisce a un ritorno a una divisione più netta tra i partiti, mostrata dal fatto che le classi sociali si dividono nel voto, con la borghesia che si schiera con la destra e il centro-destra. La nascita di Forza Italia e Lega Nord mostra il fallimento della morale cattolica nel civilizzare le masse e, al contrario, la vittoria della tradizione comunista nella sua capacità di cambiare e integrare i lavoratori nella democrazia. A livello internazionale, i governi socialisti e democratici promuovono la riduzione delle regole per la finanza, abbandonando l’idea della “civiltà del lavoro”. Per ricostruire un potere stabile serve un sistema con più centri di potere dove partiti e rappresentanti dei territori tornano ad avere importanza, insieme a rappresentanti di categorie (come Camere di Commercio, Università, associazioni). Questo richiede un cambiamento culturale che ridefinisca gli interessi sociali. Bisogna mettere al centro l’occupazione e il profitto, non la rendita. Su questa base si ricostruisce tutta la politica: assistenza sociale, lavoro, solidarietà, riforma dello Stato e della pubblica amministrazione. Se questo non succede, l’angoscia cresce in generazioni isolate, perse, senza valori, preda del nichilismo e della violenza. Questo problema è evidente in Europa, più che in Nord America o nelle democrazie del Nord Europa, dove si sono ottenuti risultati sul lavoro, anche se con disuguaglianze o riforme difficili, dando speranza. I risultati positivi si ottengono rinunciando a vantaggi immediati per quelli futuri. Se il lavoro è la scelta principale, tutto deve essere messo in secondo piano rispetto ad esso. Ripensare la rappresentanza politica e sindacale significa affrontare questi problemi, inseriti in una chiara scelta culturale con ideali a lungo termine che guidano le politiche a medio termine. La volontà di agire per il “bene comune”, non solo per un’élite, è fondamentale e definisce il nuovo confronto tra destra e sinistra. La sinistra rischia di crollare a causa di alleanze elettorali e trasformazioni in sistemi di favori e ruberie, con potere basato sulla persona e sui clan che distruggono la forma partito. Se questo accade, i problemi italiani si risolvono solo per intervento esterno. Si assiste a una continua perdita di potere dei parlamenti a favore di poteri finanziari sovranazionali, invisibili, visibili e di poche persone, che controllano le variabili economiche principali. Questi poteri non sono soggetti alla sovranità prevista dalla Costituzione. Il pensiero basato sulla Costituzione è disarmato di fronte a questa perdita di potere del popolo sovrano. Questo porta al moltiplicarsi di sistemi diversi e di “autorità indipendenti”. Verso queste autorità, far rispettare le regole è difficile o impossibile. Esse diffondono solo una logica di mercato, pratica e tecnica, togliendo valore alla legalità e a ogni logica che non sia amministrativa. La divisione del potere distrugge l’autorità delle regole sociali e la solidarietà basata sulla cooperazione si indebolisce. Trionfano le solidarietà basate sulla somiglianza, tipiche di una società divisa: legami di amicizia, di affari, familiari, che si mescolano con politica ed economia, simili ai legami di sangue delle società primitive. Il legame che unisce politica ed economia non è più il dovere politico, ma la legge del più forte e il familismo amorale diffuso. La prova è il crollo dell’autorità della legge. Un buon cittadino rispetta la legge per dovere morale, non per paura. Oggi è il contrario: la fiducia nella legalità crolla nella disgregazione sociale e morale. Questo indica un possibile passaggio dall’attuale sistema con più centri di potere a una lotta tra il Caos (trionfo del più forte) e la Dittatura (apparenza di legalità sotto chi comanda). L’alternativa, presentata in modo non esplicito, potrebbe essere l’essere governati da autorità sovranazionali, realizzando un desiderio “anti-italiano” di governo esterno, ricordando che il successo storico italiano stava nella diversità imprenditoriale e culturale, non nell’autogoverno politico nazionale.Riassunto Lungo
1. La trasformazione del potere in Italia e in Europa
Nel dopoguerra, il potere in Italia ha cambiato volto. In un periodo in cui lo Stato era debole, i partiti politici ne hanno preso il posto, controllando l’economia attraverso una gestione che univa aspetti tecnici e politici. Mediobanca, in quel contesto, svolgeva un ruolo di equilibrio tra pubblico e privato, spesso “socializzando” le perdite (facendole ricadere sulla collettività) e “privatizzando” i profitti (beneficiando i privati), con il sostegno degli Stati Uniti. Chi minacciava questo sistema di potere, come figure influenti quali Amintore Fanfani ed Eugenio Cefis, veniva allontanato. I rapporti tra i vari settori della società e dell’economia erano basati su accordi tra categorie (corporativi) che non favorivano la crescita produttiva. Un esempio negativo fu l’accordo del 1974 tra Fiat (Agnelli) e i sindacati sulla scala mobile, che finì per indebolire sia le rappresentanze dei lavoratori che l’associazione degli industriali (Confindustria).L’arrivo del mercato e le privatizzazioni
L’introduzione di un mercato con meno regole e le privatizzazioni hanno portato allo smantellamento del potere dei partiti, spesso attraverso azioni giudiziarie. I partiti erano diventati un ostacolo a queste privatizzazioni e avevano mostrato resistenza all’influenza degli Stati Uniti su questioni importanti, in particolare sotto la guida di Giulio Andreotti e Bettino Craxi.L’instabilità dopo gli anni Novanta
Dagli anni Novanta, in Italia non c’è più un punto di riferimento stabile per il potere. Lo Stato non è più sostituito dai partiti, ma da gruppi di interesse diversi che cambiano nel tempo e cercano appoggio a livello internazionale. Il potere dei partiti è diviso e frammentato. Nello stesso periodo, il potere giudiziario è cresciuto enormemente, sia in Italia che nel resto del mondo, diventando di fatto il potere dominante in una società che manca di strutture solide. Questa mancanza di stabilità si è manifestata anche in attacchi diretti contro la figura del Presidente della Repubblica. La nuova struttura di potere, con imprese e banche indebolite, non ha fondamenta solide e questa situazione è considerata pericolosa.Il contesto europeo
In parallelo, a livello europeo, la fine della Guerra Fredda ha favorito l’espansione di un modello economico basato sul capitalismo anglo-americano. Il processo di unificazione dei mercati ha incontrato resistenze, soprattutto da parte delle banche centrali che tutelavano interessi legati alla speculazione e ad accordi nascosti. La Germania, in particolare, è riuscita a imporre le regole della sua banca centrale (Bundesbank) alla Banca Centrale Europea. Helmut Schmidt criticò apertamente il governatore della Bundesbank per aver ostacolato la creazione della moneta unica. Helmut Kohl, invece, vedeva nell’integrazione europea e in un accordo con gli Stati Uniti la strada giusta per la Germania.Una proposta per il futuro dell’Italia
Per ricostruire un sistema stabile in Italia, è necessario un accordo forte tra coloro che producono ricchezza (i produttori), sostenuto da organizzazioni e istituzioni che operano in autonomia per il bene comune. Questo patto dovrebbe avere come obiettivi principali il rispetto della legalità e la promozione della crescita economica.È davvero il potere giudiziario il “potere dominante” in una società “senza strutture solide”, o questa è una semplificazione eccessiva di dinamiche ben più complesse?
Il capitolo, pur evidenziando l’indubbia crescita del ruolo della magistratura nel panorama italiano e non solo, presenta questa evoluzione quasi come un vuoto di potere riempito da un’unica forza. Questa prospettiva rischia di trascurare la complessità delle interazioni tra i diversi poteri dello Stato, l’influenza di attori economici e sociali non istituzionali, e le specifiche contingenze storiche che hanno portato a tale situazione. Per comprendere meglio questo fenomeno, è utile approfondire gli studi di scienza politica e sociologia del diritto, analizzando il ruolo delle istituzioni nella storia repubblicana. Autori come Norberto Bobbio o Sabino Cassese possono offrire spunti critici sul funzionamento del sistema politico e amministrativo italiano.2. Dalle vecchie classi alla finanza globale, passando per il fascismo
Un cambiamento importante nel rapporto tra politica ed economia in Italia avviene all’inizio degli anni Novanta. Questo periodo coincide con la diffusione a livello internazionale di un capitalismo meno regolamentato, soprattutto dopo la fine di norme come il Glass-Steagall Act negli Stati Uniti. Si affermano nuovi strumenti finanziari complessi che favoriscono la rendita finanziaria rispetto all’economia produttiva. L’Italia si trova particolarmente esposta a questi cambiamenti, sia per la sua posizione strategica nel contesto globale, sia per la presenza di gruppi economici legati a interessi americani che influenzano le dinamiche interne.L’azione della magistratura e il nuovo scenario
Questo cambiamento si manifesta concretamente attraverso l’azione di settori della magistratura, in particolare a Milano, che iniziano indagini approfondite sul sistema dei partiti politici. Questi magistrati trovano un sostegno significativo in una parte dell’alta finanza italiana, che a sua volta ha legami con gruppi internazionali, e nei principali mezzi di comunicazione. Questa fase segna una netta rottura con la tradizione politica precedente, una tradizione che aveva radici profonde nel periodo fascista e che aveva plasmato per decenni i rapporti tra Stato, partiti e economia.Il sistema politico ed economico fascista
Il fascismo aveva costruito un sistema differente, unificando la borghesia all’interno di un partito-stato. Questo modello si basava su un controllo capillare esercitato dal partito e su una rigida divisione dell’amministrazione pubblica per garantire l’efficienza del regime. In questo quadro, solo la Chiesa e l’alta finanza di stampo tecnocratico riuscivano a mantenere una certa autonomia rispetto al potere centrale del partito. Era un sistema in cui il governo operava con la società economica, creando un capitalismo dominato da grandi gruppi, sia statali che privati, ma privo di un vero e proprio mercato concorrenziale e aperto.La società sotto il fascismo
Nonostante il tentativo di unificazione forzata e il controllo del partito-stato, la società civile e politica rimaneva divisa al suo interno. Il consenso al regime fascista proveniva principalmente dalle classi medie e alte, che vedevano nel fascismo un garante dell’ordine sociale. Le classi popolari, pur accettando la dittatura spesso per necessità economiche o per evitare repressioni, riuscivano a mantenere vivi i propri valori e le proprie tradizioni culturali e politiche. Il sistema autoritario fascista non riuscì a creare una vera unità sociale perché mancava il libero confronto delle idee e delle posizioni politiche, un elemento che, seppur con difficoltà e contraddizioni, era presente nell’epoca precedente.L’epoca Giolitti e la fragilità borghese
Prima dell’avvento del fascismo, durante l’era Giolitti, il governo agiva per favorire gli interessi della borghesia in un quadro liberale. Tuttavia, questo approccio portava a forti divisioni interne alla classe dirigente e al fenomeno del “trasformismo”, un modo per gestire la frammentazione degli interessi politici attraverso accordi e compromessi. Questo sistema, basato su equilibri precari e sulla cooptazione, non fu in grado di resistere all’emergere dei partiti di massa, come quello socialista e quello cattolico, e all’intensificarsi dei conflitti sociali che seguirono la Prima Guerra Mondiale.Dalla crisi di Giolitti al fascismo
La debolezza della borghesia nel costruire un potere politico stabile e unificante fu un fattore cruciale che portò all’ascesa del fascismo. Il fascismo si presentò e fu percepito come una reazione preventiva alla crisi del sistema liberale e all’avanzata dei movimenti popolari che minacciavano l’ordine costituito. Unificò il sistema politico in modo autoritario e violento, ma le idee politiche e sociali che circolavano prima della dittatura non scomparvero del tutto. Anzi, sopravvissero nel tessuto sociale e riemersero con grande forza durante la lotta contro il regime e nel processo di ricostruzione politica che seguì la sua caduta.Come si può affermare che gli eventi degli anni Novanta abbiano rappresentato una rottura netta con una tradizione politica ed economica radicata nel fascismo, quando il capitolo non chiarisce quali specifici elementi di tale tradizione post-fascista siano stati effettivamente smantellati?
Il capitolo descrive il sistema fascista e quello giolittiano, ma il passaggio dalla Repubblica post-bellica (che si suppone abbia mantenuto radici fasciste) al “cambiamento importante” degli anni Novanta non è sufficientemente dettagliato. Per comprendere meglio questa presunta rottura e la natura della tradizione che sarebbe stata interrotta, sarebbe utile approfondire la storia politica ed economica della Prima Repubblica italiana e il dibattito storiografico sulla continuità e discontinuità tra fascismo e Italia repubblicana. Approfondire autori come Paul Ginsborg o Guido Crainz potrebbe fornire il contesto necessario per valutare la portata e la natura del cambiamento descritto.3. La Nuova Classe Politica Nata dalla Lotta
La Resistenza cambia profondamente il modo in cui si forma la classe dirigente in Italia. Prima, i politici venivano soprattutto dai notabili locali o dagli ambienti legati all’economia e allo Stato. Il fascismo, invece, basava il potere sulla scelta diretta e su un unico partito.Una Nuova Origine Politica
Con la Resistenza, emerge un gruppo politico diverso. Questo gruppo nasce dalla lotta armata, dalle prigioni del regime fascista, e da esperienze maturate in movimenti internazionali o religiosi. Questa nuova classe dirigente non viene dai vecchi centri di potere o dalla società civile che esprimeva i valori comuni, ma trova nei grandi partiti di massa il luogo per crescere e affermarsi. Nelle zone dove i partiti di massa non riescono a radicarsi, invece, si assiste al ritorno dei vecchi politici e dei gruppi sociali legati alla proprietà terriera e alla finanza. I partiti di massa, così, danno vita a una politica nuova, quasi separata dalla società civile tradizionale, formata da persone che hanno rischiato molto per un ideale futuro, non per un vantaggio personale immediato.Indipendenza dagli Interessi Economici
Questa classe politica si distingue per la sua capacità di gestire e in parte dominare gli interessi economici, sia a livello locale che nazionale, senza esserne completamente sottomessa. Un esempio significativo è l’ingresso dell’Italia nel mercato comune europeo. Questo passo importante è stato possibile grazie a figure come De Gasperi e La Malfa, che avevano una visione basata su un forte ruolo dello Stato nell’economia e legata all’alto capitalismo internazionale. Questa visione riuscì a superare l’opposizione sia del vecchio capitalismo legato all’autarchia, sia di una parte della sinistra che, pur avendo educato le masse ai principi democratici, era inizialmente contraria a questa apertura.Il Ritorno del Trasformismo
Nonostante questa fase di rinnovamento, riappare una vecchia tendenza della politica italiana: il trasformismo. Nella democrazia parlamentare, questo fenomeno si manifesta in due modi principali. Da un lato, si sviluppa un sistema di favori e scambi basato sulla gestione della spesa pubblica di massa, spesso gestito dalle correnti interne ai partiti. Dall’altro, si crea un rapporto diretto tra le grandi imprese e i politici. Le imprese cercano di influenzare i partiti con pressioni e corruzione, saltando la mediazione politica e indebolendo persino il ruolo delle associazioni di categoria come la Confindustria, finché le grandi aziende non arrivano a controllarla direttamente.Il capitolo dipinge il potere giudiziario come un semplice “strumento” del potere economico. Ma non è forse un’eccessiva semplificazione che ignora la sua autonomia e complessità?
Il capitolo, nel descrivere la trasformazione politica, suggerisce che il potere giudiziario sia stato uno “strumento” del potere economico per indebolire la politica. Questa affermazione, per quanto suggestiva, rischia di ridurre un’istituzione complessa a una mera pedina, trascurando le motivazioni interne, le dinamiche istituzionali e il dibattito sul ruolo della magistratura in una democrazia. Per avere un quadro più completo, è indispensabile approfondire la storia e la sociologia delle istituzioni giudiziarie, oltre agli studi di scienza politica sul rapporto tra poteri. Autori che hanno analizzato criticamente il ruolo della magistratura, come Guido Neppi Modona o Sabino Cassese, possono offrire prospettive più articolate.6. La Crisi del Potere e la Disgregazione Sociale
Per ricostruire un potere stabile, serve una forma di governo dove diversi centri di potere (come partiti politici, rappresentanze dei territori, ma anche Camere di Commercio, Università e associazioni) riprendano forza e credibilità. Questo richiede un cambiamento profondo nel modo in cui si considerano gli interessi della società. Bisogna mettere al centro la possibilità di lavorare e di fare impresa, non la rendita finanziaria o immobiliare. Partendo da qui, si può ripensare tutta la politica: il sistema di assistenza sociale, il mondo del lavoro, la solidarietà tra le persone, la riforma dello Stato e della pubblica amministrazione.Le Conseguenze della Mancanza di Stabilità
Se non si riesce a fare questo, cresce l’angoscia nelle nuove generazioni, che si sentono sole e senza punti di riferimento. Vivono in uno stato di confusione, senza valori chiari, facile preda del pessimismo più totale e della violenza. Si vede bene questo problema in Europa, in modo più forte che in Nord America o nei paesi scandinavi, dove invece sono stati ottenuti risultati positivi sul fronte del lavoro. Questo è successo anche se ci sono ancora disuguaglianze o le riforme sono state difficili, ma almeno si è data speranza. Per ottenere risultati positivi, spesso bisogna rinunciare a vantaggi immediati in cambio di benefici futuri. Quando il lavoro diventa la scelta più importante per la società, tutto il resto deve essere organizzato in funzione di questo obiettivo.La Crisi della Rappresentanza Politica
Affrontare queste questioni significa anche ripensare il modo in cui siamo rappresentati in politica e nei sindacati. Tutto questo deve essere inserito in una visione culturale chiara, con ideali che guardano lontano e che guidano le scelte politiche di medio periodo. È fondamentale riscoprire l’idea di lavorare per il “bene comune”, non solo per un piccolo gruppo di persone. Questo definisce anche il nuovo scontro tra destra e sinistra. La sinistra, in particolare, rischia di perdere completamente la sua identità a causa di alleanze elettorali poco chiare e trasformazioni che portano a favoritismi e corruzione, con un potere concentrato nelle mani di pochi e gruppi chiusi che distruggono l’idea stessa di partito politico. Se questo accade, i problemi dell’Italia potrebbero risolversi solo grazie a un intervento esterno.La Perdita di Sovranità e il Trionfo della Logica di Mercato
Si assiste a una continua perdita di potere da parte degli organi che fanno le leggi (i parlamenti nazionali), a favore di poteri che stanno al di sopra dei singoli Stati, spesso legati alla finanza, a volte nascosti, a volte visibili, ma comunque controllati da poche persone potenti che decidono sulle grandi questioni economiche. Questi poteri sfuggono al controllo delle leggi fondamentali dei singoli paesi. Il pensiero che sta alla base delle costituzioni si trova disarmato di fronte a questa situazione, dove il potere del popolo sembra svanire. Questo porta alla nascita di tanti sistemi di regole diversi e di “autorità indipendenti” che non rispondono direttamente a nessuno. È difficile, se non impossibile, sentire un dovere morale verso queste autorità. Loro diffondono solo una logica basata sul mercato, che è pratica e tecnica, e che finisce per delegittimare le leggi tradizionali e ogni forma di ragionamento che non sia amministrativo.La Frammentazione Sociale e il Crollo della Legalità
La frammentazione del potere distrugge l’autorità delle regole sociali e indebolisce i legami che tengono unita la società in modo complesso. Prevalgono i legami più semplici e basati sull’interesse personale, tipici di una società divisa in tanti piccoli gruppi: amicizie, rapporti d’affari, legami familiari. Questi legami si mescolano con la politica e l’economia, ricordando i legami di sangue delle società antiche. Il rapporto che unisce politica ed economia non è più basato sul senso del dovere verso la comunità, ma sulla legge del più forte e su un diffuso egoismo familiare che mette gli interessi del proprio gruppo prima di tutto. La prova più evidente è il crollo del rispetto per la legge. Un buon cittadino rispetta la legge perché sente che è giusto farlo, non solo per paura di essere punito. Oggi, invece, la fiducia nella legalità scompare a causa della disgregazione sociale e morale.Scenari Futuri
Si rischia di passare dall’attuale sistema con più centri di potere a una lotta tra il caos totale, dove vince il più forte, e una forma di dittatura, dove c’è solo una finta legalità sotto il controllo di pochi potenti. L’alternativa, presentata in modo non sempre chiaro, potrebbe essere quella di essere governati da autorità che stanno al di sopra dei singoli Stati. Questo realizzerebbe un desiderio, quasi “anti-italiano”, di essere guidati dall’esterno. Eppure, il successo storico dell’Italia è sempre stato nella sua grande varietà di iniziative economiche e culturali, non certo nella capacità di autogovernarsi a livello nazionale in modo unitario.Ma la perdita di sovranità nazionale a favore di poteri ‘sopra i singoli Stati’ è solo il trionfo della logica di mercato, o il sintomo di una realtà globale più complessa che il capitolo non esplora a fondo?
Il capitolo descrive efficacemente il sintomo della perdita di potere dei parlamenti nazionali e l’ascesa di autorità indipendenti legate alla finanza. Tuttavia, non approfondisce le ragioni strutturali e storiche che hanno portato a questa evoluzione, né considera le argomentazioni a favore di forme di governance sovranazionale o di autorità tecniche indipendenti in un mondo interconnesso. Per comprendere meglio questo fenomeno, sarebbe utile esplorare la letteratura sull’economia politica internazionale, la teoria delle relazioni internazionali e gli studi sulla globalizzazione. Approfondire il pensiero di autori che hanno analizzato la trasformazione dello Stato-nazione e l’emergere di nuove forme di potere globale, come ad esempio chi si occupa di governance globale o di diritto costituzionale transnazionale, potrebbe fornire un contesto più ricco e sfumato.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]