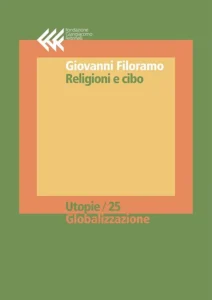Contenuti del libro
Informazioni
“Buddhismo” di Giovanni Filoramo è un viaggio affascinante che ripercorre la storia del buddhismo dalle sue origini in India con il Buddha Gautama, esplorando concetti chiave come le Quattro Nobili Verità, il karma e il nirvana. Il libro mostra come questa via di liberazione, inizialmente basata sull’ascesi e la conoscenza, si sia diffusa e trasformata attraverso l’Asia. Seguiamo la sua evoluzione in luoghi come lo Sri Lanka con il buddhismo Theravada, il Tibet con le sue tradizioni tantriche e i lama, la Cina con l’incontro-scontro con confucianesimo e taoismo, e il Giappone con la nascita di scuole uniche come lo Zen e la Terra Pura. Vediamo il ruolo cruciale di maestri, imperatori come Ashoka, e la formazione dei testi buddhisti. Infine, il libro arriva al buddhismo in occidente, descrivendo come l’interesse sia cresciuto, passando dallo studio alla pratica della meditazione, portando alla nascita di diverse comunità. È un racconto ricco e chiaro che esplora la resilienza e la varietà delle scuole buddhiste attraverso i secoli e i continenti.Riassunto Breve
Le tradizioni indiane come il buddhismo non sono viste come religioni nel senso occidentale, ma come vie per la liberazione dalla sofferenza e dal ciclo delle rinascite, basate sull’ascesi e sulla conoscenza. Il Buddha, uno tra i maestri asceti (śramaṇa), insegnò le Quattro Nobili Verità, che spiegano la natura del disagio esistenziale (duḥkha), la sua causa (la “sete” o desiderio), la possibilità di cessazione (Nirvāṇa) e il percorso per raggiungerla (il Nobile Sentiero ad otto membra). Un concetto chiave è il sorgere condizionato (Pratītyasamutpāda), che descrive la catena di cause ed effetti che lega gli esseri all’ignoranza e alla sofferenza. La comunità dei discepoli (saṅgha) segue il Dharma. Diverse scuole si svilupparono in India, come il Mahāsāṅgha e il Sarvāstivāda, con dottrine distinte sull’Arhat, la natura del Buddha e l’esistenza dei fenomeni nel tempo. La scuola Pudgalavāda introdusse il concetto di individuo (pudgala). Il Theravāda, stabilitosi in Sri Lanka, si concentrò sull’ideale dell’Arhat e sul canone Pāli. La formazione del canone, organizzato in Vinaya, Sutta e Abhidhamma, avvenne gradualmente da tradizioni orali. Successivamente emerse il Mahāyāna, che enfatizza l’ideale del Bodhisattva che cerca l’illuminazione per tutti gli esseri, praticando le perfezioni (pāramitā). Nuovi testi (Sūtra) espongono concetti come la Vacuità (Śūnyatā), sviluppata filosoficamente da Nāgārjuna, e la dottrina della mente-soltanto (Vijñānavāda) con la coscienza deposito (Ālayavijñāna). Il Vajrayāna integrò elementi tantrici, mantra e rituali. Il buddhismo si diffuse in Tibet, interagendo con il Bonismo e stabilendosi con il supporto regale, portando alla fondazione di monasteri e alla traduzione di testi. Si distinsero tradizioni antiche e nuove scuole (bKa’-gdams, Sa-skya, bKa’-brgyud, dGe-lugs), con l’istituzione dei lama incarnati come il Dalai Lama. La dottrina tibetana integra diversi veicoli e include concetti come il bardo. In Cina, il buddhismo arrivò via terra e mare, confrontandosi con confucianesimo e taoismo. La distanza dall’India e le difficoltà di traduzione portarono a una sinicizzazione. Nonostante le tensioni con lo Stato riguardo all’autonomia del clero e le persecuzioni, il buddhismo si radicò, offrendo affinità con ideali cinesi e ricevendo patrocinio imperiale. Fiorirono scuole cinesi originali come Tiantai, Huayan e Chan, e la Terra Pura divenne popolare. Il saṅgha ebbe un ruolo sociale, ma subì crisi e persecuzioni, perdendo vitalità intellettuale con l’ascesa del neo-confucianesimo. In epoca moderna, il buddhismo cinese affrontò sfide politiche e sociali, sopravvivendo principalmente nelle forme Chan e Terra Pura, spesso fuse. Il buddhismo cinese fu un veicolo per la diffusione in Giappone, Corea e Vietnam. In Giappone, si affermò con il supporto della corte, integrandosi con lo shintoismo (shinbutsu-shūgō) e sviluppando scuole come Tendai e Shingon. Nel periodo Kamakura emersero nuove scuole focalizzate sulla fede in Amida (Terra Pura) o sulla meditazione (Zen), e la setta Nichiren. Nonostante conflitti e repressioni del potere militare dei monasteri, il buddhismo giapponese mantenne un legame con la popolazione e un rigoroso studio dottrinale. Il buddhismo Theravāda persistette in Sri Lanka e nel Sud-Est asiatico, mantenendo il canone Pāli ma evolvendo come religione di massa con pratiche popolari e integrazione di culti locali. La relazione tra saṅgha e Stato fu storicamente forte, con tentativi di riforma e crescente partecipazione politica dei monaci in alcuni paesi. In Indonesia, dopo una fase sincretica e l’ascesa dell’islam, si verificò una rinascita nel XX secolo. In Occidente, l’interesse per il buddhismo crebbe dal XVII secolo, inizialmente accademico e filosofico, poi con la formazione di società e le prime conversioni. I motivi erano vari, dall’interesse intellettuale ed etico per il Theravāda alla ricerca di elementi mistici. Dopo le guerre mondiali, l’attività riprese, specialmente negli Stati Uniti e in Europa. La pratica della meditazione divenne centrale, con la diffusione dello Zen, del Vipassana e del buddhismo tibetano, favorito dalla popolarità di maestri asiatici. Accanto ai buddhisti occidentali, esistono comunità asiatiche. Il buddhismo in Occidente si presenta vario, con una solida organizzazione e una capacità di adattarsi alle esigenze locali, promuovendo la partecipazione dei laici, il ruolo delle donne e l’impegno sociopolitico, segnando una nuova fase di dialogo e integrazione tra scuole.Riassunto Lungo
1. Il Sentiero Indiano Oltre la Religione
Applicare il concetto occidentale di “religione” alle tradizioni indiane, come il buddhismo e il jainismo, può creare confusione. Queste antiche correnti di pensiero si presentano piuttosto come vie per raggiungere la liberazione, basate sull’ascesi e sulla riflessione filosofica. Le pratiche rituali e devozionali che conosciamo si sono sviluppate in momenti successivi. L’attenzione non è posta su un Dio personale o su un “sé” immutabile destinato a sopravvivere. Al contrario, si sottolinea l’impegno che ogni individuo deve mettere per ottenere una conoscenza che liberi dalla sofferenza.Contesto Storico e la Figura del Buddha
Nel contesto dell’India antica, esistevano maestri asceti chiamati śramaṇa. Questi si distinguevano dai brāhmaṇa, che erano legati alla tradizione dei Veda. Gli śramaṇa proponevano diverse dottrine per superare il ciclo continuo delle rinascite, noto come karman. Il Buddha, anche chiamato śramaṇa Gautama, è una figura centrale tra questi maestri. Definire con precisione la sua vita storica è difficile a causa delle leggende che si sono formate nel tempo. È associato al clan degli Śākya, e le sue origini potrebbero essere state brahminiche, anche se la tradizione lo presenta come appartenente alla casta dei guerrieri, i kṣatriya.Le Dottrine Fondamentali
La dottrina principale attribuita al Buddha è esposta nelle Quattro Nobili Verità. La prima verità descrive il disagio che si prova nell’esistenza, il duḥkha, che si manifesta in molte forme, dalla nascita e dalla vecchiaia al dolore interiore e alla natura transitoria degli elementi che compongono una persona, gli skandha. La seconda verità identifica la causa di questo disagio nella “sete”, la tṛṣṇā, un desiderio che non si placa mai e che lega gli esseri al ciclo del cambiamento e della sofferenza. La terza verità afferma che è possibile porre fine al duḥkha spegnendo questa sete, raggiungendo così il Nirvāṇa. La quarta verità indica la strada per ottenere questa cessazione: è il Nobile Sentiero composto da otto aspetti, tra cui la retta comprensione, la retta intenzione, la retta parola, la retta azione, i retti mezzi di sussistenza, il retto sforzo, la retta attenzione e la retta concentrazione. Un altro concetto essenziale è il Pratītyasamutpāda, che significa “il sorgere dipendente”. Questa è una catena di dodici elementi, i nidāna, che spiega come l’ignoranza, avidyā, alimenti il ciclo di sofferenza e rinascite. Comprendere e superare l’ignoranza permette di spezzare questa catena e raggiungere la liberazione.La Comunità dei Discepoli
La comunità dei discepoli si chiama saṅgha. I suoi membri seguono il Dharma insegnato dal Maestro. L’ingresso in questa comunità avviene prendendo rifugio nel Buddha, nel Dharma e nel Saṅgha. La vita comunitaria è guidata dagli insegnamenti, ma la storia mostra anche episodi di dissenso e tentativi di scisma. Questo dimostra la dinamicità interna del gruppo.Confronto con Altre Tradizioni
Le scuole buddhiste, come il jainismo e gli ājīvika, condividono alcune nozioni importanti come il karman e la trasmigrazione. Tuttavia, differiscono in modo significativo nel modo in cui interpretano queste idee e nella via che propongono per la liberazione. Ad esempio, i jaina vedono il karman come una materia sottile che si attacca a un principio vitale, chiamato jīva. Gli ājīvika, invece, sostengono un determinismo cosmico, la niyati, che rende l’iniziativa umana quasi illusoria. Il buddhismo elabora un modello del karman meno materialistico e, soprattutto, nega l’esistenza di un sé permanente, distinguendosi nettamente dalle altre visioni.Il capitolo afferma che applicare il concetto occidentale di “religione” sia fonte di confusione, preferendo definire queste tradizioni “vie per raggiungere la liberazione”. Ma non si rischia così di ignorare o sminuire le dimensioni rituali e devozionali che, come il capitolo stesso ammette, si sono sviluppate e sono diventate centrali?
Questa prospettiva, pur utile per sottolineare l’aspetto filosofico e ascetico, potrebbe non rendere piena giustizia alla complessità storica e alla pratica vissuta di queste tradizioni, che per molti aspetti funzionano come religioni nel senso più ampio del termine. Per approfondire questo dibattito e comprendere meglio come le tradizioni indiane si inseriscano nel panorama degli studi comparati, è utile esplorare le diverse definizioni di “religione” e la storia delle pratiche devozionali. Si possono consultare opere di studiosi di storia delle religioni o di indologia, come Mircea Eliade o altri specialisti del buddhismo e del jainismo che analizzano anche gli aspetti rituali e sociali.2. Le Prime Vie del Dharma
Il re Ashoka Maurya diffonde un codice morale chiamato Dharma in tutto il suo vasto regno. Usa iscrizioni su pilastri e rocce per far conoscere questo codice, che si basa su principi fondamentali. Tra questi ci sono la non-violenza (ahiṃsā), il rispetto per tutti gli esseri viventi, la tolleranza tra diverse credenze religiose, l’obbedienza a genitori e maestri, la compassione verso gli altri e la moderazione nei comportamenti. Ashoka si impegna attivamente per promuovere queste virtù, viaggiando personalmente e inviando funzionari dedicati in diverse aree del regno. Egli stesso si presenta come un esempio di questi principi, decidendo di rinunciare alla guerra di conquista dopo aver assistito a un conflitto estremamente sanguinoso. Protegge attivamente la vita sia degli uomini che degli animali, dimostrando il suo impegno per la non-violenza. Inoltre, si dedica alla costruzione di infrastrutture utili per la popolazione, come ospedali per la cura dei malati e pozzi per l’approvvigionamento idrico. Ashoka si dichiara pubblicamente un seguace laico degli insegnamenti del Buddha e incoraggia lo studio approfondito di tali insegnamenti tra i suoi sudditi.La Nascita delle Scuole Buddiste
La diffusione degli insegnamenti del Dharma voluta da Ashoka porta alla fioritura e alla formazione di diverse scuole di pensiero all’interno del Buddismo. Queste scuole interpretano e sviluppano gli insegnamenti originali in modi leggermente diversi, dando origine a dibattiti e nuove dottrine. Tra queste scuole, il Mahāsāṅgha emerge come un gruppo particolarmente numeroso e influente.Le Idee del Mahāsāṅgha
La scuola Mahāsāṅgha propone alcune tesi innovative riguardo alla figura dell’Arhat, che è colui che ha raggiunto l’illuminazione secondo l’insegnamento tradizionale. Essi considerano l’Arhat ancora soggetto a certe limitazioni e imperfezioni umane, distanziandosi così da un’idea di perfezione assoluta e sovrumana per chi raggiunge questo stato. Inoltre, il Mahāsāṅgha sviluppa una visione più trascendente del Buddha. Secondo questa prospettiva, il Buddha è una realtà ultima che esiste al di là del mondo ordinario e appare nel mondo terreno solo temporaneamente per insegnare e guidare gli esseri. Introducono anche il concetto di una “mente radicale” o “mente fondamentale” (mūlavijñāna). Questa “mente radicale” è vista come uno strato più profondo della coscienza che garantisce la continuità dell’esperienza e dell’identità attraverso i vari stati mentali e le esistenze.La Dottrina del Sarvāstivāda
Un’altra scuola di pensiero di grande importanza che si sviluppa in questo periodo è il Sarvāstivāda. Questa scuola si distingue per una dottrina centrale che afferma l’esistenza reale di tutti i fenomeni (chiamati dharma) in tutti e tre i tempi: passato, presente e futuro. Questa posizione filosofica è supportata da argomenti logici complessi e dalla necessità di spiegare come gli eventi passati possano ancora influenzare il presente attraverso la causalità. Secondo il Sarvāstivāda, il tempo stesso, così come lo percepiamo, è in gran parte una convenzione. La realtà ultima è invece composta da eventi o “dharma” che esistono istantaneamente. Diverse teorie interne alla scuola cercano di spiegare esattamente come questi eventi istantanei si muovano attraverso i momenti temporali, con la dottrina della “condizione” o “posizione” (avasthāvāda) che diventa una delle spiegazioni più importanti. Il Sarvāstivāda pone un’enfasi molto forte sullo studio e sull’elaborazione dell’Abhidharma, che è la parte della letteratura buddista dedicata all’analisi filosofica e psicologica dei fenomeni.La Visione dei Sautrāntika
Dalla scuola Sarvāstivāda si separa in seguito un gruppo noto come Sautrāntika. Questi pensatori privilegiano l’autorità diretta dei Sūtra, i discorsi del Buddha, rispetto alle elaborazioni filosofiche dell’Abhidharma. I Sautrāntika sostengono una forma di istantaneismo più radicale rispetto ai Sarvāstivāda. Essi negano l’esistenza reale dei fenomeni nel passato e nel futuro, affermando che solo il presente istantaneo è reale. Propongono anche l’idea di una “mente sottile” o “seme della coscienza” (bīja) che è responsabile della continuità karmica e della memoria, offrendo un’alternativa alla “mente radicale” del Mahāsāṅgha e alla dottrina dell’esistenza dei dharma nei tre tempi del Sarvāstivāda.Come può esistere “realmente” il passato, se il Buddismo insegna l’impermanenza radicale?
Il capitolo presenta la dottrina Sarvāstivāda secondo cui i fenomeni esistono in tutti e tre i tempi, passato, presente e futuro. Questa tesi sembra in apparente contraddizione con l’insegnamento fondamentale dell’impermanenza (anicca) che vede ogni cosa sorgere e dissolversi istantaneamente. Per comprendere come questa scuola conciliasse queste posizioni e quali fossero i suoi “argomenti logici complessi”, è necessario approfondire lo studio dell’Abhidharma Sarvāstivāda e della filosofia buddista. Autori che hanno analizzato in dettaglio queste dottrine, come ad esempio K.L. Dhammajoti, possono offrire la prospettiva necessaria.3. Percorsi Dottrinali e la Nascita dei Testi Sacri
La scuola Pudgalavāda emerge con il concetto di pudgala, che significa l’individuo o la persona. Questa ‘persona’ sperimenta e passa da una vita all’altra. È diversa dagli skandha (gli elementi che compongono l’individuo secondo altre scuole), ma non può esistere senza di essi. Non è qualcosa che scompare velocemente (dharma perituro) e non si può definire facilmente. Questa idea si basa su ciò che si sperimenta e sulla realtà profonda. È un’idea diversa da quella di altre scuole. Da questa scuola nascono diversi gruppi, come i Sammatīya, che diventano molto importanti.La Tradizione Theravāda
La tradizione Theravāda si sviluppa da gruppi che seguono le dottrine più antiche. Questa tradizione si stabilisce soprattutto a Ceylon (oggi Sri Lanka), ricevendo un forte sostegno dai re. Così, la comunità dei monaci (saṅgha) diventa molto potente, sia per l’economia che per la cultura. Anche se a volte si uniscono credenze in divinità locali, la vera liberazione si ottiene solo seguendo l’insegnamento del Buddha.Il pensiero Theravāda analizza le cose in modo dettagliato ed è molto concreto. Non è d’accordo con le idee di altre scuole. La persona più importante è l’Arhat, che arriva a uno stato di perfezione che dura nel tempo. Per questa tradizione, il passato e il futuro non esistono veramente. Il Buddha è visto come un essere reale e straordinario, unico e che sa tutto.
La Nascita dei Testi Sacri (Il Canone Buddista)
La formazione dei testi sacri buddisti avviene piano piano, partendo dagli insegnamenti tramandati a voce (chiamati Aṅga) dai discepoli del Buddha. Riunioni importanti (concili) e l’interesse di re come Ashoka aiutano a mettere per iscritto questi insegnamenti. I testi vengono divisi in tre gruppi principali, chiamati Piṭaka: il Vinaya (regole per i monaci), i Sutta (i discorsi del Buddha) e l’Abhidhamma (spiegazioni più profonde della dottrina).Ogni scuola buddista crea la sua versione di questi testi. Quella della scuola Theravāda, scritta in lingua Pāli, è la raccolta più completa che abbiamo oggi tra quelle che non appartengono alla tradizione Mahāyāna. Le regole per i monaci (Vinaya) sono abbastanza simili tra le scuole, segno che c’è un nucleo di regole molto antico e comune. Invece, le spiegazioni più profonde (Abhidhamma) cambiano molto da una scuola all’altra, mostrando le differenze nelle loro idee.
Quanto del “Buddhismo in Occidente” descritto nel capitolo è una fedele trasmissione e quanto una reinterpretazione o creazione originale?
Il capitolo descrive l’evoluzione dell’interesse occidentale per il Buddhismo, culminando nella centralità della pratica meditativa. Tuttavia, non approfondisce se questo processo sia una semplice “adozione” o implichi profonde trasformazioni e adattamenti ai contesti culturali occidentali. Per esplorare questa lacuna, sarebbe utile studiare la sociologia della religione e la storia delle idee, confrontando le forme tradizionali del Buddhismo con quelle emerse in Occidente. Autori come Edward Said, Stephen Batchelor o David L. McMahan offrono prospettive critiche su come le culture si influenzano e reinterpretano a vicenda, e sulla specificità del Buddhismo “occidentale”.17. Un Nuovo Oriente in Occidente
L’espansione complessiva del buddhismo in Occidente, un fenomeno con una storia ormai ultracentenaria, ha subito un’accelerazione significativa a partire dagli anni Sessanta. Questa crescita è stata favorita da profondi cambiamenti sociopolitici che hanno reso le società occidentali più aperte alle tradizioni non cristiane. Allo stesso tempo, si è manifestato un rinnovato e diffuso interesse per la pratica religiosa e spirituale. In questo contesto, a partire dagli anni Ottanta, si è osservata una notevole diffusione del buddhismo tibetano, che ha seguito e in parte superato una precedente crescita dello Zen. Questo periodo ha segnato una nuova fase nella presenza buddhista in Europa, Nordamerica e Australia.L’Arrivo dei Maestri e la Diffusione
La diffusione del buddhismo tibetano è stata largamente favorita dalle visite di numerosi maestri, invitati dai primi discepoli occidentali che avevano viaggiato in Asia. I riti affascinanti, i simboli ricchi di significato e il carisma personale dei Lama hanno esercitato una forte attrattiva, in particolare tra i giovani e coloro che aderivano a culture alternative. Dalla metà degli anni Ottanta, le principali tradizioni tibetane si sono organizzate in modo stabile in Nordamerica, Europa e Australia, diventando spesso il gruppo buddhista più numeroso in queste aree. L’interesse per questa forma di buddhismo è stato notevolmente amplificato dalla crescente popolarità a livello mondiale del XIV Dalai Lama. In questo periodo, si è notata una preferenza per le scuole di meditazione tibetane e giapponesi, legata a una ricerca di elementi mistici e rituali in società percepite come eccessivamente razionali e prive di incanto.Le Diverse Tradizioni e la Formazione Occidentale
Negli anni Ottanta e Novanta, la crescita ha riguardato in modo significativo anche i gruppi legati allo Zen, al Theravada e quelli non affiliati a scuole specifiche. Il numero di centri e gruppi di pratica è aumentato notevolmente in molti paesi occidentali, concentrandosi soprattutto nelle grandi città e nelle aree economicamente più sviluppate. Parallelamente a questa espansione, è iniziata presto la formazione di maestri occidentali qualificati. L’introduzione di ritiri intensivi e percorsi di studio pluriennali ha garantito la presenza di figure autorevoli capaci di guidare le comunità locali. Questo processo di formazione ha permesso al buddhismo di mettere radici più profonde nel contesto occidentale.Comunità a Confronto
Accanto ai buddhisti di origine occidentale, esistono importanti comunità composte da immigrati e rifugiati provenienti da paesi asiatici come Vietnam, Cambogia, Laos e Tibet. Queste comunità, spesso più numerose dei gruppi occidentali, tendono a rimanere separate. La loro pratica del buddhismo è strettamente legata al mantenimento dell’identità culturale e i contatti con i gruppi occidentali sono limitati. Si delineano così due linee distinte e parallele nella ricezione e pratica del buddhismo in Occidente, con motivazioni e modalità spesso differenti.Il Volto del Buddhismo Occidentale
Negli anni Novanta, il panorama del buddhismo occidentale si presenta estremamente vario, con l’esistenza di numerose scuole, lignaggi e centri di pratica. Nonostante il numero di aderenti rappresenti ancora una piccola percentuale della popolazione totale, il buddhismo occidentale ha raggiunto una solida organizzazione interna. La sua espansione è stata facilitata dalla sua intrinseca diversità e dalla capacità di adattarsi a esigenze spirituali e culturali differenti. La presenza costante di maestri asiatici e l’enfasi sulla pratica quotidiana degli insegnamenti rimangono elementi cruciali per la sua vitalità. Nuove istituzioni, monasteri e comunità laiche continuano a sorgere sia in Nordamerica che in Europa, testimoniando una presenza in continua evoluzione.Nuove Interpretazioni e Dialoghi
Nel corso del XX secolo, il buddhismo ha progressivamente assunto il carattere di una religione universale, estendendo la sua presenza anche in America centrale e meridionale. In risposta alle caratteristiche delle società occidentali, si sono sviluppate nuove interpretazioni degli insegnamenti tradizionali. Queste nuove prospettive promuovono attivamente la partecipazione dei laici nella vita religiosa, rafforzano il ruolo delle donne all’interno delle comunità e incoraggiano un maggiore impegno sociopolitico basato sui principi buddhisti. La vicinanza e l’interazione tra le diverse tradizioni buddhiste presenti in Occidente favoriscono la collaborazione e portano a tentativi di integrazione tra scuole differenti. Il dialogo aperto con il pensiero occidentale e la ricerca di un’intesa tra le varie scuole segnano una fase nuova e dinamica nella lunga storia del buddhismo.Ma se il buddhismo occidentale è così “adattabile”, perché le comunità di immigrati restano separate?
Il capitolo, pur descrivendo un panorama variegato e in evoluzione, osserva una netta separazione tra i gruppi buddhisti di origine occidentale e quelli composti da immigrati, attribuendo la divisione principalmente alle esigenze di identità culturale di questi ultimi. Tuttavia, questa constatazione solleva interrogativi sulla reale capacità di “adattamento” del buddhismo nel contesto occidentale e sulla natura stessa di questo “nuovo Oriente”. Per comprendere meglio le dinamiche di questa separazione e le sue implicazioni per il futuro del buddhismo in Occidente, sarebbe utile approfondire gli studi sociologici sulle religioni e le migrazioni, esplorando le opere di autori che hanno analizzato i processi di integrazione culturale e religiosa nelle società multietniche.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]