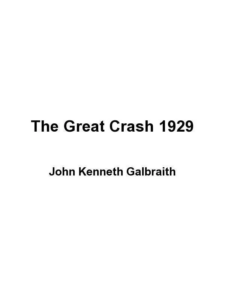1. L’Anatomia della Speculazione Finanziaria
Le economie di libero mercato sono soggette a ricorrenti speculazioni finanziarie. Questi episodi prendono piede quando un’idea o un oggetto, apparentemente nuovo e desiderabile, cattura l’attenzione degli investitori. I prezzi iniziano a salire, attirando l’interesse di nuovi acquirenti. L’ingresso di nuovi investitori spinge ulteriormente i prezzi verso l’alto, innescando un processo che si autoalimenta e crea un’ondata di entusiasmo crescente.I Partecipanti
I partecipanti a queste ondate speculative si possono dividere in due gruppi. Da una parte, coloro che credono in un aumento indefinito dei prezzi; dall’altra, coloro che confidano nella propria capacità di sfruttare l’onda speculativa, per poi ritirarsi prima del suo inevitabile crollo. In entrambi i casi, la psicologia di massa gioca un ruolo fondamentale. L’interesse personale nell’euforia speculativa è forte, e chi esprime dubbi viene spesso criticato. L’aumento della ricchezza, inoltre, porta i partecipanti a credere nella propria intuizione superiore, alimentando ulteriormente l’ottimismo.Il Crollo
Il crollo di una bolla speculativa è inevitabile e non avviene mai in modo graduale. Al contrario, quando si verifica, è rapido e disastroso. Entrambi i gruppi di partecipanti cercano di fuggire contemporaneamente, causando un collasso del mercato. Dopo il crollo, si tende a cercare un capro espiatorio, evitando di discutere la speculazione stessa o l’ottimismo irrazionale che l’ha alimentata. La fede nel mercato come entità neutrale, inoltre, impedisce di riconoscere la sua tendenza intrinseca all’errore.Fattori Aggravanti
La memoria finanziaria è notoriamente breve e i disastri del passato vengono presto dimenticati. Nuove generazioni di investitori, ignare della storia, tendono a considerare le vecchie pratiche speculative come innovazioni. Un altro fattore che contribuisce al ripetersi di questi episodi è la tendenza ad associare il denaro all’intelligenza. Si crede, erroneamente, che chi possiede più soldi sia anche più intelligente. Questa convinzione si estende anche ai leader delle grandi istituzioni finanziarie, che spesso occupano tali posizioni per ragioni burocratiche e non per reale acume finanziario. La deferenza verso chi detiene grandi capitali si trasforma in una presunzione di superiorità intellettuale, ostacolando qualsiasi forma di autocritica.Caratteristiche Ricorrenti
Nonostante la loro frequenza, le caratteristiche comuni di questi episodi speculativi non sono state analizzate a fondo. La regolamentazione e le conoscenze economiche tradizionali si rivelano spesso inefficaci nel proteggere individui e istituzioni finanziarie quando l’euforia prende il sopravvento. La vera protezione, in realtà, risiede nella comprensione delle dinamiche profonde che portano a questa “follia di massa”. In ogni episodio speculativo, infatti, si crede che ci sia qualcosa di nuovo. Che si tratti di tulipani, azioni o obbligazioni, l’innovazione finanziaria è spesso una semplice variazione di schemi già esistenti. La creazione di debito, garantito in modo variabile da beni reali, è una costante che si ripresenta regolarmente. La storia della speculazione, se compresa a fondo, può offrire una possibilità di avvertimento, anche se la forza dell’euforia finanziaria è spesso travolgente.Se la “memoria finanziaria” è così breve e la tendenza a credere che il denaro sia sinonimo di intelligenza è così forte, come possiamo pretendere che la comprensione razionale delle dinamiche speculative possa davvero proteggere dalla “follia di massa”? Non è forse una contraddizione in termini?
Il capitolo, pur delineando acutamente le dinamiche psicologiche e sociali che alimentano le bolle speculative, sembra cadere in un’ingenua speranza quando afferma che la “comprensione” può essere un’arma efficace contro l’euforia finanziaria. Ma se, come afferma, la memoria è labile e la deferenza verso il denaro è radicata, non è forse più realistico aspettarsi che la storia continui a ripetersi, nonostante la comprensione teorica del fenomeno? Per approfondire questo apparente paradosso, sarebbe utile esplorare le teorie sull’irrazionalità umana in campo economico, come quelle proposte dalla finanza comportamentale. Autori come Kahneman e Thaler, ad esempio, offrono spunti interessanti su come i bias cognitivi e le emozioni influenzino le decisioni finanziarie, anche in presenza di conoscenze razionali. Inoltre, un’analisi più approfondita del ruolo delle istituzioni e delle regolamentazioni, solo accennata nel capitolo, potrebbe fornire un quadro più completo delle possibili contromisure alla speculazione, al di là della semplice “comprensione” individuale.2. Bolle Speculative e Follia Collettiva
La natura delle bolle speculative
Le bolle speculative rappresentano un fenomeno ricorrente nella storia economica, caratterizzato da un aumento rapido e ingiustificato del prezzo di un bene, seguito da un crollo altrettanto repentino. Questo andamento è spesso alimentato da un’ondata di ottimismo irrazionale e dalla convinzione che i prezzi continueranno a salire all’infinito. La speculazione finanziaria, spesso basata su novità apparenti, può portare a bolle economiche.La Tulipomania olandese
Un esempio emblematico di bolla speculativa è la Tulipomania, che colpì l’Olanda nel XVII secolo. In quel periodo, i bulbi di tulipano divennero oggetto di un’intensa speculazione, raggiungendo prezzi esorbitanti, con bulbi singoli scambiati per cifre enormi, equivalenti al valore di una casa. La frenesia collettiva coinvolse persone di ogni ceto sociale, tutte convinte di poter ottenere facili guadagni. La bolla, tuttavia, era destinata a scoppiare: quando la fiducia venne meno, i prezzi crollarono rapidamente, lasciando molti investitori in rovina.Il sistema di John Law in Francia
Un altro caso significativo di bolla speculativa si verificò in Francia nel 1720, ad opera di John Law. Law, un economista scozzese, convinse il reggente Filippo II di Orléans ad adottare un sistema finanziario innovativo, basato sulla creazione di una banca centrale, la Banque Royale, e di una compagnia commerciale, la Compagnia del Mississippi. La banca emetteva banconote, mentre la compagnia ottenne il monopolio del commercio con la Louisiana, un territorio nordamericano allora considerato ricco di risorse. L’entusiasmo per le presunte ricchezze della Louisiana portò a una frenesia speculativa, con prezzi delle azioni in rapida ascesa. La situazione precipitò quando gli investitori iniziarono a dubitare del reale valore delle azioni e a richiedere la conversione delle banconote in oro. La mancanza di riserve auree sufficienti causò il crollo del sistema, portando alla rovina molti investitori e a una crisi economica.La Bolla dei Mari del Sud in Inghilterra
Nello stesso periodo, l’Inghilterra fu teatro di un’altra grande bolla speculativa, nota come la Bolla dei Mari del Sud. La Compagnia dei Mari del Sud, fondata nel 1711, ottenne il monopolio del commercio con le colonie spagnole in America. La compagnia ottenne il monopolio del commercio con le colonie spagnole in America, e per finanziare le sue attività, la compagnia emise azioni che divennero oggetto di un’intensa speculazione. L’emissione di azioni per coprire il debito pubblico generò un’ondata speculativa, con prezzi che salirono vertiginosamente. Sull’onda dell’entusiasmo, nacquero numerose altre compagnie, spesso prive di un reale scopo commerciale, che contribuirono ad alimentare la bolla. Il crollo, inevitabile, si verificò nel 1720, quando la fiducia degli investitori venne meno e i prezzi delle azioni precipitarono.Conseguenze e considerazioni
Le bolle speculative, pur manifestandosi in forme diverse, seguono dinamiche simili: un’iniziale euforia, alimentata da aspettative di guadagni facili e rapidi, un picco insostenibile dei prezzi e un crollo repentino, che lascia dietro di sé rovina e disordine economico. La storia delle bolle speculative dimostra come la psicologia umana, con la sua tendenza all’irrazionalità e al conformismo, giochi un ruolo fondamentale in questi fenomeni. In tutti questi casi, la tendenza è quella di cercare capri espiatori, piuttosto che riconoscere la follia collettiva che ha alimentato la speculazione.Se le bolle speculative sono caratterizzate da un’ondata di ottimismo irrazionale, come mai gli investitori, anche i più esperti, continuano a cadere nella trappola della speculazione, nonostante la storia ci insegni che queste bolle sono destinate a scoppiare?
Il capitolo, pur descrivendo accuratamente il fenomeno delle bolle speculative e riportando esempi storici significativi, non approfondisce a sufficienza le motivazioni psicologiche e comportamentali che spingono gli investitori a partecipare a tali fenomeni, anche quando sono consapevoli dei rischi. Per comprendere appieno le dinamiche delle bolle speculative, sarebbe utile approfondire gli studi di economia comportamentale e di psicologia cognitiva, con particolare riferimento ai bias cognitivi come l’effetto gregge, l’eccesso di fiducia e l’avversione alle perdite. Autori come Daniel Kahneman e Robert Shiller possono fornire spunti interessanti in questo ambito.3. La Storia della Speculazione Finanziaria Americana
La storia finanziaria americana è caratterizzata da una serie di cicli speculativi che si ripetono con regolarità. Questi cicli iniziano con un periodo di ottimismo e innovazione finanziaria, spesso alimentato dalla creazione di denaro tramite carta moneta e dall’uso della leva finanziaria. L’ottimismo porta a un aumento dei prezzi, che a sua volta attrae nuovi investitori, creando una bolla speculativa.Le Prime Speculazioni
Il primo esempio di questo fenomeno si verifica già nelle colonie, con l’emissione di carta moneta garantita da beni come il tabacco. Successivamente, la tendenza alla speculazione si manifesta con la creazione di banche statali che emettono banconote senza un’adeguata copertura in metallo prezioso. Questo porta a periodi di boom seguiti da crolli, con conseguenti panici finanziari e depressioni economiche.Speculazioni nel XIX Secolo
Nel corso del XIX secolo, la speculazione si concentra su settori come i canali, le ferrovie e la terra, spesso finanziati da prestiti esteri. Ogni boom è seguito da un crollo, con la tendenza a dare la colpa a fattori esterni, come le politiche monetarie o eventi naturali, piuttosto che alla speculazione stessa.Il Crollo del 1929
Il culmine di questa tendenza si raggiunge con la bolla speculativa del 1920, che porta al crollo di Wall Street del 1929. In questo periodo, la leva finanziaria raggiunge livelli estremi, con la creazione di società che investono in altre società, amplificando i guadagni e le perdite. Figure di spicco del mondo finanziario e accademico promuovono l’idea che i prezzi delle azioni siano destinati a salire indefinitamente. Dopo il crollo, si cerca di dare la colpa a fattori esterni, ma vengono anche introdotte alcune misure di controllo, come la creazione della Securities and Exchange Commission. Tuttavia, la tendenza alla speculazione non viene eliminata, e si ripresenta in futuro. Il crollo del 1929, però, lascia un segno nella memoria finanziaria, portando a un periodo di relativa calma nei mercati per circa un quarto di secolo.Se la speculazione finanziaria è un fenomeno così ricorrente e dannoso, perché non sono state adottate misure più efficaci per prevenirla, oltre alla creazione della Securities and Exchange Commission dopo il crollo del 1929?
Il capitolo descrive la storia della speculazione finanziaria americana come un ciclo che si ripete, con conseguenze negative come panici finanziari e depressioni economiche. Tuttavia, sembra che le misure adottate per controllare questo fenomeno siano state insufficienti, visto che la tendenza alla speculazione non è stata eliminata e si è ripresentata in futuro. Questo solleva la questione dell’efficacia delle regolamentazioni finanziarie e della volontà politica di affrontare le cause profonde della speculazione. Per approfondire l’argomento, potrebbe essere utile esplorare le discipline dell’economia comportamentale e della psicologia dei mercati finanziari, per comprendere meglio i fattori umani che contribuiscono alla formazione delle bolle speculative. Inoltre, per un’analisi più approfondita delle dinamiche politiche ed economiche che influenzano la regolamentazione finanziaria, si potrebbero consultare autori come Hyman Minsky, per le sue teorie sull’instabilità finanziaria, e Charles P. Kindleberger, per i suoi studi sulle crisi finanziarie.4. La Ricorrenza della Follia Finanziaria
La memoria finanziaria è breve, con una durata massima di circa vent’anni. Questo è il tempo che intercorre tra un disastro finanziario e il successivo, durante il quale il ricordo del disastro precedente svanisce e una nuova forma di euforia finanziaria prende piede. In questo contesto, una nuova generazione di operatori finanziari, convinta della propria genialità, cade preda di due pericolose illusioni: la prima è che la ricchezza sia il risultato di abilità finanziarie superiori, la seconda è che chi possiede grandi ricchezze sia dotato di un’intelligenza eccezionale. Queste illusioni nascondono la realtà dell’autoinganno e dell’illusione collettiva, che sono alla base di molti disastri finanziari.Eventi Memorabili e Periodi di Cautela
Nonostante la regolarità di questo ciclo di euforia e crollo, alcuni eventi rimangono impressi nella memoria collettiva per un periodo più lungo, portando a fasi di maggiore cautela. Un esempio lampante è il crollo del 1929, che causò la Grande Depressione, un periodo caratterizzato da un drastico calo della domanda, una profonda sfiducia nel sistema finanziario e numerosi fallimenti aziendali. Tuttavia, negli anni ’50, l’atteggiamento verso il mercato azionario iniziò a cambiare, aprendo la strada a nuove ondate speculative.Esempi di Follia Finanziaria
Negli anni ’60, molti operatori di mercato si convinsero di essere innovativi e immuni ai rischi, ma subirono comunque delle correzioni. Un esempio emblematico di questo periodo fu l’IOS, un’organizzazione di fondi comuni con una struttura di vendita piramidale, che riuscì a raccogliere miliardi di dollari da investitori ignari. Anche le grandi banche internazionali caddero in questo errore, prestando ingenti somme di denaro a paesi che poi si rivelarono incapaci di ripagare i debiti. Il crollo del 1987 seguì uno schema simile, con nuove generazioni di speculatori e l’utilizzo di strumenti finanziari sempre più rischiosi. La risposta a questo crollo fu quella di attribuire la colpa a fattori esterni, come il deficit di bilancio, ignorando la speculazione come causa principale. Gli studi successivi si concentrarono su dettagli tecnici, trascurando le cause profonde del problema.La Follia Finanziaria è Universale
La follia finanziaria non è un fenomeno limitato a un singolo paese o a un particolare periodo storico. Anche in Giappone e in Canada si verificarono crolli finanziari, con operatori che si credevano invulnerabili e banche che finanziavano operazioni sempre più rischiose. Questi esempi dimostrano che la follia finanziaria è un fenomeno ricorrente e universale, che non conosce confini geografici.Lezioni e Considerazioni Finali
L’attrazione per la ricchezza facile e l’illusione di un’intelligenza superiore legata al possesso di denaro portano inevitabilmente a speculazioni e crolli. I mercati finanziari non sono perfetti e le crisi sono una componente intrinseca del sistema. Non si può fare molto per impedire questi cicli, se non sviluppare un sano scetticismo e non associare l’intelligenza al denaro. Quando l’ottimismo sui mercati è eccessivo, è il momento di essere cauti. La storia si ripete e ci saranno sempre nuove ondate speculative, alimentate dall’illusione e dall’avidità.Se la “memoria finanziaria” dura al massimo vent’anni, come mai il crollo del 1929 ha avuto un impatto così duraturo, influenzando il mercato fino agli anni ’50, ben oltre il limite temporale proposto?
Il capitolo afferma che la memoria finanziaria ha una durata massima di circa vent’anni, eppure cita il crollo del 1929 come un evento memorabile che ha influenzato il mercato fino agli anni ’50, un periodo chiaramente superiore ai vent’anni. Questa apparente contraddizione necessita di un chiarimento. Per comprendere meglio le dinamiche dei cicli finanziari e la psicologia degli investitori, sarebbe utile approfondire discipline come la psicologia comportamentale e la storia economica. Un autore di riferimento per questi temi è Robert Shiller, che ha studiato a fondo le bolle speculative e l’irrazionalità dei mercati. Inoltre, per contestualizzare meglio il crollo del 1929 e la Grande Depressione, si potrebbero analizzare le opere di storici economici come Charles P. Kindleberger e Liaquat Ahamed.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]