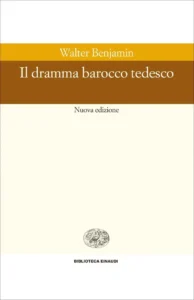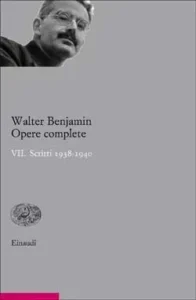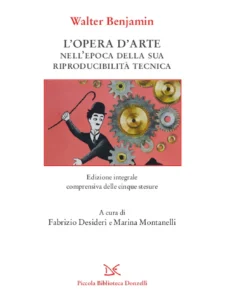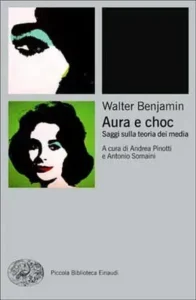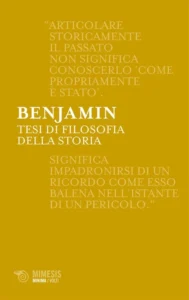Contenuti del libro
Informazioni
“Bambini, abbecedari, giocattoli” di Walter Benjamin non è solo un saggio, è un viaggio affascinante nella storia di come i bambini imparano e giocano, visto attraverso gli occhi di un pensatore incredibile. Il libro esplora il mondo dei libri per l’infanzia, partendo dagli abbecedari antichi e dalla nascita dell’illustrazione per bambini, notando come l’uso del colore nei libri abbia creato mondi di fantasia. Benjamin ci porta a scoprire la pedagogia del gioco, confrontando i vecchi metodi rigidi con l’apprendimento ludico che sfrutta la naturale inclinazione dei bambini a giocare, anche con lettere e numeri. Poi si immerge nella storia del giocattolo, analizzando giocattoli antichi di legno o carta, la loro produzione in luoghi come la Germania o la Russia, e il loro profondo significato del gioco e il rapporto adulto bambino che vi si riflette. Non dimentica il teatro dei burattini, con figure iconiche come Kasperle, mostrando come questi “dèi di legno” abbiano sempre sfidato le convenzioni. È un libro che ti fa guardare con occhi diversi gli oggetti della tua infanzia, capendo quanto la storia, l’economia e la visione degli adulti abbiano plasmato il mondo percettivo e ludico dei bambini attraverso i secoli.Riassunto Breve
La storia dei libri per bambini mostra un passaggio da testi didattici e moralistici, visti come aridi, a opere dove l’illustrazione diventa sempre più importante. Dalla fine del Settecento, e in particolare nel periodo Biedermeier con la calcografia colorata, il colore nelle illustrazioni crea mondi di fantasia autonomi. Le illustrazioni in bianco e nero, invece, stimolano l’interazione attiva del bambino, invitandolo a descrivere o persino a scarabocchiare, facilitando l’apprendimento del linguaggio e della scrittura. Formati interattivi, come libri con figure animate, sottolineano ulteriormente il ruolo attivo del bambino nella lettura. La letteratura per l’infanzia più recente, dalla fine dell’Ottocento, è vista come meno riuscita, avendo perso autenticità e contenuto etico, a favore di rappresentazioni artificiose. L’apprendimento dell’alfabeto ha visto evoluzioni simili. Inizialmente si decoravano le lettere pensando di facilitare, ma si capì che le decorazioni non aiutavano. Si provò ad associare lettere a oggetti, ma l’Illuminismo spostò il focus sull’idea che le lettere nascono dalle cose stesse. Vecchi abbecedari usavano sequenze fonetiche difficili. Ci furono tentativi di rendere i sillabari più divertenti con giochi. Un approccio moderno combina sillabario e quaderno di scrittura, sfruttando l’inclinazione del bambino a scarabocchiare e colorare, legando disegno e scrittura. La grafologia suggerisce che le lettere derivano da figure. Un principio educativo moderno vede l’apprendimento come un’avventura e il gioco come centrale, anche se l’idea di imparare “con l’inganno” solleva dubbi. Questo approccio si estende anche all’aritmetica, dove l’apprendimento è visto come un’avventura ludica. Il libro diventa un’enciclopedia interattiva, con attività giocose come completare disegni o inventare storie per le operazioni matematiche. Si cerca di proteggere la “sovranità” del bambino nel gioco, rendendo lettere e numeri meno spaventosi. L’esagerazione è usata come strumento pedagogico per divertire e aumentare il fascino di lettere e cifre. I vecchi sillabari rappresentavano un ingresso in un mondo di legge, mentre il gioco con le lettere oggi riflette forse l’incertezza attuale. La nostalgia per i vecchi alfabetari è legata al gesto fisico dell’apprendimento, un legame irripetibile con l’infanzia. Il mondo del gioco e dei giocattoli è profondamente influenzato dagli adulti e dal contesto sociale. I giocattoli sono dati al bambino dall’adulto e molti derivano da elementi culturali adulti. L’idea che i bisogni del bambino determinino il giocattolo è errata; storicamente, le bambole riflettevano l’immagine adulta. La “semplicità” di un giocattolo è spesso legata alla trasparenza del processo produttivo e ai materiali artigianali come il legno. La storia del giocattolo è legata alla cultura economica e tecnica. Il gioco ha una legge centrale: la ripetizione, che trasforma l’esperienza in abitudine. I giocattoli sono cambiati nel formato e nei materiali con l’industrializzazione. Non sono solo prodotto della mentalità infantile, ma un dialogo con la società. Giocattoli più semplici e meno imitativi sono spesso più autentici. Le esposizioni di giocattoli mostrano pezzi borghesi e offrono uno spaccato della vita dell’epoca. La figura del commerciante di giocattoli è relativamente recente. Esistevano giocattoli di zucchero, teatri di marionette e dispositivi ottici. I giocattoli antichi interessano diverse discipline e l’interesse adulto per il gioco è visto come una liberazione dalla realtà. La produzione moderna a volte riflette la visione adulta, non quella del bambino. Alcuni riconoscono gli aspetti meno innocenti dell’infanzia, suggerendo di non nascondere la complessità umana, che il bambino elabora attraverso il gioco. Le modifiche più importanti ai giocattoli avvengono tramite il gioco del bambino stesso. I giocattoli nascono dall’industria domestica e dall’artigianato. Tedeschi e russi mostrano un particolare talento per i giocattoli popolari. L’analisi di libri sui giocattoli a volte privilegia la produzione artistica su quella popolare e manca di profondità sul significato del gioco. Il rapporto con il giocattolo può essere passionale o meramente catalogatorio. I giocattoli possiedono un potenziale allegorico. I reparti giocattoli dei grandi magazzini mostrano una vasta gamma, inclusi giochi antichi e nuovi, e giocattoli di carta. La produzione di giocattoli è passata dall’artigianato limitato a una produzione diffusa, come i “giocattoli di Norimberga” nati dal lavoro contadino. Esistono giocattoli che racchiudono mondi minuscoli, evocando l’idea di un “paesino delle meraviglie”. L’osservazione di molti giocattoli può portare a una gioia indipendente dal possesso. Il teatro dei burattini ha attraversato diverse fasi, con figure come Kasperle che rimangono legate ai bambini. I burattini si sono rivelati uno strumento teatrale efficace e vantaggioso, essendo economici e non protestando. Un burattinaio esperto riesce a dare grande espressività alle figure di legno. I burattini hanno una leggerezza unica e la capacità di prendersi gioco dell’autorità, causando a volte ostilità. I grandi burattinai tramandano la loro arte oralmente. Esistevano anche teatri meccanici che mostravano scene in movimento.Riassunto Lungo
1. L’Anima Colorata dei Libri Dimenticati
Lo studio dei libri per l’infanzia si basa sull’analisi di una vasta raccolta di opere antiche. La storia di questi libri inizia con testi pensati soprattutto per insegnare e impartire principi morali. Questi primi volumi, influenzati dalle idee dell’Illuminismo, erano spesso percepiti come poco interessanti per i bambini a causa del loro approccio molto didattico. Allo stesso tempo, già dalla fine del Settecento, le illustrazioni iniziarono a guadagnare sempre più importanza, affiancando il testo scritto e iniziando a cambiare il volto dei libri per i più piccoli.L’esplosione del colore
Un cambiamento significativo si verificò nel periodo Biedermeier, tra gli anni Venti e Trenta dell’Ottocento. In questa fase, l’uso del colore nelle illustrazioni divenne fondamentale, grazie a tecniche come la calcografia colorata. Questi colori vivaci non erano solo un abbellimento, ma creavano un mondo a sé stante all’interno del libro, un luogo di fantasia e sogno capace di catturare l’immaginazione del bambino. Successivamente, dagli anni Quaranta agli anni Sessanta dello stesso secolo, la tecnica della litografia si diffuse ampiamente, portando alla ribalta nuovi illustratori che contribuirono a definire l’estetica dei libri per l’infanzia di quel tempo.Il ruolo del bianco e nero e l’interazione
Le illustrazioni in bianco e nero, spesso realizzate con la tecnica della silografia, avevano un impatto diverso rispetto a quelle a colori. Mentre il colore invitava il bambino a immergersi in un mondo fantastico e onirico, le immagini in bianco e nero, con la loro maggiore sobrietà, stimolavano il bambino a un’interazione più diretta e attiva. Queste illustrazioni incoraggiavano il bambino a descrivere a parole ciò che vedeva e lo spingevano quasi a “scrivere” sulle immagini stesse, magari anche solo con scarabocchi. Questo tipo di interazione facilitava l’apprendimento del linguaggio e un approccio quasi “geroglifico” alla comprensione e all’espressione.Libri che invitano all’azione
L’importanza dell’attività manuale e cognitiva del bambino durante la lettura è ulteriormente dimostrata dall’esistenza di formati interattivi. Libri con figure che si muovono o volumi pieni di rebus non erano semplici strumenti per l’insegnamento. Erano concepiti come veri e propri mondi con cui il bambino poteva interagire attivamente, manipolando le pagine e le immagini. Attraverso questa interazione diretta, il bambino non era un semplice spettatore, ma partecipava attivamente alla creazione del significato del libro, trasformando la lettura in un’esperienza dinamica e personale.La letteratura per l’infanzia prodotta nell’ultimo quarto del XIX secolo è spesso considerata meno riuscita rispetto alle opere precedenti. Secondo questa visione, i libri più recenti avrebbero perso parte del loro contenuto etico profondo e della loro autenticità. Si sarebbero orientati maggiormente verso la ricerca del favore del pubblico moderno, finendo per offrire rappresentazioni dell’infanzia percepite come artificiose. Il fascino duraturo dei libri più vecchi risiederebbe invece proprio nella loro capacità di coinvolgere il bambino in modo genuino, soprattutto attraverso la potenza evocativa delle immagini e dei colori, spesso riuscendo a stimolare la fantasia in modi che andavano oltre le intenzioni della pedagogia più rigida e razionalista dell’epoca.
Su quali basi si afferma che la letteratura per l’infanzia della fine del XIX secolo fosse “meno riuscita” e “artificiosa” rispetto alle opere precedenti?
Il capitolo esprime un giudizio netto sulla qualità della letteratura per l’infanzia prodotta nell’ultimo quarto del XIX secolo, definendola ‘meno riuscita’ e ‘artificiosa’ rispetto alle opere precedenti. Tuttavia, non specifica i criteri su cui si basa tale valutazione, che appare fortemente soggettiva e potenzialmente controversa. Per comprendere meglio questa affermazione e formarsi un’opinione più completa, sarebbe utile approfondire la storia della critica letteraria per l’infanzia e studiare le diverse correnti di pensiero che hanno analizzato quel periodo. Approfondire autori che si sono occupati di storia della letteratura per ragazzi o di storia dell’editoria può fornire prospettive alternative e contestualizzare meglio i cambiamenti stilistici e tematici di fine Ottocento.2. L’alfabeto si fa gioco
I primi modi di insegnare l’alfabeto
Le lettere dell’alfabeto hanno ricevuto da sempre grande cura ornamentale, con l’idea iniziale che decorarle potesse facilitare l’apprendimento nei bambini. Tuttavia, si comprese più avanti che le decorazioni non erano di aiuto. Inizialmente, le lettere venivano associate a oggetti, come la C con un cappello o la T con un topo. Nei vecchi abbecedari del XVI e XVII secolo si usavano sequenze fonetiche difficili, come “Chichleuchlauchra”, che apparivano come stranezze imposte dagli adulti ai bambini, senza considerare che imparare a leggere richiede anche un po’ di intuizione. Ci furono tentativi antichi di rendere i sillabari più divertenti, usando giochi come lotterie o dadi con lettere.Il cambiamento e il legame tra disegno e scrittura
Con l’Illuminismo e l’umanesimo, i libri di lettura iniziano a cambiare. Gli oggetti illustrati, che prima erano solo marginali, diventano elementi centrali. Si fa strada l’idea che lo spirito delle lettere nasca dalle cose stesse, e non il contrario. Esiste un legame profondo tra disegno e scrittura, suggerito anche dalla grafologia, che ipotizza che le lettere derivino da figure, come la P che rappresentava un uomo o la O un occhio. I sillabari del XVII secolo esplorarono questa idea di “biomorfismo”, rappresentando le lettere con forme naturali o oggetti, a volte in modo un po’ forzato.Approcci moderni e nuove domande
Un approccio più recente all’insegnamento combina il sillabario con un quaderno di scrittura, sfruttando le inclinazioni naturali del bambino per l’apprendimento. Lo spazio limitato per scrivere incoraggia il bambino a superare i confini del libro. Questo tipo di libro incorpora elementi del mondo infantile come colorare, gare e disegni, sfruttando la tendenza dei bambini a scarabocchiare e chiedendo loro di colorare lettere specifiche all’interno di una storia. Un sillabario moderno presenta oggetti disegnati con tratti che evidenziano la forma della lettera in rosso, evitando così i vecchi giochi fonetici. L’inclusione di nomi di paesi europei in un sillabario destinato a bambini piccoli solleva interrogativi su possibili interferenze con i programmi scolastici tradizionali e su come i bambini imparano parole che si riferiscono a concetti lontani dalla loro esperienza quotidiana.Imparare giocando: la pedagogia moderna
Un principio educativo moderno considera l’apprendimento per il bambino come un’avventura, non solo l’acquisizione di un compito. La vecchia scuola, che imponeva obiettivi rigidi, bloccava quello che viene definito “sapere reale”, che si manifesta invece nell’esercizio inconscio attraverso il gioco. Questo approccio, influenzato dalla psicologia, vede il gioco come elemento centrale nel processo educativo. Tuttavia, l’idea di imparare “con l’inganno” solleva dubbi sulla fragilità e il disorientamento che una tale libertà potrebbe creare nel bambino. Questa pedagogia radicale sembra nascere più dal crollo dell’autorità tradizionale che da un reale progresso scientifico nell’ambito dell’apprendimento. L’efficacia dell’insegnamento collettivo senza una figura di autorità forte viene messa in discussione, mentre il successo di questo tipo di sillabario sembra basarsi piuttosto sul gioco individuale.Ma la critica alla pedagogia moderna si basa su evidenze scientifiche o è solo nostalgia per l’autorità perduta?
Il capitolo solleva perplessità sull’approccio ludico all’apprendimento, arrivando a suggerire che derivi più da un “crollo dell’autorità tradizionale” che da un reale progresso scientifico. Questa affermazione, piuttosto forte, manca di un confronto approfondito con le basi teoriche che sostengono tali metodi. Per valutare la validità di queste pedagogie, è indispensabile esplorare la psicologia dell’educazione e le neuroscienze cognitive. Approfondire il pensiero di autori come Maria Montessori o Jerome Bruner, che hanno posto l’accento sul ruolo attivo del bambino e sull’apprendimento per scoperta, fornirebbe il contesto necessario per superare una visione riduttiva del dibattito.3. L’avventura del gioco nell’apprendimento
Un nuovo modo di insegnare lettura e aritmetica si basa sulla voglia naturale dei bambini di giocare. Imparare diventa una grande avventura, diversa dal modo in cui gli adulti affrontano i compiti. Questo metodo unisce strettamente scrittura e disegno e trasforma il libro in una sorta di enciclopedia per dare sicurezza ai piccoli. Le idee vengono presentate un po’ alla volta, partendo da cose semplici per arrivare a mondi più complessi come foglie, alberi, pesci e negozi. Si propongono attività divertenti come firmare disegni, completare storie, disegnare quello che manca, o aggiungere i versi degli animali. Si impara anche a mettere le cose in ordine, per esempio mettendo oggetti in caselle in base alla prima lettera o al tipo.Il bambino al centro
Il bambino si sente padrone di quello che impara, un po’ come un cavaliere sul suo cavallo, e il disegno lo aiuta a gestire lettere e parole. Anche con i numeri si usa un sistema giocoso, che dà al bambino un senso di controllo, per esempio colorando le cifre finali di una somma. Lo scopo è proteggere la libertà del bambino nel gioco, evitando che le prime lettere o i primi numeri facciano paura. A differenza dei vecchi problemi di aritmetica, che erano freddi e lontani dalle storie che piacciono ai bambini, questi libri invitano a inventare racconti per le operazioni matematiche. È importante includere la spontaneità del bambino, lasciandolo giocare con quello che impara, anche se “storpia” le parole. Ci sono spazi bianchi per disegnare e fare scarabocchi. Attività organizzate, come colorare lettere precise in una storia, portano a giochi come la “ginnastica alfabetica” e a “travestire” le lettere.Il valore del gioco e il confronto con il passato
Si usa l’esagerazione come strumento per insegnare, presentando finzioni così chiare da essere divertenti o da mettere in guardia, un po’ come si fa nelle grandi storie per bambini di una volta. Questa esagerazione giocosa fa sembrare lettere e numeri più importanti e affascinanti agli occhi dei bambini. I vecchi libri per imparare a leggere, con la loro serietà e rigidità, sembravano l’ingresso in un mondo di regole fisse. Imparare le lettere in quei libri significava accettare quelle regole con sicurezza. Forse, nel mondo di oggi, pieno di incertezze, è più utile giocare con le lettere, un gioco che incuriosisce e allo stesso tempo toglie un po’ di quella vecchia rigidità.Il ricordo delle prime lettere
Ricordare con affetto l’alfabetario dell’infanzia, con le lettere singole su piccole tavolette, è come cercare di ritrovare un pezzo della propria infanzia. Questo ricordo è legato al gesto fisico di formare le parole con le mani o con la matita. Quel modo di imparare, come imparare a camminare, appartiene a un tempo che è passato e non può tornare. Simboleggia un legame speciale e unico con le prime scoperte dell’apprendimento, una connessione che resta nella memoria ma non si può rivivere.Ma se il capitolo riconosce la mancanza di attenzione al ‘cosa significa giocare davvero’ e al ‘legame affettivo’, perché poi si perde in un elenco di oggetti e storie senza approfondire proprio l’esperienza umana del giocattolo?
Il capitolo, pur riconoscendo esplicitamente la necessità di andare oltre la mera catalogazione per esplorare il significato profondo del gioco e il legame affettivo con l’oggetto, sembra poi non colmare questa lacuna. Si concentra sulla storia della produzione, sui tipi di giocattoli e su riferimenti letterari, ma l’esperienza vissuta del bambino (o dell’adulto) che gioca, il desiderio, la creazione di mondi interiori attraverso l’oggetto rimangono in gran parte inesplorati. Per comprendere veramente il “mondo dei giocattoli” nella sua interezza, non basta descrivere gli oggetti o la loro provenienza; è fondamentale indagare la dimensione psicologica e sociale del gioco stesso. Approfondire discipline come la psicologia dello sviluppo, la sociologia o l’antropologia, e leggere autori che hanno esplorato il rapporto tra l’uomo e l’oggetto ludico, come Winnicott o Bachelard, potrebbe offrire gli strumenti concettuali per andare oltre la superficie e cogliere la vera “meraviglia” di cui il capitolo parla.7. Burattini: Dèi di legno e ribelli immortali
Il teatro dei burattini ha attraversato diverse epoche, evolvendosi da semplice intrattenimento per il popolo a una vera forma d’arte apprezzata anche dagli adulti. Con il tempo, la figura di Kasperle è rimasta più legata al mondo dei bambini.Gli spettacoli a Berlino e la figura di Kasperle
A Berlino, in passato, gli spettacoli natalizi erano un appuntamento importante, spesso allestiti in pasticcerie o grandi sale. Arlecchino, conosciuto anche come Kasperle, è una figura centrale, capace di inserirsi in qualsiasi storia, anche le più serie, senza mai subirne le conseguenze. Le locandine dell’epoca annunciavano gli spettacoli con titoli che catturavano l’attenzione, e il pubblico, perfino i più giovani, partecipava in modo informale, con persone che fumavano e bevevano birra durante la rappresentazione.Le origini e i vantaggi del teatro di figura
Le origini del teatro dei burattini in Germania sono strettamente legate al periodo successivo alla Guerra dei Trent’anni. L’insicurezza delle strade rendeva rischioso viaggiare per le compagnie di attori umani. In questo contesto, i burattini si dimostrarono uno strumento teatrale estremamente efficace e conveniente: erano economici da realizzare, non richiedevano vitto né compenso e, soprattutto, non protestavano mai.Il ruolo del burattinaio
Il burattinaio è un artista completo: scrive i testi, dipinge e scolpisce le figure, e dà voce a una moltitudine di personaggi diversi. È come un creatore assoluto, quasi un despota nel suo piccolo mondo. Tuttavia, per dare vita vera ai burattini, deve anche saper entrare in sintonia con loro, quasi concedendo loro una propria ‘volontà’ o un’anima. Nonostante la testa grande e rigida delle figure, un burattinaio esperto riesce a farle esprimere con grande capacità mimetica.La natura dei burattini e le loro sfide
I burattini possiedono una leggerezza quasi eterea, non essendo vincolati dalle leggi di gravità come gli attori in carne e ossa. Questa loro natura, unita alla facilità con cui possono prendersi gioco di qualsiasi cosa, comprese le autorità e le figure potenti, ha spesso generato ostilità nei loro confronti. Per questo motivo, hanno subito persecuzioni e si sono trovati a competere duramente con i teatri tradizionali.Tradizione e innovazione nell’arte dei burattini
I grandi burattinai sono figure dedite alla loro arte per tutta la vita. Spesso tramandano il loro sapere oralmente, quasi come membri di una società segreta che custodisce antichi trucchi del mestiere. Alcuni maestri, come Schwiegerling, hanno portato innovazioni straordinarie, creando burattini capaci di trasformarsi e mettendo in scena effetti che sembravano vera magia.Altre forme di spettacolo e l’approccio al pubblico
A Berlino esisteva anche il “theatrum mundi”, un tipo di teatro meccanico. Questo spettacolo continuo mostrava scene di vita quotidiana in movimento ed è considerato un antenato del cinema. C’erano anche rappresentazioni di eventi storici o racconti biblici. Le introduzioni agli spettacoli di burattini erano spesso molto vivaci e dirette, pensate per catturare immediatamente l’attenzione del pubblico.È sufficiente l’insicurezza post-bellica a spiegare l’affermazione del teatro di figura in Germania?
Il capitolo presenta la Guerra dei Trent’anni come causa quasi unica e determinante per la diffusione dei burattini, suggerendo che la semplice necessità di strumenti teatrali economici e non protestatari abbia guidato l’evoluzione artistica. Questa visione rischia di semplificare eccessivamente un fenomeno culturale complesso. Per comprendere appieno le origini e il successo del teatro di figura, sarebbe utile esplorare il contesto sociale, economico e culturale più ampio dell’epoca, confrontando magari la situazione tedesca con quella di altri paesi europei. Approfondire la storia sociale e la storia del teatro popolare potrebbe offrire una prospettiva più completa, magari leggendo autori che si occupano di storia culturale del Seicento o di storia dello spettacolo.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]