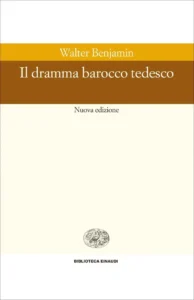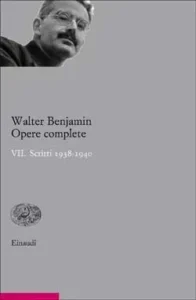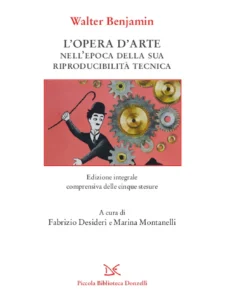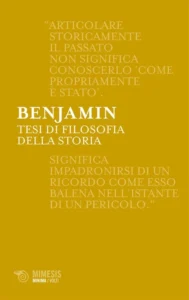1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Aura e choc. Saggi sulla teoria dei media” di Walter Benjamin è un libro che ti prende e ti fa vedere l’arte e il mondo in modo diverso, soprattutto come cambiano con le nuove tecnologie. Benjamin analizza come la riproducibilità tecnica, pensiamo al cinema o alla fotografia, trasformi l’opera d’arte, facendole perdere quell’aura unica e irripetibile che aveva prima, legata al suo essere originale e al suo valore quasi sacro. Al posto dell’aura, arriva lo choc, l’esperienza frammentata e intensa della vita moderna, specialmente nella metropoli come Parigi, che Benjamin esplora come un luogo pieno di segni nascosti e di stimoli continui. Il libro parla di tantissimi media: dalla pittura cinese alla poesia di Baudelaire, dal teatro epico di Brecht al cinema russo, fino alla radio e alla traduzione linguistica, vista non solo come passaggio di parole ma come ricerca di una “lingua pura”. Benjamin ti mostra come questi media non siano solo strumenti, ma modificano la nostra percezione e il nostro modo di vivere la storia, usando concetti come il montaggio, che scompone e ricompone la realtà. È un viaggio affascinante attraverso l’arte, la tecnica e la società, che ti fa capire quanto i media abbiano plasmato e continuino a plasmare chi siamo e come vediamo il mondo.Riassunto Breve
La riproduzione tecnica cambia completamente l’arte. Prima, un’opera aveva un’aura, una specie di alone unico legato al suo essere lì, in quel posto e in quel momento, e al suo uso nei riti. La riproduzione, invece, la stacca da tutto questo. L’autenticità e il valore legato al culto diminuiscono, mentre aumenta il valore legato all’esposizione, cioè al fatto che l’opera diventa accessibile a tante persone. Il cinema è l’esempio perfetto di questo cambiamento. Passa dal valore legato al culto a quello espositivo, da una visione quasi magica a una ricezione più distratta, che usa i sensi in modo diverso. Il cinema, con le sue tecniche, cambia come percepiamo le cose, ci mostra un “inconscio ottico” e ci prepara a vivere in modo nuovo nell’era della tecnologia. Questa cosa ha lati positivi, come la possibilità di liberare le persone, ma anche rischi, come l’uso dell’arte per fare propaganda politica, come faceva il fascismo che “estetizzava la politica”, mentre il comunismo cercava di “politicizzare l’arte”. La storia dell’arte è legata a quella dei media e a come cambia la percezione, un continuo movimento tra lontano e vicino, valore di culto e valore di esposizione. Anche la fotografia all’inizio aveva una specie di aura, legata alla tecnica precisa e al tempo lungo di esposizione, ma poi è diventata merce e strumento di massa, perdendo quell’unicità. Artisti come Atget e Sander hanno usato la fotografia in modo nuovo, più oggettivo o scientifico. Il dibattito si sposta sull’uso sociale della fotografia e su come cambia la percezione dell’arte stessa. Il cinema russo mostra come fotografia e film possano avere un forte significato politico e sociale. Il montaggio, che scompone e ricompone la realtà, diventa una tecnica fondamentale non solo nel cinema, ma anche nel teatro, come nel teatro epico di Brecht, che usa l’interruzione per far pensare lo spettatore invece di farlo immedesimare. Anche la radio, un altro medium, può diventare uno strumento per insegnare e stimolare il pensiero critico, se il pubblico non è solo passivo ma partecipa. Il linguaggio stesso è un medium che comunica sé stesso, non solo un mezzo per dire qualcosa, e la traduzione cerca una “lingua pura” che sta nascosta in ogni lingua. L’autore, in quest’epoca, deve capire il suo posto e usare la sua tecnica per cambiare le cose, non solo per servire l’apparato esistente, cercando di coinvolgere il pubblico nella produzione culturale. La poesia di Baudelaire racconta la vita moderna, piena di “choc” e dove l’aura scompare, specialmente nella città, dove le esperienze sono frammentate. La “povertà di esperienza” nella società moderna, dopo eventi come le guerre, porta a un azzeramento, a ricominciare da capo, valorizzando l’essenziale, come si vede nell’architettura moderna. Il sogno e la veglia sono importanti per capire come percepiamo, e il Surrealismo cerca di unire queste due dimensioni, trovando energie rivoluzionarie nelle cose vecchie e dimenticate della città. Il montaggio, infine, è anche un modo per guardare la storia, non come un racconto continuo, ma come un insieme di “immagini dialettiche” che mettono insieme passato e presente in un lampo, rendendo leggibili i frammenti storici.Riassunto Lungo
1. L’Opera nell’Era della Tecnica
Il pensiero di Walter Benjamin
Il concetto di opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica è molto importante nel pensiero di Walter Benjamin, soprattutto per la teoria dei media. In questo saggio, si trovano idee fondamentali come medium, aura e choc. Questi concetti sono collegati tra loro e formano una teoria completa e innovativa. Vengono analizzate diverse forme di arte, tecniche e modi di comunicare. Alcune idee anticipate qui saranno poi spiegate meglio in altri capitoli dedicati ai diversi tipi di media.La genesi del saggio
La creazione di questo saggio è stata lunga e complessa, con diverse versioni e modifiche. La versione presentata qui, chiamata Urtext, è stata scritta prima della versione finale più conosciuta. Offre una visione più originale del rapporto tra medium, aura e choc. Questo testo è collegato al progetto sui Passages e Parigi capitale del XIX secolo. Funziona come introduzione teorica a un modo di vedere l’arte basato sui fatti materiali.La riproducibilità tecnica e la trasformazione dell’arte
La possibilità di riprodurre tecnicamente le opere d’arte cambia completamente il modo in cui viviamo l’arte. In passato, l’opera d’arte aveva un’aura, cioè era unica e legata al momento e al luogo in cui si trovava, e alle tradizioni. Invece, la riproduzione tecnica libera l’opera d’arte da questi legami. L’importanza dell’autenticità e del valore tradizionale dell’opera, legati ai riti, diminuisce, e aumenta il valore di poterla mostrare a un vasto pubblico. L’arte diventa accessibile a molte persone.Il cinema come esempio di cambiamento
Il cinema è un esempio perfetto di questo cambiamento. Rappresenta il passaggio dal valore tradizionale al valore di esposizione, dal guardare l’opera d’arte con attenzione al riceverla in modo distratto e immediato. Il cinema, con le sue tecniche di riproduzione e montaggio, cambia il modo in cui percepiamo le cose. Ci offre un “inconscio ottico” e ci prepara a nuove esperienze tipiche dell’era tecnologica. Questo cambiamento ha aspetti positivi e negativi. Da un lato, può portare a una maggiore libertà, ma dall’altro, può essere usato per manipolare le persone politicamente. Un esempio negativo è l’uso dell’estetica nella politica del fascismo. A questo, il comunismo risponde cercando di rendere l’arte più politica. La storia dell’arte è quindi legata alla storia dei media e del modo in cui percepiamo il mondo. C’è un continuo movimento tra opposti come distanza e vicinanza, valore tradizionale e valore di esposizione, apparenza e illusione.Ma il concetto di “aura” è ancora valido nell’era digitale, dove la riproducibilità tecnica è assoluta e pervasiva?
Il capitolo sembra dare per scontata la persistenza di un concetto di “aura” nell’arte riproducibile, pur sottolineandone la trasformazione. Tuttavia, nell’era digitale, dove ogni immagine e suono può essere replicato, modificato e diffuso all’infinito, è necessario interrogarsi se l’idea di “aura” mantenga ancora un significato o se sia stata completamente superata dalla natura stessa dei nuovi media. Per rispondere a questa domanda, sarebbe utile approfondire le teorie dei media più recenti e confrontarle con il pensiero di Benjamin, magari studiando autori come McLuhan o Debord, per capire come la riproducibilità tecnica estrema influenzi la nostra percezione e il valore attribuito all’arte.2. L’Essenza Cromatica dell’Arte
Il colore si presenta come l’aspetto spirituale dei sensi e come espressione pura della fantasia. Il colore puro esiste nell’intuizione, e proprio in essa si trova la sua forma assoluta. Quando il colore viene utilizzato nella pittura, diventa un riflesso della fantasia, trasformandosi in azione e creando effetti di luce e ombra. È importante notare che la superficie, più del colore stesso, costituisce la base spirituale dell’immagine, poiché è la superficie che illumina e valorizza il colore. La fantasia, che è la fonte del colore, si manifesta come la capacità di intuire un modello o una forma ideale, unendo chi guarda e ciò che viene guardato.La Differenza tra Pittura e Disegno
La pittura, chiamata “Mal”, si distingue dal “Zeichen”, cioè dal disegno, perché è un mezzo espressivo che emerge spontaneamente, senza essere impresso o forzato. A differenza del disegno grafico, la pittura non ha bisogno di uno sfondo preparato né di linee precise; i contorni delle aree di colore si definiscono attraverso la composizione stessa dell’opera. La composizione introduce nella pittura, nel “Mal”, una forza superiore, che è quella del linguaggio. Questa forza permette di dare un nome e un significato all’immagine che nasce dalla pittura. Le diverse epoche della pittura si distinguono in base al tipo di linguaggio che si unisce alla pittura e al modo in cui la pittura, il “Mal”, viene intesa.L’Analisi Rigorosa dell’Opera d’Arte
Lo studio scientifico e approfondito dell’arte si concentra sull’analisi delle singole forme artistiche, rifiutando le semplificazioni e le generalizzazioni tipiche dei racconti generali sulla storia dell’arte. L’opera d’arte viene considerata come un “mondo piccolo” a sé, che deve essere studiato in profondità per scoprire il suo vero significato, che spesso non è immediatamente evidente. Questo modo di studiare l’arte, ispirato al pensiero di Riegl, dà grande importanza all’analisi dettagliata e specifica di ogni opera, spostando l’attenzione dagli aspetti superficiali, come i “problemi di forma”, al significato storico e concreto dell’opera stessa. Anche i casi particolari, come il disegno architettonico, diventano fondamentali per capire i processi di cambiamento e di declino nell’arte, rivelando aspetti importanti che spesso vengono trascurati.Ma è davvero utile definire il colore come “aspetto spirituale dei sensi” senza fornire una solida base teorica?
Il capitolo introduce concetti come “spiritualità” e “fantasia” in relazione al colore, ma manca un’analisi critica di queste categorie. Senza una definizione chiara e un riferimento a teorie consolidate sulla percezione e l’estetica, si rischia di cadere in un discorso vago e soggettivo. Per comprendere appieno la relazione tra colore, percezione e “spiritualità” nell’arte, sarebbe opportuno esplorare le teorie della percezione del colore, la filosofia dell’arte e le neuroscienze cognitive, consultando autori come Rudolf Arnheim o studiosi della Gestaltpsychologie.3. L’Impronta del Pensiero: Arte, Linguaggio e Percezione
La Pittura Cinese e l’Arte di Pensare per Immagini
La pittura cinese, specialmente quella delle dinastie Ming e Ch’ing, dimostra una grande abilità tecnica e un forte legame tra pittura e scrittura. Questo legame si vede nella figura del pittore-letterato, per cui l’arte non è solo rappresentare qualcosa, ma è anche esprimere un pensiero. La calligrafia cinese è un esempio di questa unione, perché sta a metà strada tra immagine e pensiero. È come un “gioco d’inchiostro” che mostra come le cose si assomigliano e si influenzano a vicenda. Quindi, l’arte pittorica cinese è un modo di pensare usando le immagini, dove si cerca di cogliere l’essenza della realtà che cambia continuamente.L’Importanza di Affinare la Percezione per Apprezzare l’Arte
Per capire bene l’arte, bisogna imparare a percepire in modo più profondo, riuscendo a vedere la bellezza che il tempo rivela nelle opere. Il tempo cambia sia l’aspetto materiale che il significato spirituale dell’arte, rendendola più ricca. Per capire veramente l’arte, serve una sensibilità profonda e un modo di giudicare che va oltre la semplice conoscenza superficiale. Bisogna cercare una verità che non si vede subito, ma si manifesta in modo indiretto. Vivere l’arte in prima persona e anche collezionare opere, anche solo una, aiuta molto a sviluppare un vero senso artistico.Il Linguaggio: Non Solo Strumento di Comunicazione
Il linguaggio non serve solo per comunicare, ma è un mezzo che comunica anche sé stesso. Ogni lingua esprime la realtà in modi unici e diversi, che non si possono scambiare tra loro. Quando si traduce, non si tratta solo di cambiare le parole da una lingua all’altra, ma di cercare una “lingua pura” ideale, come se si volesse riunire tutte le lingue che si sono separate. La capacità umana di imitare, che si vede nei bambini quando giocano e nelle forme antiche di conoscenza, si trasforma nel linguaggio e nella scrittura, che diventano come archivi di “somiglianze che non si possono toccare”.Il Ruolo dell’Autore nell’Epoca Moderna
Nell’epoca in cui si producono tantissime cose in serie, chi scrive deve chiedersi quale sia il suo ruolo nella società e se il suo modo di scrivere sia utile per far progredire le cose o le faccia peggiorare. Il giornalismo e i nuovi mezzi di comunicazione offrono esempi di come il ruolo di chi scrive e di chi legge o guarda può cambiare e diventare più attivo. La parola, unita ad altre forme espressive come le foto e la musica, mette in discussione le divisioni tradizionali tra le arti. Si cerca di portare la “letteratura” nella vita di tutti i giorni e chi scrive ha un ruolo educativo, insegnando qualcosa.La Poesia di Baudelaire e l’Esperienza Moderna dello “Choc”
La poesia di Baudelaire, infine, mostra la condizione moderna caratterizzata dallo “choc” e dalla perdita dell’aura, cioè di quella speciale atmosfera che circonda le opere d’arte uniche. La vita nelle grandi città, con le sue continue interruzioni e i suoi traumi, si riflette nella sua opera. Baudelaire è una figura di passaggio tra il modo di vivere tradizionale e la modernità. Cerca di salvare il valore speciale dell’arte in un mondo che cambia rapidamente, dove l’esperienza vera e profonda viene sostituita da un’esperienza più superficiale e vissuta di fretta. La sua poesia diventa così l’espressione di come l’aura scompare nell’epoca dello choc.Ma è davvero “liberatorio” dimenticare il passato, o rischiamo di ripetere gli stessi errori, magari con materiali più moderni?
Il capitolo descrive una reazione alla perdita di esperienza come una spinta a concentrarsi sull’essenziale e sul nuovo, quasi fosse una soluzione positiva e necessaria. Tuttavia, non si sofferma sulle implicazioni di questa tabula rasa. È utile chiedersi se questa “liberazione” dalla storia non ci privi anche di strumenti fondamentali per comprendere il presente e affrontare il futuro. Per approfondire questa critica, si potrebbe esplorare il pensiero di autori come Hannah Arendt, che ha analizzato i pericoli della perdita di memoria e di tradizione nel mondo moderno.12. Montaggio di Tempi: Immagini Dialettiche e Storia
La Storicità dell’Esperienza Sensibile nei Media
Secondo Benjamin, la fotografia e il cinema hanno la capacità di mostrare come cambia nel tempo il modo in cui percepiamo il mondo attraverso i sensi. Questi mezzi di comunicazione non si limitano a modificare la nostra percezione, ma ci danno anche degli strumenti teorici per ripensare la storia. In questo contesto, il montaggio diventa un modo fondamentale per costruire significati, prendendo spunto dalle avanguardie artistiche degli anni ’20 e ’30. Questa tecnica, chiamata “montaggio letterario”, si distingue dal modo tradizionale di raccontare la storia, proponendo invece una narrazione storica che non segue un ordine lineare e continuo, ma procede per salti e interruzioni.Il Montaggio come Strumento di Conoscenza
L’opera “Passagenwerk” è un esempio concreto di questa visione. In questo lavoro, Benjamin utilizza il montaggio come principio guida per organizzare la sua analisi del XIX secolo, che si presenta in forma frammentata. Il montaggio non è quindi solo un modo per esprimersi artisticamente, ma diventa un vero e proprio strumento per capire la realtà. Grazie al montaggio, è possibile rendere comprensibili i frammenti del passato, mettendoli in relazione dialettica con il presente. In altre parole, il montaggio ci permette di leggere il passato attraverso gli occhi del presente e viceversa, creando un dialogo tra epoche diverse.L’Immagine Dialettica: Unione di Passato e Presente
L'”immagine dialettica” è un tipo speciale di montaggio che unisce il tempo passato e il tempo presente. È come una costellazione, in cui elementi del passato e del presente si incontrano improvvisamente, illuminandosi a vicenda. Questa immagine ci offre un modo di capire la storia che non si basa sulla ricerca di ciò che è continuato nel tempo o sulla semplice identificazione con il passato. Al contrario, l’immagine dialettica si fonda sulla discontinuità, sul cambiamento e sulla capacità di rendere attuale ciò che è stato. Questo modo di vedere la storia prende ispirazione dalla forma di “Strada a senso unico”, un’opera di Benjamin che sperimenta un tipo di montaggio applicato alla scrittura. Attraverso il montaggio, la storia non viene presentata come un racconto lineare, ma si frantuma in immagini. In questo modo, si rivela la natura ambivalente della storia, che è allo stesso tempo costruzione e distruzione, ordine e caos.Ma se il montaggio è uno strumento di conoscenza, quali sono i criteri per distinguere un montaggio illuminante da uno fuorviante o arbitrario?
Il capitolo descrive il montaggio come cruciale per rivelare la natura ambivalente della storia, ma non approfondisce i meccanismi attraverso i quali il montaggio garantisce una comprensione più profonda, piuttosto che una semplice manipolazione o interpretazione soggettiva dei frammenti storici. Per comprendere meglio come il montaggio possa essere utilizzato in modo rigoroso e non arbitrario, sarebbe utile esplorare le opere di Benjamin più direttamente legate alla metodologia storica, come “Angelus Novus” o altri saggi sulla filosofia della storia. Approfondire autori come Aby Warburg, che ha sviluppato un metodo di analisi iconografica basato su principi simili al montaggio, potrebbe offrire ulteriori strumenti concettuali per valutare la validità e l’efficacia di questo approccio.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]