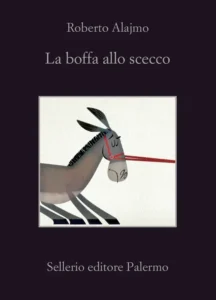1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
RISPOSTA: “Arriva la fine del mondo” di Roberto Alajmo ci porta in un viaggio affascinante attraverso le nostre ossessioni per la catastrofe, esplorando come l’attesa della fine del mondo, dalle profezie Maya all’era digitale, sia un tema ricorrente nella storia umana, spesso alimentato da paure irrazionali e dalla ricerca di un senso in tempi incerti. Il libro analizza come questa “psicosi della fine del mondo” si manifesti non solo in contesti religiosi, ma anche nelle preoccupazioni laiche legate al cambiamento climatico o all’intelligenza artificiale, intrecciando previsioni scientifiche con il fascino per scenari apocalittici. Attraverso un’analisi acuta, Alajmo ci mostra come l’Italia, in particolare, viva un “limbo della rivolta mancata” e un “trionfo dell’incompetenza”, dove la rassegnazione e la perdita di fiducia nel futuro sembrano prevalere, creando un declino lento ma inesorabile. Il mondo, nel frattempo, si restringe, con crisi globali che non conoscono confini, mentre l’umanità si trova paradossalmente nell’età migliore della sua storia, eppure dominata da un’inquietudine persistente e da una lenta erosione dei valori civili. Questo libro è un’esplorazione profonda delle pulsioni umane di fronte all’incertezza, un invito a riflettere sulla nostra percezione del futuro e sulle dinamiche sociali che ci portano a immaginare la fine, anche quando viviamo in un’epoca di prosperità senza precedenti.Riassunto Breve
L’idea che il mondo stia per finire è sempre presente, con profezie che si susseguono e date che cambiano. Questa attesa di una catastrofe, che sia basata su antiche credenze, interpretazioni religiose o paure moderne come quelle ambientali o tecnologiche, genera ansia e a volte porta a comportamenti estremi. Le persone tendono a vedere segnali di questa fine ovunque, anche in eventi naturali. Accanto alle previsioni di disastri naturali come eruzioni o impatti di asteroidi, ci sono quelle legate all’azione umana, come il collasso ambientale dovuto allo sfruttamento delle risorse o il rischio che l’intelligenza artificiale diventi una minaccia. Nonostante i progressi globali in termini di ricchezza e aspettativa di vita, la paura di un grande collasso, che sia finanziario, sanitario o militare, persiste.In alcuni contesti, come l’Italia, si osserva una forma di declino meno improvvisa e più strisciante. Manca una vera spinta alla rivolta sociale, forse perché le proteste funzionano da sfogo o perché le nuove generazioni sono ancora dipendenti dai genitori. La mancanza di esperienza diretta della guerra in Occidente ha rimosso un modo storico di gestire le tensioni, e la violenza sembra spesso virtuale. La crisi economica viene vissuta in modo individuale, non collettivo, impedendo reazioni di massa. Il sistema sociale ed economico si basa su una precarietà diffusa, chiamata “Gratitudine Sospesa”, che lega le persone al potere e impedisce loro di rivendicare i propri diritti o di acquisire competenze stabili. Si assiste a una selezione al contrario, un “Darwinismo Invertito”, dove l’incompetenza è spesso premiata sulla capacità, portando a inefficienze e a una perdita del senso di vergogna per l’ignoranza. C’è anche un disinteresse per i lavori manuali essenziali.A livello globale, i disastri mostrano che i confini nazionali non contano. Crisi finanziarie o ambientali si diffondono rapidamente. Un fattore cruciale è lo squilibrio demografico, con l’Occidente che invecchia e i paesi poveri che crescono, rendendo inevitabili le migrazioni verso il Nord, nonostante i tentativi di bloccarle. Questa realtà globale si scontra con la percezione di un benessere diffuso, che convive con l’attesa di una fine. I media amplificano allarmi che spesso non si concretizzano, portando a una certa incredulità ma non a una diminuzione dell’inquietudine.Il vero processo di cambiamento sembra essere una lenta erosione del contesto civile. Questo degrado graduale, fatto di piccole negatività quotidiane, alza la soglia di tolleranza e rende le persone apatiche. Di fronte all’accumulo di problemi, ambientali e sociali, si diffonde un senso di impotenza e rassegnazione. L’idea che non ci sia più nulla da fare porta ad accettare la situazione, a volte giustificando i propri comportamenti negativi con il quadro generale già compromesso. Invece di agire, si aspetta quasi un evento traumatico, un collasso improvviso, sperando che possa portare a una rigenerazione, perché le forze per resistere o cambiare sembrano esaurite.Riassunto Lungo
1. L’attesa della catastrofe e le sue forme
Le previsioni sulla fine del mondo si ripetono nel tempo, con scadenze che sembrano farsi sempre più vicine. Queste teorie nascono da interpretazioni di antiche profezie, come quelle legate al calendario Maya, o da letture di testi sacri e persino da allineamenti planetari, generando attesa e a volte veri e propri stati di psicosi collettiva. È evidente come l’idea di un’imminente apocalisse eserciti un fascino maggiore rispetto all’annuncio di un’era di pace duratura. La paura di questa fine porta le persone a cercare segnali ovunque, interpretando anche eventi naturali insoliti come presagi. Si nota, ad esempio, come i terremoti sembrino colpire con maggiore frequenza le aree già più vulnerabili, alimentando la convinzione che alcune popolazioni siano destinate a un fato avverso. Anche nella modernità, la superstizione non scompare; al contrario, gruppi religiosi, soprattutto negli Stati Uniti, continuano a fissare date precise per l’apocalisse, preparando i propri seguaci con esiti che possono essere drammatici, arrivando persino a suicidi collettivi. In questo senso, la teoria stessa della fine del mondo può innescare apocalissi reali, sebbene su scala ridotta.Perché l’idea della fine attrae?
Le teorie apocalittiche su larga scala continuano a nascere, spesso guidate da figure carismatiche e dalla ricerca di capri espiatori a cui attribuire le colpe del male presente. La fine del mondo viene spesso immaginata non solo come distruzione, ma anche come la condizione necessaria per l’inizio di un’era radicalmente migliore, offrendo così ai credenti la potente speranza di una salvezza futura. Il termine stesso “Apocalisse”, che in origine significa “Rivelazione”, ha assunto nel linguaggio comune un senso prettamente catastrofico. L’idea di una fine imminente sembra attrarre in modo particolare chi sente di avere poco da perdere nella situazione attuale, nutrendo la speranza in un azzeramento delle gerarchie sociali e in un ribaltamento delle sorti. Questa convinzione di appartenere all’ultima generazione che vedrà la fine dei tempi rivela un certo egocentrismo, ponendo la propria epoca al centro di un evento cosmico definitivo.Forme diverse di previsioni
Esistono anche forme di “finismo” meno drammatiche, legate alla previsione della scomparsa di specifiche tecnologie o usanze a causa dell’introduzione di nuove invenzioni; si pensi al dibattito tra cinema e televisione o tra libri cartacei ed e-book. Spesso, tuttavia, l’evoluzione porta all’integrazione delle nuove tecnologie con quelle preesistenti, ampliando l’offerta disponibile anziché sostituirla completamente. Le leggende apocalittiche su date precise, come quelle diffuse per il 2012 o il 1982, tendono a essere dimenticate una volta superata la scadenza prevista, salvo poi riemergere in nuove forme o con nuove date. Predicatori come Harold Camping hanno fissato scadenze precise basate su complessi calcoli biblici, e nonostante i ripetuti fallimenti, hanno semplicemente spostato in avanti la data attesa. La credenza nell’apocalisse non si limita all’ambito religioso; anche il profondo pessimismo legato alle problematiche ambientali o la paura di un olocausto nucleare rappresentano forme laiche di millenarismo, proiezioni della stessa ansia per il futuro. La crisi dei missili di Cuba nel 1962 ha effettivamente portato il mondo sull’orlo dell’autodistruzione, un evento di portata apocalittica che, sorprendentemente, è stato in gran parte rimosso dalla memoria collettiva.Affrontare la paura
La psicosi legata alla fine del mondo può essere interpretata come un modo per l’umanità di affrontare e gestire la paura profonda dell’ignoto e della perdita. Questa paura si manifesta in diversi meccanismi psicologici: l’espiazione delle colpe passate, l’elaborazione anticipata di un lutto futuro per ciò che potrebbe essere perso, o una sorta di esorcismo collettivo per tentare di controllare le conseguenze immaginate della catastrofe. Accanto a coloro che abbracciano attivamente la credenza nell’apocalisse, vi sono gli “integrati”, che scelgono di rimuovere completamente il problema e di non pensarci. Esiste anche una prospettiva edonistica, tipica di chi, pur consapevole del rischio, sembra quasi accettare e persino accelerare la corsa verso la catastrofe imminente, concentrandosi unicamente sul piacere presente. Nonostante il continuo susseguirsi di fallimenti nelle profezioni sulla fine, l’idea di un’imminente catastrofe persiste con forza, rivelando l’esistenza di pulsioni profonde nell’animo umano che vanno al di là della semplice razionalità o della verifica dei fatti.Ma davvero l’attrazione per la fine del mondo si spiega unicamente con ‘pulsioni profonde nell’animo umano’, o non si rischia di ignorare le precise condizioni sociali, economiche e politiche che rendono fertile il terreno per tali profezie?
Il capitolo offre un’interessante disamina delle dinamiche psicologiche che sottendono la persistenza delle credenze apocalittiche, focalizzandosi sulla paura, la speranza e l’egocentrismo. Tuttavia, nel porre l’accento quasi esclusivo sulle motivazioni interiori e “profonde”, si potrebbe sottovalutare il peso determinante dei fattori esterni. Le attese catastrofiche e i movimenti millenaristi non emergono dal nulla; sono spesso risposte a crisi strutturali, disuguaglianze marcate, instabilità politica o rapidi cambiamenti sociali che generano insicurezza e alienazione. Per comprendere appieno il fenomeno, è cruciale integrare la prospettiva psicologica con l’analisi dei contesti in cui queste idee fioriscono. Approfondire discipline come la Sociologia, la Storia sociale e la Scienza Politica, leggendo autori che hanno studiato i movimenti collettivi, le ideologie e il loro rapporto con le condizioni materiali, come Max Weber o Eric Hobsbawm, può offrire una visione più completa e meno riduttiva del perché l’idea della fine continui ad affascinare e mobilitare le masse.2. Previsioni e Sfide del Futuro
Esistono molte idee su possibili eventi futuri che potrebbero cambiare radicalmente il mondo come lo conosciamo. Alcune di queste idee vengono da antiche culture, come quelle dei Maya, che parlavano di cicli del mondo che finiscono con eventi distruttivi, come grandi alluvioni. Altre previsioni riguardano fenomeni naturali che potrebbero accadere sulla Terra o nello spazio.
Previsioni Naturali
Questi fenomeni naturali includono l’inversione dei poli magnetici della Terra, forti tempeste solari che potrebbero danneggiare le nostre tecnologie, grandi eruzioni di supervulcani come quello di Yellowstone o i Campi Flegrei, o l’impatto con asteroidi o pianeti misteriosi come Nibiru. Anche le previsioni meno basate sulla scienza possono avere effetti concreti sulla vita delle persone, spingendole, ad esempio, a comprare case in luoghi considerati sicuri e influenzando così l’economia di quelle zone.Impatto Umano
Oltre alle minacce naturali, si considerano scenari legati a quello che fa l’uomo. Alcuni esperti pensano che la popolazione mondiale potrebbe diminuire molto a causa del riscaldamento del pianeta e di come usiamo le risorse in modo non sostenibile. La storia dell’Isola di Pasqua è un esempio di come sfruttare troppo la natura, specialmente tagliando tutti gli alberi, possa portare a un crollo della società, alla mancanza di cibo e persino ad atti estremi. Questa storia serve da avvertimento per la situazione che il mondo intero potrebbe affrontare.Futuri Tecnologici
Anche il progresso scientifico e tecnologico presenta nuove sfide e possibili scenari di “fine”. Una teoria molto discussa, soprattutto nell’ambiente della tecnologia, parla della “Singolarità”. Si immagina un momento nel prossimo futuro, forse tra il 2030 e il 2045, in cui l’intelligenza artificiale diventerà più capace di quella umana, riuscendo a migliorarsi da sola e a prendere decisioni autonome. Questo scenario solleva la preoccupazione che le macchine possano arrivare a vedere l’umanità come un ostacolo. Allo stesso tempo, la ricerca scientifica punta a superare i limiti della vita umana. Attraverso tecniche avanzate e l’uso della tecnologia nel corpo umano, si cerca di fermare o invertire l’invecchiamento per vivere molto più a lungo. Questo obiettivo, pur sollevando questioni etiche importanti, è visto da alcuni come il passo logico successivo della medicina. Tuttavia, cercare di prolungare la vita a tutti i costi fa anche riflettere sulla qualità dell’esistenza e crea nuove difficoltà per la società e l’economia, dovendo gestire una popolazione sempre più vecchia.Si possono davvero confrontare le previsioni basate su miti antichi con quelle derivate da studi scientifici senza cadere nella confusione?
Il capitolo mette sullo stesso piano “idee” su eventi futuri che spaziano da miti antichi e speculazioni non verificate (come la menzione di Nibiru) a fenomeni naturali e sviluppi tecnologici oggetto di studio scientifico. Questa commistione, senza una chiara distinzione tra ciò che è basato su evidenze e ciò che è pura fantasia o credenza, crea un cortocircuito logico e mina la credibilità dell’analisi. Per navigare in questo mare di “previsioni”, è essenziale affinare gli strumenti del pensiero critico e comprendere le basi del metodo scientifico. Approfondire autori che si occupano di scetticismo razionale e di come smascherare la pseudoscienza, come ad esempio James Randi, può fornire gli strumenti necessari.3. Il Limbo della Rivolta Mancata
La rivoluzione attesa in Italia negli anni Duemila non si verifica, e le ragioni di questo ritardo sono molteplici. Le proteste studentesche e le occupazioni funzionano come uno sfogo che impedisce una vera rivolta, permettendo di liberare la tensione senza cambiare lo stato delle cose. Le ultime generazioni hanno visto le precedenti faticare e hanno capito che per loro non resta quasi nulla. Questa situazione dovrebbe spingere alla rivolta, ma non accade, anche perché in Occidente manca l’esperienza diretta della guerra da settant’anni. Questo crea un senso di sicurezza diffuso e rimuove un meccanismo storico per gestire le tensioni sociali e la popolazione. Il senso della morte è diminuito, sostituito da una percezione di impunità e immortalità, dove la violenza sembra quasi virtuale, e l’esposizione continua a immagini di sofferenza attraverso i media porta a una progressiva desensibilizzazione.La Crisi Nascosta
La crisi attuale è diversa dalle precedenti; è meno visibile e viene vissuta in modo individuale o familiare, spesso dentro casa. Contrariamente alle crisi passate, non porta necessariamente alla fame nel senso tradizionale, ma a un consumo di cibo economico e poco sano, creando un paradosso in cui la società appare esteriormente sana ma nasconde problemi interni. Si cerca di mantenere le apparenze di benessere e si usano svaghi economici, come la televisione, per distrarsi dalle difficoltà quotidiane. Questa percezione individuale impedisce un’azione collettiva efficace, poiché i problemi sono sentiti come personali e non come una condizione sociale condivisa che richiederebbe una risposta unitaria.La Passività dei Giovani
Atti di violenza isolati avvengono, ma non si traducono in un movimento rivoluzionario organizzato. I giovani, che tradizionalmente guidano le rivolte e i cambiamenti sociali, mostrano una notevole passività. Sono ancora sostenuti economicamente dai genitori, e questa dipendenza prolungata ritarda qualsiasi potenziale insurrezione. La speranza di una rivolta futura sembra legata alla fine di questo supporto economico, ma quando ciò accadrà, i giovani saranno più vecchi e probabilmente meno inclini a lottare o a mettersi in gioco in modo radicale. Si osserva anche una rottura nella tradizione dei genitori che costruiscono per i figli, poiché le risorse accumulate vengono spesso consumate nel presente per mantenere lo status quo o per sostenere la generazione più giovane, invece di essere investite per il loro futuro.Ma se il benessere è davvero così diffuso, perché la paura di un crollo e le rivolte urbane sembrano essere in aumento?
Il capitolo dipinge un’epoca di apparente prosperità globale, un dato che stride con la diffusa sensazione di precarietà e l’attesa di un crollo. Tuttavia, l’argomentazione potrebbe beneficiare di una maggiore attenzione alla natura di questo benessere: è davvero così “diffuso” come suggerito, o le crescenti disuguaglianze economiche e sociali rappresentano un elemento di frizione fondamentale, capace di alimentare quella frustrazione che sfocia nelle rivolte urbane e nella percezione di un sistema sull’orlo del baratro, indipendentemente dai dati medi? Approfondire gli studi sulla disuguaglianza, leggendo autori come Thomas Piketty o esplorando i concetti di economia circolare e “doughnut economics” (come proposto da Kate Raworth), può offrire strumenti critici per analizzare se la prosperità attuale sia sostenibile e inclusiva, o se stia creando le condizioni per le stesse tensioni che il capitolo descrive.7. La lenta erosione
Si assiste a un progressivo cedimento del tessuto civile che si riflette nel modo in cui le persone si comportano ogni giorno. Questo peggioramento non avviene in modo improvviso, ma è un processo graduale, quasi difficile da notare all’inizio, che però si manifesta con sempre maggiore frequenza. Fatti e situazioni che in passato avrebbero provocato reazioni forti o indignazione vengono ora accettati come normali, quasi fossero parte del paesaggio quotidiano. Questo lento ma costante scivolamento verso il basso, fatto di piccole negatività che si accumulano, agisce come un lento veleno che alza la nostra capacità di sopportazione.L’indifferenza e l’illusione
La popolazione, esposta a questo deterioramento continuo, sviluppa una sorta di insensibilità, diventando meno capace di provare indignazione e più incline all’apatia di fronte a eventi che un tempo avrebbero scatenato proteste o dibattiti accesi. La consapevolezza che il degrado è ormai diffuso, visibile nell’accumulo di problemi come i rifiuti non raccolti o il peggioramento delle condizioni di vita per molte persone, può portare a un profondo senso di impotenza. Si tende così ad accettare la situazione così com’è, a volte giustificando la propria inazione pensando che un singolo gesto positivo non possa cambiare un quadro già così compromesso. Questa accettazione passiva si rafforza nel tempo, radicando la convinzione che non ci sia più nulla di efficace da fare per invertire la rotta.Danni irreversibili e rassegnazione
Il degrado che si osserva, specialmente quello legato all’ambiente, provoca spesso danni che non possono essere riparati. Nonostante i segnali di un peggioramento a livello mondiale, come l’aumento della povertà e della fame in molte aree, prevale l’idea sbagliata che tutto questo non tocchi direttamente il proprio benessere immediato. C’è una distanza temporale tra il momento in cui il danno ecologico si verifica e quando i suoi effetti si manifestano nella vita di tutti i giorni, un po’ come un debito che si sa di dover pagare, ma non subito. Di fronte a questo scenario, si diffonde un senso di profonda rassegnazione. Sembra che l’unica alternativa all’agire sia aspettare che accada qualcosa di molto grave, un crollo improvviso, sperando che forse solo un evento traumatico possa innescare una rinascita, perché le energie per resistere o cambiare direzione sembrano ormai esaurite. Si arriva a un punto in cui l’invito a non farsi prendere dal panico, che appare idealmente sullo schermo della realtà, si trasforma in un’amara constatazione: “Okay, è il momento del panico”.Ma se il problema è la ‘lenta erosione’, quali sono le cause profonde che la alimentano, al di là dei sintomi descritti?
Il capitolo dipinge con efficacia il quadro desolante di una società che scivola nell’indifferenza e nella rassegnazione di fronte al degrado. Tuttavia, si concentra prevalentemente sugli effetti di questa “lenta erosione” (l’apatia, l’accettazione passiva, il senso di impotenza) senza indagare a fondo le radici sistemiche che generano tale deterioramento. Comprendere i meccanismi economici, politici, sociali o culturali che innescano e perpetuano questo processo è fondamentale per valutare se la rassegnazione sia davvero l’unica risposta possibile o se esistano margini per l’azione e il cambiamento. Per approfondire le cause strutturali del degrado sociale e ambientale, può essere utile rivolgere l’attenzione a discipline come la sociologia critica, l’economia politica e gli studi ambientali, leggendo autori che hanno analizzato le dinamiche del potere, le crisi del capitalismo e l’impatto dei modelli di sviluppo sulla società e sull’ambiente.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]