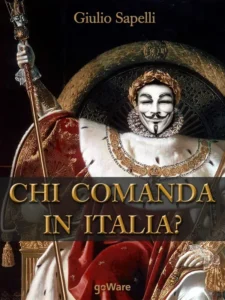1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“AMEN! Un grido inascoltato sulla crisi italiana” di Giulio Sapelli è un libro che ti sbatte in faccia perché l’Italia non cresce più da anni. Non è solo colpa nostra, spiega, ma di un mix micidiale: dalla `deregolamentazione finanziaria` globale che ha creato casini e spostato la ricchezza dalla produzione alla finanza, alle `privatizzazioni Italia` fatte malissimo negli anni Novanta che hanno smantellato pezzi di industria vitale. Poi c’è l’euro, nato per ragioni politiche ma con regole (quelle del `Trattato di Maastricht` e della `Banca Centrale Europea`) che ci ingessano, impedendo strumenti come la svalutazione e tenendo i `salari bassi`. Il `debito pubblico` non è il vero mostro, dice Sapelli, ma la mancanza di `crescita economica Italia`. Il libro analizza anche come la `politica industriale` sia stata abbandonata e come l’istruzione non aiuti a formare i tecnici che servono. Guarda pure al contesto `economia globale`, alla `volatilità finanziaria` e ai nuovi equilibri mondiali. Ma non è solo un lamento: propone soluzioni, come rinegoziare Maastricht, investire strategicamente, riformare la `Cassa Depositi e Prestiti` e ripensare la `tassazione lavoro` per rimettere in moto il paese. È un invito a capire i problemi complessi e a cercare una via d’uscita, anche se sembra che nessuno voglia ascoltare.Riassunto Breve
L’Italia non cresce da circa quindici anni, dopo un periodo di forte aumento della produttività legato alle nuove tecnologie. Questa situazione è collegata alla deregolamentazione finanziaria iniziata negli Stati Uniti, che ha creato nuovi strumenti come i derivati e le “shadow bank”, eliminando la separazione tra banche d’investimento e commerciali e permettendo l’uso dei soldi dei depositanti per operazioni rischiose, causando crisi finanziarie. La mancata crescita deriva anche da una crisi di sovracapacità industriale e dallo spostamento della ricchezza dal profitto industriale alla rendita finanziaria e dal lavoro al capitale, riducendo i mercati interni. In Italia, il carico fiscale su imprese e lavoro è aumentato significativamente. L’euro, nato come invenzione politica per limitare la Germania, con una Banca Centrale Europea modellata sulla Bundesbank e focalizzata sulla stabilità dei prezzi anziché sulla crescita, svantaggia i paesi con un modello economico diverso da quello tedesco. Il debito pubblico non è il problema principale, ma il deficit; la deflazione è un pericolo maggiore dell’inflazione. La rigidità dell’euro impedisce la svalutazione competitiva, e il cambio lira/euro è stato svantaggioso. Le privatizzazioni degli anni Novanta hanno smantellato il patrimonio industriale pubblico vendendo le aziende “a spezzatini”, eliminando grandi imprese statali in settori chiave e contribuendo all’abbassamento dei salari, i più bassi in Europa, indebolendo il mercato interno. Lo smantellamento dell’istruzione tecnica e una cultura che disprezza il lavoro manuale hanno portato a carenze di periti. Per invertire la rotta, si propone di concentrarsi sulla bassa crescita e non solo sul debito, rinegoziando il Trattato di Maastricht per escludere gli investimenti pubblici dal calcolo del deficit. È necessario detassare profitto e lavoro, investire nell’istruzione tecnica e salvare le grandi imprese pubbliche rimaste. Si suggerisce un piano infrastrutturale e l’intervento statale in settori strategici tramite Authorities, difendendo le banche cooperative e promuovendo forme d’impresa che privilegiano l’occupazione. Il futuro economico presenta alta volatilità finanziaria, che mette a rischio i risparmi se le banche non vengono riformate separando le attività. L’indipendenza negli organismi di controllo è cruciale. La crescita globale si sposta verso nuove aree come l’Asia e l’America Latina. Gli Stati Uniti mostrano un disimpegno strategico dall’Europa ma non desiderano il crollo dell’euro. La lotta di classe continua, usando strumenti come l’euro e la paura dell’inflazione. L’ingresso della Cina nel WTO ha creato asimmetrie. L’immigrazione sostenibile richiede pianificazione sociale, non solo logiche di mercato che favoriscono la riduzione del costo del lavoro. Esiste una mancanza di teoria economica chiara per affrontare la crisi. La politica industriale deve identificare settori strategici, dato che l’Italia ha produttività in crescita negativa. Essere in Europa rende più difficile negoziare manovre per la crescita. Per trovare risorse, si considerano la detassazione, la patrimoniale (con obiezioni) o una forte tassazione progressiva sui redditi molto alti, e la vendita di beni immobili statali non utilizzati. La Cassa Depositi e Prestiti necessita di una riforma della governance per diventare uno strumento strategico sotto controllo parlamentare. Esiste una mancanza di giustizia nella distribuzione dei redditi. Trovare risorse per ridurre le tasse e finanziare l’intervento pubblico richiede rinegoziare Maastricht, un accordo con altri paesi europei che vogliono cambiare le regole. La Germania stessa affronta problemi e la sua politica ha impoverito altri paesi. Un cambiamento politico in Germania e Francia è necessario per permettere questa rinegoziazione, l’unica soluzione politica per avere crescita.Riassunto Lungo
1. Le cause della mancata crescita italiana
L’Italia non cresce da circa quindici anni. Questo arresto, che arriva dopo un periodo di forte spinta legato all’introduzione di nuove tecnologie e all’aumento della produttività, si inserisce in un quadro economico globale profondamente cambiato. Negli ultimi decenni, il mondo della finanza ha subito trasformazioni radicali che hanno avuto un impatto diretto sull’economia reale.Trasformazioni Finanziarie e Crisi Economiche
Un cambiamento cruciale è stata la deregolamentazione finanziaria avviata negli Stati Uniti alla fine degli anni Ottanta. Questa ha aperto la strada a nuovi strumenti complessi come i derivati e alla nascita di entità meno controllate, le cosiddette ‘shadow bank’. La vendita dei titoli di Stato è passata dalle banche centrali a consorzi di banche private, e la distinzione tra banche d’investimento e banche commerciali, prevista ad esempio in Italia dalla legge Amato, è venuta meno. Le nuove ‘banche universali’ hanno iniziato a utilizzare anche i risparmi dei depositanti per operazioni più rischiose. Queste profonde modifiche nel sistema finanziario globale hanno innescato diverse crisi a partire dalla fine degli anni Novanta, culminate in quella del 2008. Parallelamente, si è manifestata una crisi di eccesso di capacità produttiva nell’industria. La ricchezza ha cominciato a spostarsi in modo significativo dai guadagni industriali alla rendita finanziaria e dal lavoro al capitale, con la conseguenza di ridurre la domanda e i mercati interni.Fattori Interni Italiani
La situazione italiana presenta criticità specifiche che hanno aggravato il quadro generale. Tra il 1995 e il 2007, a differenza di quanto accaduto in altri paesi, l’Italia ha visto un notevole aumento del carico fiscale su imprese e lavoratori. Una tassazione elevata sul lavoro produttivo, che supera il 35%, rappresenta un freno significativo alla crescita economica. Questo peso fiscale, che grava pesantemente sul costo del lavoro, unito alla riduzione dei mercati interni causata dalle dinamiche globali, ha reso più difficile per le aziende italiane investire, assumere e competere efficacemente.L’Impatto dell’Euro
Un altro elemento cruciale che ha influenzato la performance economica italiana è l’introduzione dell’euro. La moneta unica è nata anche da un’intesa politica tra Mitterrand e Andreotti, con l’intento di bilanciare il peso della Germania dopo la sua riunificazione. La Banca Centrale Europea (BCE) è stata strutturata seguendo il modello della Bundesbank tedesca, ponendo come obiettivo primario la stabilità dei prezzi, a differenza di altre banche centrali nel mondo che considerano anche la crescita economica tra i loro scopi. Questo approccio monetario rigido tende a svantaggiare i paesi la cui struttura economica non rispecchia il modello tedesco, storicamente basato su alta produttività e forte coesione sociale, rendendo più complessa la gestione delle specificità nazionali.Debito, Deflazione e Cambio Valutario
Nel dibattito economico, spesso si punta il dito contro il debito pubblico italiano, ma l’aspetto più critico da considerare è in realtà il deficit. L’inflazione, storicamente, ha rappresentato uno strumento per ridurre il peso del debito in termini reali, mentre la deflazione attuale rappresenta un pericolo molto maggiore per l’economia. La rigidità imposta dall’euro impedisce ai paesi membri di utilizzare la svalutazione competitiva della propria moneta, uno strumento che in passato e in altre economie è stato efficace per favorire le esportazioni e la ripresa. Inoltre, l’Italia ha adottato un cambio lira/euro inizialmente sfavorevole (fissato a circa uno a due), che ha avuto un impatto negativo diretto sul potere d’acquisto degli stipendi e sulla competitività dei prezzi. Questi fattori, uniti alle limitazioni imposte dal quadro monetario europeo, complicano ulteriormente la capacità dell’Italia di ritrovare un percorso di crescita sostenuta.Ma davvero la mancata crescita italiana si spiega solo con la finanza globale, le tasse e l’euro?
Il capitolo offre una visione focalizzata su macro-fattori e vincoli esterni o monetari, come la finanza globale, il carico fiscale e l’impatto dell’euro. Tuttavia, la stagnazione italiana è un fenomeno complesso spesso ricondotto anche a problemi strutturali interni che il capitolo non approfondisce a sufficienza. Per avere un quadro più completo e rispondere a questa domanda, sarebbe utile esplorare studi sull’efficienza della pubblica amministrazione, sul sistema giudiziario, sulla burocrazia, sulla competitività delle imprese (al di là del solo costo del lavoro), sull’innovazione e sul capitale umano. Approfondire le analisi di economisti che si occupano di riforme strutturali e di economia istituzionale potrebbe fornire prospettive aggiuntive fondamentali per comprendere il quadro completo.2. Le Privatizzazioni Sbagliate e la Ricerca di una Nuova Crescita
Le privatizzazioni avvenute in Italia negli anni Novanta hanno smantellato gran parte del patrimonio industriale pubblico. Invece di vendere le imprese per grandi gruppi forti, si è preferito venderle “a spezzatini”, un processo descritto come “alla Boris Eltsin” o “all’argentina”. Questo modo di procedere non è stato accompagnato da una vera liberalizzazione del mercato. Ha portato all’eliminazione di molte grandi aziende statali in settori chiave come la chimica etilenica e la siderurgia a ciclo integrale. L’effetto principale di queste scelte è stato un indebolimento della crescita economica del paese.Le Conseguenze: Salari e Competenze
La perdita di queste grandi imprese, unita all’aumento dell’offerta di lavoro proveniente dall’estero, ha avuto un impatto diretto sui salari. I salari in Italia sono diventati tra i più bassi d’Europa. Un’economia in cui i lavoratori guadagnano poco ha difficoltà a crescere, perché le famiglie hanno meno soldi da spendere e il mercato interno non riesce a sostenere l’economia quando le esportazioni diminuiscono. A peggiorare il quadro, c’è stato un progressivo smantellamento dell’istruzione tecnica e professionale. Questo, insieme a una mentalità che tende a svalutare il lavoro manuale, ha creato una grave mancanza di tecnici specializzati. Si assiste a un’eccessiva enfasi sulle lauree umanistiche, anche per ruoli che non le richiederebbero, e l’influenza delle famiglie spesso limita la disponibilità dei giovani a spostarsi o adattarsi a nuove opportunità. Questa situazione complessiva porta a uno squilibrio, dove la ricchezza si concentra sempre più nelle mani di chi possiede capitale, a discapito di chi vive del proprio lavoro.Proposte per una Nuova Crescita
Per cambiare questa situazione e favorire una nuova crescita economica, si suggeriscono diverse azioni:- Focus sulla Crescita: Non considerare il debito pubblico come il problema principale, ma concentrarsi sulla bassa crescita economica.
- Rinegoziazione Europea: Rinegoziare il Trattato di Maastricht.
- Politica Fiscale: Detassare sia il profitto che il lavoro.
- Investimento in Competenze: Investire in modo significativo nell’istruzione tecnica.
- Protezione delle Imprese Strategiche: Salvare le grandi imprese pubbliche ancora esistenti, come Finmeccanica ed ENI, impedendone lo smembramento.
- Piano Infrastrutturale: Realizzare un piano nazionale per le infrastrutture.
- Intervento Statale Strategico: Ripensare l’intervento dello Stato in settori chiave (terre rare, digitale, biomedicale) attraverso apposite Autorità.
- Ruolo delle Banche Cooperative: Difendere e valorizzare il ruolo delle banche cooperative (BCC e popolari).
- Modelli d’Impresa: Promuovere forme d’impresa che mettano l’occupazione al primo posto rispetto al profitto, esplorando diverse forme di proprietà.
Ma siamo sicuri che la colpa dei salari bassi sia solo delle privatizzazioni e dei lavoratori stranieri?
Il capitolo lega la questione dei salari bassi alla perdita delle grandi imprese e all’aumento dell’offerta di lavoro dall’estero. Tuttavia, la dinamica dei salari è un fenomeno complesso, influenzato da molti altri fattori non sufficientemente esplorati nel testo, come la produttività, il potere contrattuale dei lavoratori, la regolamentazione del mercato del lavoro e la struttura stessa del sistema produttivo (es. prevalenza di piccole imprese). Per approfondire, sarebbe utile studiare l’economia del lavoro e le teorie sulla distribuzione del reddito. Autori come Thomas Piketty offrono spunti sulla concentrazione della ricchezza, mentre testi di economia del lavoro analizzano i determinanti dei salari.3. Volatilità Finanziaria e Nuovi Assi della Crescita Globale
Il futuro dell’economia è segnato da un’alta instabilità finanziaria e da grandi oscillazioni che mettono a rischio i risparmi delle famiglie. Questa situazione difficile continuerà se le grandi banche non verranno cambiate, separando le loro diverse attività. L’Europa non sta intervenendo su questo punto cruciale. L’indipendenza di chi controlla le banche e le aziende è una questione importante non solo per la legge, ma anche per l’etica e la morale. Chi controlla non dovrebbe mai aspettarsi favori futuri da chi viene controllato, per garantire decisioni giuste e imparziali.Geopolitica e nuovi centri di crescita
La crescita economica nel mondo si sposta seguendo i cambiamenti nelle leadership globali, che da sempre uniscono potere militare e forza economica. Gli Stati Uniti, con le ultime presidenze, mostrano di volersi allontanare militarmente e strategicamente dall’Europa. Questo atteggiamento è visto in parte come una reazione a quello che gli americani considerano un tradimento da parte dell’Europa. Gli Stati Uniti spingono per cambiamenti nella Banca Centrale Europea e non vogliono che l’euro crolli, perché l’Europa rappresenta un mercato molto grande per i loro prodotti e servizi. L’episodio del default della Grecia viene interpretato come un avvertimento lanciato dagli USA all’Europa. Le immagini di scontri e violenza in Grecia, mostrate dai mezzi di informazione, servono a spaventare le persone comuni in Europa. La lotta tra le classi sociali non è finita; la borghesia continua a combattere contro i lavoratori, usando strumenti come l’euro e la paura che i prezzi aumentino troppo (l’inflazione).La crescita dell’economia si sta spostando verso nuove zone del mondo. È nato un grande mercato con 800 milioni di persone grazie ad accordi commerciali come il Trans-Pacific Partnership. Questo accordo lascia fuori la Cina ma include paesi come il Vietnam, l’Australia e nazioni del Sud America. L’Australia ha anche stretto un accordo militare con gli Stati Uniti perché teme un’invasione da parte della Cina. L’ingresso della Cina nell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) nel 2001 è considerato un evento che ha creato squilibri nell’economia globale. Anche la Russia è entrata nel WTO, spinta dai paesi che prima facevano parte del blocco comunista. Si prevede crescita anche in America Latina, come dimostra il caso del Brasile, la cui espansione economica è attribuita a vent’anni di buona gestione politica. L’India è vista come un paese con un grande potenziale per il futuro, grazie alla sua storia democratica. Ci sono forze che hanno contribuito a costruire la civiltà come la intendiamo oggi: il cristianesimo, che ha messo al centro la persona; l’impero britannico, che ha diffuso l’idea di legge; e le grandi aziende internazionali (multinazionali), che hanno sviluppato infrastrutture.Immigrazione, rimesse e responsabilità etica
Parlando dei soldi inviati a casa dai lavoratori stranieri, in passato le rimesse degli emigranti italiani hanno aiutato a gestire il debito dello Stato. Oggi, gli immigrati mandano denaro per favorire la crescita dei loro paesi d’origine. Si propone di controllare meglio chi arriva nel paese, prendendo esempio dall’Australia dove è richiesta la conoscenza della lingua inglese. Le persone ricche tendono a vedere l’immigrazione in modo positivo perché fa diminuire il costo del lavoro e aumenta i loro guadagni. Bloccare l’invio di denaro all’estero è difficile e potrebbe portare a movimenti illegali di valuta. È necessaria un’immigrazione gestita e sostenibile, basata su un piano sociale preciso. Questo significa stabilire, ad esempio, quanti laureati servono in certi settori professionali. Il mercato non è qualcosa di astratto, ma è fatto da persone e gruppi di persone. Questo implica che c’è una responsabilità etica da considerare nell’economia. È sempre possibile trovare soluzioni per uscire dalle crisi.Ma spostare le decisioni della Cassa Depositi e Prestiti dal consiglio di amministrazione al Parlamento risolve davvero il problema delle “mediazioni politiche”, o lo sposta semplicemente altrove?
Il capitolo propone una riforma della governance della Cassa Depositi e Prestiti suggerendo un controllo parlamentare più diretto per superare le influenze politiche nel consiglio di amministrazione. Tuttavia, non approfondisce come tale spostamento di potere possa alterare la natura dell’influenza politica, potenzialmente introducendo logiche di breve termine legate al ciclo politico o dinamiche di lobbying diverse. Per comprendere meglio le complessità della governance delle partecipate statali e il ruolo dell’intervento pubblico, è utile approfondire discipline come la scienza della pubblica amministrazione, l’economia politica e la corporate governance. Autori come Luigi Zingales hanno esplorato a fondo le intersezioni tra politica, economia e gestione aziendale in contesti come quello italiano.5. La chiave per la crescita: rinegoziare Maastricht
Si affronta la sfida di individuare le risorse necessarie per diminuire le tasse sul lavoro e sugli investimenti, e per finanziare gli interventi pubblici nell’economia, assicurando al contempo il benessere sociale per tutti. Mentre le teorie economiche talvolta non tengono conto delle persone nella loro realtà, la politica ha il dovere di farlo, considerando l’impatto concreto delle decisioni sulla vita dei cittadini.Il Trattato di Maastricht e gli investimenti
Un passo fondamentale per rispondere a questa esigenza è rinegoziare gli accordi stabiliti dal Trattato di Maastricht con i partner europei. Già in passato era stata avanzata la proposta di escludere gli investimenti destinati alle opere pubbliche dal calcolo del deficit che rileva ai fini del Trattato. Non è semplice comprendere le ragioni per cui l’attuale governo non intraprenda negoziati per ottenere questa ridefinizione delle regole del Trattato.La necessità di un accordo europeo
È indispensabile raggiungere un’intesa con gli altri Paesi europei che condividono la volontà di modificare le norme di Maastricht. Continuare a seguire la linea dettata dalla Germania senza avviare un confronto porta l’Italia in una posizione di difficoltà. In questo modo, la crescita economica del Paese non appare realizzabile. È necessario spingere la Germania verso un cambiamento di rotta nelle sue politiche economiche.L’impatto delle politiche tedesche
La Germania stessa sta affrontando le conseguenze di questa situazione, con un rallentamento della sua crescita e una diminuzione del commercio a livello mondiale. Le politiche adottate in passato hanno contribuito a impoverire gli altri Stati membri, finendo per limitare anche le esportazioni tedesche verso il resto d’Europa. Un importante politico tedesco del passato, Helmut Schmidt, criticò a suo tempo la scelta della Germania di porsi in una posizione dominante in Europa, evidenziando come ciò avrebbe causato problemi e risentimenti tra i Paesi membri.La via per la crescita
Per consentire questa rinegoziazione del Trattato, è visto come necessario un cambiamento politico sia in Germania che in Francia. Rinegoziare l’intero Trattato di Maastricht rappresenta l’unica soluzione percorribile a livello politico per stimolare la crescita economica in Italia e in Europa.Quanto è credibile presentare la rinegoziazione dell’intero Trattato di Maastricht come l'”unica soluzione percorribile” per la crescita, quando le resistenze politiche sembrano così radicate?
Il capitolo, pur individuando nella rinegoziazione del Trattato di Maastricht la chiave per la crescita, non esplora a fondo le enormi difficoltà politiche e istituzionali che un simile processo implicherebbe a livello europeo. Affermare che sia l'”unica soluzione percorribile” richiede una dimostrazione più robusta, che tenga conto delle dinamiche di potere tra gli Stati membri e delle alternative strategiche a disposizione per stimolare l’economia. Per approfondire questi temi, è fondamentale studiare l’economia politica dell’Unione Europea, le teorie dell’integrazione e le analisi critiche sull’Eurozona. Autori come Padoa-Schioppa, Pisani-Ferry o Stiglitz offrono spunti essenziali per valutare la fattibilità e le implicazioni di modifiche ai trattati.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]