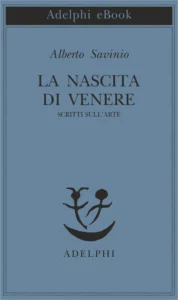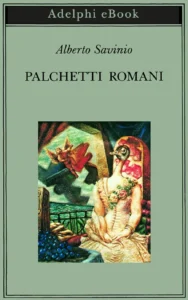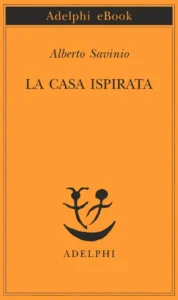Contenuti del libro
Informazioni
“Alcesti di Samuele e atti unici” di Alberto Savinio è un libro che ti sbatte in faccia domande grosse sulla vita, la morte e cosa significa essere umani, partendo da storie che sembrano teatro ma sono più vere del vero. Immagina una donna, Teresa Goerz, che nel pieno del nazismo fa un sacrificio estremo, un po’ come l’antica Alcesti, per salvare suo marito, e questo ti fa pensare subito a come certi gesti si ripetano nella storia. Savinio usa il teatro non solo come palco, ma come lente per guardare la vita stessa, dove tutti recitano e i luoghi si caricano di memoria. Poi ti porta in posti strani, tipo il “Kursaal dei Morti”, un luogo metafisico dove le personalità si sciolgono e da cui si vede una “verità nera” sulla vita, spesso vista come egoista e superficiale rispetto all’indifferenza della morte. Ma non è solo morte: c’è anche la finzione che fallisce, come quella di un tizio che prova a sostituirsi a un amico morto, o la noia assurda di certe famiglie, o legami madre-figlio complicatissimi che tornano dopo anni. Attraverso questi “atti unici”, Savinio esplora il sacrificio moderno, la relazione tra teatro e vita, la morte e memoria, e la lotta tra verità e illusione, mostrandoti come i legami familiari e le crisi (anche storiche come il nazismo) si intreccino con queste riflessioni profonde. È un viaggio un po’ surreale ma super stimolante su cosa resta di noi e delle nostre azioni.Riassunto Breve
C’è una differenza tra come si vede la vita da vivi e come si vede la morte da morti. La morte non è una fine spaventosa, ma un passaggio dove la personalità si scioglie, anche se per alcuni con personalità forte ci vuole tempo in un posto speciale per dissolversi. Dalla morte si vede la “verità interna” delle cose, una “verità nera”. I vivi, visti da questo stato, sembrano intrappolati nell’egoismo e nella superficialità, non capiscono l’indifferenza che si trova nella morte. La verità vista dalla morte porta a una sorta di “pazzia” nel mondo dei vivi. Un sacrificio come quello di una donna ebrea che si toglie la vita per salvare il marito dalle leggi razziali, richiamando l’antica storia di Alcesti, è un atto consapevole e ragionato, una “volontà di essere” contro i regimi totalitari, un “capolavoro” personale. Questo atto ha un valore inafferrabile e permette al marito di continuare a vivere, ma il suo ritorno o la sua presenza tra i vivi appare innaturale. Il teatro è un luogo dove la tragedia umana si manifesta in modo potente, dove la linea tra chi agisce e chi guarda scompare, e dove la vita stessa è vista come uno spettacolo continuo. Viene visto anche come un modo per “correggere” la vita, permettendo ai morti di apparire vivi. I vivi spesso rappresentano la morte in modo falso e offensivo, basato sull’orgoglio di essere ancora vivi. La vera esistenza e la felicità si trovano oltre la vita, in unione totale. I legami familiari della vita sono visti come errori e assurdità che si sciolgono nella morte. Un uomo con un eccesso d’intelligenza cerca di dare senso alla sua vita sostituendosi a un amico morto per avere i suoi soldi e la sua fidanzata, costruendo una finzione basata sul ricordo idealizzato dell’amico. Legge le lettere per capire la donna e la vera natura del rapporto, scoprendo che l’amico era mantenuto da lei. Durante l’incontro, l’uomo crea una falsa storia sulla morte eroica dell’amico, ma commette un errore fatale dicendo che l’ultima parola dell’amico era il nome della donna. Quando lei insiste per sentirlo pronunciare, l’uomo è costretto a rivelare la verità: l’ultima parola era il ridicolo cognome dell’amico, Chiappadoro. Questa verità assurda distrugge l’illusione della donna e manda in rovina il piano dell’uomo, che si ritira sconfitto dalla realtà che lui stesso ha svelato. La vita può essere caratterizzata da profonda noia e mancanza di vitalità, con persone che vivono in attesa passiva, quasi desiderando un evento traumatico per spezzare la monotonia. Anche i legami familiari in vita sono complicati e pieni di ostilità, come una madre che aspetta un figlio assente da quindici anni, vedendolo come il suo “vero uomo” e trasformandosi fisicamente per accoglierlo, mentre gli abiti del figlio, conservati come memoria, cadono a terra.Riassunto Lungo
1. Il Sacrificio Moderno e la Natura del Teatro
Una donna, Teresa Goerz, ebrea e moglie di un editore tedesco, si toglie la vita durante il regime nazista. Il suo gesto è consapevole e ragionato, compiuto per liberare il marito dalle leggi razziali che lo costringono a scegliere tra il divorzio e la perdita del lavoro. Sceglie di entrare nel fiume, vedendo la Germania come una terra che soffoca e porta alla pazzia. La sua morte non è un atto di disperazione, ma un mezzo per raggiungere la libertà e compiere un’opera personale, quasi un “capolavoro” interiore.Un’eco dell’antichità
Questo atto richiama l’antica storia di Alcesti, che muore volontariamente per salvare la vita del marito Admeto. Il sacrificio moderno di Teresa Goerz dimostra che l’esempio di Alcesti non è unico nella storia, ma rappresenta un tipo di azione che si ripete. Anche di fronte alla “sciocchezza” distruttiva del nazismo, un atto di bene e sacrificio mantiene un valore inafferrabile.La vita come teatro tragico
In questo contesto, la vita stessa appare come uno spettacolo continuo dove tutti sono attori. Il teatro non è solo un luogo di rappresentazione, ma uno spazio dove la tragedia umana si manifesta in modo diretto e potente. La distinzione tra chi agisce sulla scena e chi guarda dalla sala scompare. Le parole e i pensieri delle persone rimangono legati ai luoghi, creando una sorta di memoria persistente.L’impatto del sacrificio
L’atto di Teresa ha un impatto che va oltre la sua persona, coinvolgendo chi ne viene a conoscenza. La sua morte permette al marito di continuare a vivere, e la sua memoria vive attraverso di lui e il suo gesto. I figli reagiscono con dolore alla perdita, mentre i genitori mostrano indifferenza o preoccupazione egoistica, evidenziando la complessità dei legami familiari di fronte a una tragedia così grande.È sufficiente definire il nazismo una mera “sciocchezza” e un atto di suicidio sotto la sua pressione un “capolavoro”?
Il capitolo, nel tentativo di trovare un parallelo antico per un gesto tragico, rischia di minimizzare la specificità e la brutalità del regime nazista, riducendolo a una generica “sciocchezza”. Questo approccio non rende giustizia alla complessità storica e ideologica che ha portato a tali tragedie. Inoltre, la valutazione etica e filosofica di un atto estremo come il suicidio in un contesto di persecuzione sistematica merita un’analisi più approfondita, che vada oltre la semplice equiparazione a un “capolavoro” o a un sacrificio mitologico. Per comprendere meglio questi temi, sarebbe utile approfondire la storia del nazismo, l’etica della resistenza e del sacrificio, e le riflessioni sulla condizione umana in situazioni estreme, magari leggendo autori come Hannah Arendt o Primo Levi.2. Il Kursaal dei Morti e la Verità Nera
L’Europa, nel suo modo di pensare e vivere, si è spostata dall’Oriente all’Occidente, trovando oggi la sua sede in America. L’Asia è vista come il polo opposto, capace di portare in Europa ‘tumori’ ideologici, come è accaduto con il nazismo, curato grazie all’intervento dell’America. Gli Americani sono descritti come conquistatori ideali, non perché impongono idee fisse, ma perché agiscono in modo passivo e accogliente, quasi come i Romani. Questa attitudine di ‘credere a tutto’ è paragonata al ‘non credere a niente’, una condizione considerata saggia. Inoltre, l’Europa si distingue dall’Asia per il modo in cui concepisce il divino: l’Europa divide Dio in molti dèi, quasi rendendo ogni uomo un piccolo dio, mentre l’Asia mantiene un Dio unico e tende a forme di governo basate sulla religione.Il passaggio della morte e il Kursaal
La morte è vista come un passaggio in cui la personalità di una persona si dissolve. Esiste un luogo chiamato Kursaal dei Morti, destinato a coloro la cui personalità è particolarmente forte. Queste personalità forti hanno bisogno di più tempo per dissolversi completamente dopo la morte. La personalità, in questo contesto, è considerata un ostacolo a una morte piena e completa. Le anime che si trovano nel Kursaal dei Morti desiderano raggiungere uno stato di indifferenza e l’annientamento della propria individualità.Crisi e cambiamenti nel mondo
Il mondo attraversa una crisi profonda che provoca notevoli cambiamenti politici e sociali. Le guerre sono interpretate come semplici lotte per il dominio politico tra le nazioni. Tuttavia, al di là di queste, persiste una crisi sociale più radicale, che spinge verso un modo di vivere più in armonia con la natura. Persino la natura stessa sembra trasformarsi insieme ai cambiamenti umani. Questa situazione di crisi generale fa da sfondo agli eventi descritti.Il caso di Teresa Goerz e il ritorno
Il concetto di teatro viene usato per spiegare come i morti possano apparire vivi, quasi come se il teatro potesse correggere o alterare la realtà della vita e della morte. Viene presentato il caso di Roosevelt, che, pur essendo morto, è ancora presente e ha il compito di riportare in vita Teresa Goerz. Teresa si era suicidata per salvare suo marito dalle leggi razziali. La sua figura viene paragonata a quella mitologica di Alcesti, e il suo ritorno avviene attraverso il suo ritratto. Il suo gesto estremo è visto come un atto di profondo sacrificio per amore.La verità vista dalla morte
Guardando dal punto di vista della morte, il suicidio di Teresa Goerz assume il significato di un atto di ‘volontà di essere’, una forma di resistenza contro i regimi totalitari. Il suo ritorno tra i vivi, tuttavia, è considerato un’inversione innaturale dell’ordine delle cose. Dallo stato di morte, si ha accesso a una ‘verità interna’ sulle cose e sul mondo. Viene introdotto il concetto che la vera ‘lotta di classe’ sia quella tra i vivi e i morti, una lotta per la dignità della morte stessa. Teresa, una volta tornata in vita, prova orrore per i vivi, che le appaiono intrappolati nell’egoismo e nella superficialità. I vivi sembrano incapaci di comprendere la sua nuova condizione di indifferenza, acquisita dopo la morte. Questa ‘verità’ vista dall’interno del regno dei morti, se riportata nel mondo dei vivi, può portare a quella che appare come ‘pazzia’.Come possono affermazioni su un “Kursaal dei Morti” o sul ritorno dei defunti essere considerate “verità” senza alcuna base logica o riscontro?
Il capitolo presenta una serie di concetti radicalmente estranei alla comprensione comune della vita e della morte, introducendo elementi come luoghi post-mortem specifici per la dissoluzione della personalità o la possibilità di un ritorno fisico dei defunti tramite oggetti. Queste affermazioni, pur potendo avere un valore metaforico o narrativo, vengono accostate a una presunta “verità” accessibile solo dallo stato di morte, creando una notevole dissonanza. Per comprendere meglio il contesto in cui tali idee possono emergere o avere significato, sarebbe utile esplorare ambiti come la filosofia (in particolare la metafisica e l’ontologia), gli studi sulle credenze escatologiche nelle diverse culture e religioni, o la teoria letteraria che analizza come i testi costruiscono realtà alternative. Pensatori che hanno indagato la natura della coscienza, l’aldilà o il rapporto tra realtà e rappresentazione potrebbero offrire spunti per inquadrare queste tematiche.3. Il Fallimento della Finzione
La rappresentazione della morte fatta dai vivi è vista come falsa e offensiva, nata dall’orgoglio di chi è ancora in vita. La vera esistenza e la vera felicità si trovano oltre la vita terrena, in uno stato di unione completa. La morte non è una fine da temere, ma un destino atteso e desiderato, quasi una “promozione” a una condizione superiore. I legami familiari che esistono in vita, come quelli tra genitori e figli, sono considerati errori o assurdità che svaniscono con la morte, perché le strade si separano. Un legame si ricrea solo nel ricordo di chi resta in vita, quando i figli, crescendo, diventano a loro volta genitori e si avvicinano anch’essi alla fine.Un piano basato sull’inganno
Un uomo, che soffre di un “eccesso d’intelligenza” e si sente divorato dalla noia, cerca di dare un senso alla sua esistenza ripensando a un’occasione che ha perso. Per farlo, va in una città isolata per incontrare la fidanzata di un suo amico, Enrico, che è morto lontano. L’uomo ha un piano: vuole prendere il posto di Enrico nella vita della donna e ottenere la sua ricchezza, sfruttando il ricordo idealizzato che lei ha dell’amico scomparso. Legge le lettere di Enrico per capire meglio il carattere della donna e la vera natura del loro rapporto. Scopre così che Enrico era mantenuto da lei e che tra loro non c’erano stati rapporti intimi.Durante l’incontro, l’uomo costruisce una storia falsa sulla vita di Enrico e sulla sua morte eroica, cercando di presentarsi come una specie di sua continuazione. La donna, immersa nel suo dolore e nelle sue illusioni, gli chiede quale sia stata l’ultima parola di Enrico. L’uomo, volendo rendere la sua invenzione più convincente, risponde che Enrico ha pronunciato il nome di lei. Questo tentativo di esagerare si rivela un errore decisivo. Quando la donna insiste per sentir pronunciare quel nome, l’uomo è costretto a dire la verità: l’ultima parola di Enrico non era il nome idealizzato che lei immaginava, ma il suo cognome, che era ridicolo, Chiappadoro. Questa verità assurda distrugge l’illusione della donna e manda in fumo il piano dell’uomo, che si ritira sconfitto dalla realtà che lui stesso ha finito per rivelare.
[/membership]Come si possono affermare verità definitive sull’aldilà e sulla dissoluzione dei legami terreni senza offrire alcuna base oltre la mera asserzione?
Il capitolo presenta affermazioni perentorie sulla natura della morte, sull’aldilà e sul valore (o disvalore) dei legami terreni, trattandole come verità assodate. Tuttavia, tali asserzioni si collocano nell’ambito della metafisica e della fede, non della logica o dell’indagine empirica. Non vengono fornite argomentazioni o elementi che possano giustificarle razionalmente. Per affrontare la complessità di questi temi, è fondamentale esplorare le diverse posizioni filosofiche e culturali sulla morte e sull’esistenza. Utile potrebbe essere la lettura di autori che hanno meditato profondamente sul senso della vita e sulla fine, come Schopenhauer, per il suo approccio alla volontà e alla rappresentazione, o Camus, per la sua riflessione sull’assurdo e sulla rivolta. È altresì importante confrontarsi con le diverse visioni religiose e spirituali sull’aldilà, riconoscendone la natura di sistemi di credenze.4. L’immobilità e il ritorno
Una famiglia vive immersa nella noia e nella mancanza di energia. Le loro giornate si ripetono sempre uguali, senza che i membri parlino o si salutino tra loro. Non si interessano a nulla di ciò che accade fuori, nemmeno alle guerre importanti. La morte della nonna rompe per un po’ questa routine. Ci sono visite e preparativi per il funerale, ma è un cambiamento breve. Subito dopo, la famiglia torna alla solita apatia. Solo il figlio Michelino, chiamato “deficiente”, mostra un po’ di vita. Le sue azioni e parole sembrano dire una verità: la famiglia aspetta senza fare nulla, quasi sperando in qualcosa di brutto che rompa la monotonia.L’attesa della madre
Intanto, una madre aspetta il figlio che manca da quindici anni e non si è fatto sentire. Il figlio se n’è andato perché le era ostile e cerca donne che le assomigliano. La madre ricorda quando lo salvò dalla polizia durante la guerra, mettendosi in pericolo. Per lei, quello fu un “miracolo”, un modo profondo di comunicare, una “verità” detta con il corpo. Vede il figlio come il suo “vero uomo”, al posto del padre. Prima che arrivi, si trucca e si mette un vestito da sera, cambiando il suo aspetto trascurato. Vuole apparire splendida per accogliere il figlio, che chiama il suo “torello”, il suo uomo. I vestiti del figlio, tenuti da parte per ricordare la sua vita lontana, cadono per terra mentre la madre si nasconde nel buio ad aspettarlo.
Data la lunga assenza e l’ostilità del figlio, è psicologicamente credibile l’idealizzazione della madre che lo attende come il suo “vero uomo”, senza un approfondimento delle dinamiche sottostanti?
Il capitolo descrive un’attesa materna carica di significati psicologici intensi, quasi patologici, come l’idealizzazione del figlio assente e ostile e la sua percezione come sostituto della figura paterna. Questa rappresentazione, pur potente, solleva interrogativi sulla sua plausibilità senza un maggiore contesto sulle dinamiche familiari e i meccanismi di attaccamento. Per comprendere meglio tali complessità, sarebbe utile approfondire discipline come la psicologia familiare e la psicoanalisi, leggendo autori come Freud o Bowlby.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]