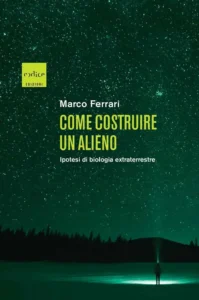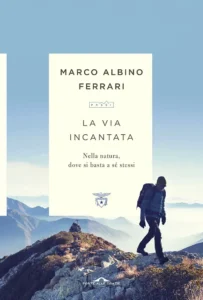1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Ahi, Sudamerica! Oriundi, tango e fútbol” di Marco Ferrari racconta una storia incredibile che lega l’Italia al Sudamerica attraverso il calcio. Immagina l’impatto enorme dell’emigrazione italiana su città come Buenos Aires e San Paolo, non solo nell’architettura o nella cultura, ma proprio nella nascita di club leggendari come Boca Juniors, River Plate, Palmeiras e San Lorenzo. Questo libro ti porta a scoprire come i liguri hanno plasmato La Boca, come un prete torinese ha fondato il San Lorenzo, o come i piemontesi hanno dato vita al Peñarol a Montevideo. Ma la storia non finisce qui: è un ponte sull’Atlantico. Vedrai come il calcio italiano ha cercato e accolto gli oriundi, giocatori con radici italiane nati in Argentina, Uruguay o Brasile, che sono tornati per diventare campioni in Serie A e anche nella nazionale italiana, vincendo Mondiali. Figure come Sivori, Altafini, Schiaffino, Ghiggia, Orsi e Monti prendono vita, con le loro magie in campo ma anche le loro vite complicate, divise tra due mondi. Non mancano storie di allenatori italiani che hanno lasciato il segno nel calcio sudamericano o di “bidoni” che non hanno funzionato. E poi c’è il legame profondo tra calcio, tango e persino la politica, mostrando quanto il fútbol sia radicato nella società sudamericana. È un viaggio affascinante tra passione, identità e pallone, che ti fa capire quanto l’eredità italiana sia viva nel cuore del calcio sudamericano e viceversa.Riassunto Breve
L’emigrazione italiana influenza profondamente la formazione di città e club calcistici in Sudamerica. A Buenos Aires, il quartiere della Boca, abitato da liguri, vede nascere Boca Juniors e River Plate, con fondatori e giocatori di origine italiana. A San Lorenzo, un prete salesiano figlio di emigranti torinesi fonda il club. A San Paolo, la numerosa comunità italiana crea la Società Sportiva Palestra Italia, poi Palmeiras, dopo le tournée di squadre italiane. L’influenza si estende all’urbanistica con architetti italiani che progettano edifici importanti. Nel secondo dopoguerra, l’immigrazione italiana in Venezuela porta alla nascita del Deportivo Italia, che ottiene successi e partecipa alla Copa Libertadores. In Paraguay, allenatori italiani come Vessillo Bartoli guidano squadre e la nazionale. In Uruguay, i legami con l’Italia sono forti; il Club Atlético Peñarol nasce per iniziativa di soci piemontesi, e giocatori di origine italiana contribuiscono ai successi della nazionale, inclusa la vittoria del primo Mondiale nel 1930. Il calcio italiano vede poi il ritorno di giocatori con origini italiane nati all’estero, gli oriundi. Arnaldo Porta è un primo esempio, seguito dai fratelli Badini a Bologna. Attila Sallustro diventa un idolo a Napoli. Il Torino si rafforza con il “Trio delle meraviglie”, tra cui Julio Libonatti, primo oriundo nella nazionale italiana. Negli anni Trenta, la ricerca di oriundi in Sudamerica diventa sistematica, stimolata anche dal Mondiale 1930. Giocatori come Raimundo Orsi e Luis Monti arrivano alla Juventus, vincono scudetti e il Mondiale 1934 con l’Italia, con Monti unico a giocare due finali mondiali per paesi diversi. Renato Cesarini è noto per la “Zona Cesarini”. Il regime fascista usa gli oriundi per propaganda, ma la loro posizione è complessa, come dimostra la fuga di alcuni giocatori per evitare la chiamata alle armi. Dopo la guerra, il ponte sull’Atlantico continua. Bruno Pesaola, nato in Argentina, gioca e allena in Italia, vincendo uno scudetto. Gli uruguayani Alcides Ghiggia e Juan Alberto Schiaffino, protagonisti del “Maracanazo” del 1950, giocano poi in Italia. Negli anni Cinquanta arrivano gli “angeli dalla faccia sporca” argentini come Omar Sivori, Humberto Maschio e Antonio Valentín Angelillo, che lasciano un segno nel campionato italiano, nonostante le difficoltà di adattamento o i dissidi. Anche oriundi brasiliani come José Altafini hanno carriere di successo. Non tutte le esperienze sono positive; la Sampdoria ingaggia giocatori con scarso successo, e l’Inter acquista i “cinque bidoni” uruguayani, un episodio che contribuisce a definire il termine per un giocatore deludente. Il calcio lega anche Argentina e Uruguay all’Italia attraverso la cultura, come nel tango che celebra squadre e giocatori. In Sudamerica, il calcio si intreccia con il potere politico; presidenti di club come Mauricio Macri usano la popolarità per carriere politiche. Regimi militari in Brasile e Cile usano il calcio per propaganda e controllo, con episodi come l’Estadio Nacional usato come centro di detenzione e la “partita fantasma”. Storie personali, come la ricerca delle origini italiane di Lionel Messi, evidenziano le complessità legate all’emigrazione e all’identità.Riassunto Lungo
1. Radici Italiane del Calcio Rioplatense e Paulista
L’arrivo degli emigranti italiani ha cambiato profondamente il volto di città come Buenos Aires e San Paolo. Queste comunità hanno lasciato un segno visibile nell’aspetto delle città, nella loro cultura e, in modo particolare, nello sport. L’influenza si è sentita nell’urbanistica, con nuovi quartieri e stili architettonici, e ha dato vita a tradizioni culturali uniche. Soprattutto, l’energia e la passione degli italiani hanno contribuito in modo decisivo alla nascita e allo sviluppo del calcio, diventato poi lo sport nazionale in questi paesi. Questo legame tra emigrazione e sport è evidente nella storia di molti club celebri.Il Calcio a Buenos Aires: Boca e River
Nel quartiere della Boca a Buenos Aires, dove si stabilirono molti liguri, prese forma la passione per il calcio. Qui, il 3 aprile 1905, nacque il Boca Juniors, fondato da giovani per lo più di origine ligure, tra cui Esteban Baglietto e i fratelli Farenga. Il soprannome “xeneizes” (genovesi) ricorda proprio le radici del quartiere e dei suoi fondatori. Persino i primi elementi del campo, come le porte, furono realizzati grazie all’aiuto di un falegname arrivato dalla Liguria. I colori blu e giallo, scelti in modo originale, si ispirarono a quelli della prima nave svedese vista attraccare nel porto. Nello stesso quartiere della Boca era già nato nel 1901 il River Plate, frutto della fusione di squadre locali. Anche se in seguito si spostò, il River Plate mantenne legami iniziali con la comunità italiana, avendo un genovese come primo presidente e diversi giocatori di origine ligure nelle sue prime formazioni.San Lorenzo: L’Oratorio e il Calcio
Un’altra storia legata all’emigrazione italiana è quella del San Lorenzo, il club molto amato anche da Papa Francesco. Questo club vide la luce nel 1908 grazie all’iniziativa di padre Lorenzo Massa, un prete salesiano i cui genitori erano emigrati da Torino. Vedendo un gruppo di ragazzi giocare per strada in modo pericoloso, padre Massa offrì loro un luogo sicuro: il cortile del suo oratorio. Fu lì che il club mosse i suoi primi passi, diventando un punto di riferimento per la comunità. I colori scelti per la squadra, l’azzurro e il rosso, non furono casuali ma si ispirarono direttamente alla figura della Vergine Maria Ausiliatrice, molto venerata da San Giovanni Bosco e legata alla spiritualità salesiana.Il Calcio a San Paolo: La Palestra Italia diventa Palmeiras
A San Paolo, all’inizio del Novecento, la comunità italiana era la più numerosa e attiva in città. Fu proprio questa grande comunità a fondare nel 1914 la Società Sportiva Palestra Italia. L’idea prese slancio anche grazie alle tournée in Brasile di squadre italiane come Pro Vercelli e Torino, che mostrarono la bellezza del calcio e ne diffusero la pratica nel paese. La Palestra Italia divenne rapidamente un club importante, simbolo dell’orgoglio italiano a San Paolo. Durante il periodo difficile della Seconda Guerra Mondiale, a causa del clima ostile verso l’Italia, il club fu costretto a cambiare nome e anche i suoi colori. Nonostante questo cambiamento forzato, la squadra, rinominata Palmeiras, ha mantenuto nel tempo una fortissima identità e un legame profondo con le sue origini legate all’immigrazione italiana.L’Impronta Italiana nell’Architettura e nella Società
L’influenza italiana non si limitò solo al calcio, ma lasciò un segno indelebile anche nell’architettura di Buenos Aires. Edifici imponenti e significativi furono progettati da architetti italiani, come il Palazzo Barolo, la cui struttura e simbolismo si ispirano in modo affascinante alla Divina Commedia di Dante Alighieri. Un altro luogo simbolo è l’Hotel de los Inmigrantes, che servì come primo punto di accoglienza per milioni di italiani appena arrivati nel nuovo continente. Questi elementi tangibili testimoniano il ruolo fondamentale che gli emigranti italiani ebbero nella costruzione e nello sviluppo delle grandi metropoli sudamericane. La loro energia e il loro lavoro contribuirono in modo essenziale a plasmare non solo l’aspetto fisico delle città, ma anche il loro tessuto sociale e culturale, di cui lo sport è un esempio brillante.Ma siamo sicuri che l’influenza italiana sia stata davvero così decisiva e unica, o il capitolo non rischia di semplificare un quadro ben più complesso?
Il capitolo presenta un quadro convincente del contributo italiano alla nascita del calcio in Argentina e Brasile, ma l’enfasi quasi esclusiva su questa origine rischia di trascurare altri fattori cruciali. La nascita e l’affermazione di uno sport nazionale sono processi complessi, influenzati da molteplici correnti migratorie, dalle condizioni sociali ed economiche locali, e dalle dinamiche interne delle città. Per avere una visione più completa, sarebbe utile esplorare il ruolo di altre comunità di immigrati (spagnoli, portoghesi, tedeschi, ecc.) e approfondire la storia sociale e urbana di Buenos Aires e San Paolo nel periodo considerato. Autori che si occupano di storia delle migrazioni, storia urbana e sociologia dello sport possono offrire prospettive più ampie.2. L’Onda Italiana nel Calcio Sudamericano
Nel secondo dopoguerra, un gran numero di immigrati europei raggiunge il Venezuela. Tra questi, oltre 252 mila italiani formano la comunità straniera più numerosa del paese. Questa forte presenza italiana si manifesta in diversi aspetti della società, incluso il mondo del calcio, dove l’influenza diventa significativa.L’Impatto in Venezuela con il Deportivo Italia
L’interesse per il calcio porta alla nascita del Deportivo Italia a Caracas nel 1948. Sotto la guida dei fratelli Mino e Pompeo D’Ambrosio, originari di Caserta, la squadra vive un periodo d’oro tra il 1958 e il 1978. Il Deportivo Italia conquista diversi campionati nazionali e partecipa con successo alla prestigiosa Copa Libertadores. Un momento memorabile è la storica vittoria per 1-0 contro i brasiliani del Fluminense allo stadio Maracanã nel 1971. In quella partita, la prestazione decisiva del portiere italo-venezuelano Vito Fasano è fondamentale. L’apporto degli italiani si estende anche alla nazionale venezuelana, dove giocatori di origine italiana contribuiscono attivamente.L’Influenza Italiana nel Calcio Paraguaiano
Anche in Paraguay, la presenza italiana si fa sentire in vari settori, compreso il calcio. L’allenatore italiano Vessillo Bartoli lascia un segno importante guidando lo Sportivo Luqueño alla vittoria di due campionati nazionali nei primi anni Cinquanta. Bartoli assume anche il ruolo di commissario tecnico della nazionale paraguayana. Dopo essere rientrato in Italia a seguito di un incidente aereo, Bartoli torna in Sudamerica, dove continua la sua carriera vincente. Conquista un altro campionato in Paraguay alla guida del Cerro Porteño e ottiene successi in Ecuador con l’Universidad Católica e il Nacional. È noto per aver introdotto nuove tattiche di gioco nel calcio sudamericano.I Forti Legami tra Italia e Uruguay
L’Uruguay ha legami profondi con l’Italia che risalgono all’epoca coloniale, con figure come Jorge Burgues. La capitale Montevideo presenta caratteristiche urbanistiche che ricordano diverse città italiane. L’immigrazione italiana ha contribuito in modo sostanziale alla formazione della società uruguayana, portando alla creazione di un’identità italo-uruguayana distintiva. Molti cittadini uruguayani possiedono la doppia cittadinanza e l’integrazione culturale tra le due comunità è molto forte. Questa presenza si riflette anche nell’ambito sportivo.L’Apporto Italiano al Successo del Calcio Uruguayano
Sebbene l’organizzazione iniziale del calcio in Uruguay sia stata influenzata dai britannici, gli italiani hanno giocato un ruolo cruciale nel suo sviluppo. Il Club Atlético Peñarol, una delle squadre più gloriose del paese, nasce dalla trasformazione di un club ferroviario per iniziativa di soci di origine piemontese. L’Uruguay emerge rapidamente come una potenza calcistica mondiale, vincendo titoli olimpici e il primo Campionato Mondiale nel 1930. Durante questo periodo d’oro, figure di origine italiana sono presenti sia nello staff tecnico che tra i giocatori della nazionale uruguayana. Nella finale del Mondiale del 1930, molti giocatori di entrambe le squadre, Uruguay e Argentina, portano cognomi italiani. L’influenza italiana nel calcio sudamericano si estende ulteriormente, contribuendo alla fondazione di altri club in paesi come Cile e Perù.Ma quanto è stata davvero decisiva questa “onda italiana” rispetto a tutte le altre forze che hanno plasmato il calcio sudamericano?
Il capitolo elenca innegabili esempi di presenza e successo di figure e club legati all’immigrazione italiana, ma l’argomentazione sulla portata complessiva e decisiva di tale influenza manca di un confronto approfondito con altri fattori cruciali. La storia del calcio in Sudamerica è un intreccio complesso di tradizioni locali, altre correnti migratorie (britannica in primis, ma non solo), evoluzioni tattiche globali e contesti socio-economici specifici di ogni paese. Per valutare l’effettivo peso dell’apporto italiano, sarebbe necessario analizzare in modo più sistematico come si sia inserito e confrontato con queste altre componenti. Approfondire la storia sociale e sportiva dei singoli paesi sudamericani, studiando autori che si occupano di storia delle migrazioni e di sociologia dello sport, permetterebbe di collocare l’influenza italiana nel suo contesto più ampio e di valutarne la reale incidenza.3. Campioni tra due mondi: storie di oriundi nel calcio italiano
Il calcio italiano assiste al ritorno di giocatori con origini italiane che arrivano dall’estero. Questo fenomeno vede l’arrivo di figure che lasceranno un segno importante nella storia dei club e della nazionale.I primi arrivi e la famiglia Badini
Tra i primi a tornare c’è Arnaldo Porta, che nel 1914 si unisce al Verona arrivando dal Brasile. Un rientro particolarmente significativo riguarda la famiglia Badini dall’Argentina. Angelo Badini, conosciuto come “Il Professore”, diventa una figura centrale per il Bologna, ricoprendo il ruolo di capitano dal 1913 al 1921. È un centromediano con visione tattica, ma anche un architetto fuori dal campo, e guida la squadra con intelligenza. La sua morte prematura nel 1921, a causa di setticemia, provoca un profondo dolore e il campo del Bologna viene intitolato in suo onore. Anche suo fratello Emilio Badini, soprannominato “Farfallino”, gioca nel Bologna ed è il primo giocatore del club a vestire la maglia della nazionale italiana, partecipando alle Olimpiadi del 1920. Purtroppo, un infortunio al ginocchio pone fine precocemente alla sua carriera.Attila Sallustro, l’idolo di Napoli
Un’altra figura che incarna questo ritorno è Attila Sallustro, figlio di emigrati italiani in Paraguay. Cresciuto ad Asunción, torna in Italia per giocare prima nell’Internaples e poi nel Napoli dal 1926 al 1937. Diventa rapidamente il centravanti della squadra, soprannominato “El Gargo” o “Veltro” per la sua velocità, e conquista l’affetto incondizionato della città, diventandone un vero idolo. Inizialmente, per volere del padre, gioca senza ricevere uno stipendio. Con il Napoli segna 106 gol e prende parte alle Olimpiadi del 1928. La sua vita privata lo vede sposare la ballerina Lucy D’Albert. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, continua a legare il suo nome al club ricoprendo l’incarico di direttore amministrativo dello stadio San Paolo.Il “Trio delle meraviglie” del Torino
Anche il Torino si rafforza notevolmente grazie all’arrivo di giocatori con origini italiane dall’estero, formando un gruppo passato alla storia come il “Trio delle meraviglie”: Julio Libonatti, Adolfo Baloncieri e Gino Rossetti. Libonatti, italo-argentino, arriva nel 1925 e si dimostra un realizzatore eccezionale, diventando il primo oriundo sudamericano a giocare nella nazionale italiana. Baloncieri, pur essendo nato in Italia, cresce in Argentina e si afferma come un giocatore di grande intelligenza tattica, diventando un punto di riferimento fondamentale per Libonatti in campo. Gino Rossetti completa il trio d’attacco. Insieme, questi tre giocatori segnano ben 385 gol per il Torino e sono protagonisti della vittoria di due campionati, sebbene uno di questi venga successivamente revocato. Queste figure rappresentano i primi, grandi “oriundi” che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia del calcio italiano.Il talento degli oriundi ha arricchito la Serie A, ma la loro presenza in Nazionale ha scatenato polemiche e fallimenti. Era una questione di campo o di identità nazionale?
Il capitolo accenna alla complessa integrazione degli oriundi nella nazionale italiana, legandola alla delusione del 1962. Tuttavia, non approfondisce le feroci polemiche che si scatenarono all’epoca, mettendo in discussione non solo le scelte tecniche, ma l’idea stessa di rappresentanza nazionale. Per comprendere appieno questa tensione, è fondamentale esplorare la storia del calcio italiano nel suo contesto sociale e politico, analizzando come la questione dell’identità nazionale si sia intrecciata con lo sport. Approfondire la sociologia dello sport e la storia dell’identità italiana può offrire spunti cruciali. Autori che hanno studiato la storia sociale del calcio in Italia possono fornire il quadro necessario.10. Calcio e Potere in Sudamerica
In Sudamerica, il calcio si intreccia profondamente con la sfera del potere, offrendo spesso una strada verso la carriera politica.Il calcio come trampolino politico
Molte figure hanno sfruttato la popolarità e l’influenza derivante dalla presidenza di importanti club calcistici per costruire consenso e lanciarsi in politica a livello nazionale. È il caso di Mauricio Macri in Argentina, che ha guidato il Boca Juniors alla vittoria di numerosi titoli prima di diventare capo del governo di Buenos Aires e, successivamente, presidente dell’Argentina. Allo stesso modo, Sebastián Piñera è diventato azionista di maggioranza del Colo Colo in Cile prima di essere eletto presidente. In Paraguay, Horacio Cartes ha presieduto il Club Libertad e le nazionali paraguiane prima di raggiungere la presidenza del paese. Queste esperienze dimostrano come il successo nel mondo del calcio possa tradursi in un significativo capitale politico e popolarità, facilitando l’ascesa a cariche istituzionali di alto livello.Il calcio sotto le dittature militari
Il legame tra calcio e potere si manifesta in modo drammatico anche durante i regimi autoritari. Dittature militari, come quella dei Gorilas in Brasile o quella di Pinochet in Cile, hanno utilizzato il calcio come strumento di propaganda e controllo sociale. In Brasile, il regime ha investito nella costruzione di grandi stadi e ha cercato di influenzare le decisioni tecniche della nazionale per sfruttarne i successi a proprio favore. Calciatori che hanno espresso posizioni critiche nei confronti del regime, come Afonsinho, Reinaldo e Nando Coimbra, hanno subito discriminazioni o vere e proprie persecuzioni, a testimonianza del tentativo del potere di silenziare ogni forma di dissenso anche all’interno del mondo sportivo.Resistenza e repressione nel calcio
Nonostante la repressione, il calcio è stato anche teatro di atti di resistenza. La “Democrazia Corinthiana”, un movimento di autogestione guidato dal calciatore Sócrates all’interno del club Corinthians, ha rappresentato un esempio unico di partecipazione democratica e opposizione interna al regime militare brasiliano, promuovendo valori di libertà e uguaglianza. In Cile, dopo il golpe del 1973, lo Stadio Nacional di Santiago è stato trasformato in un vasto centro di detenzione e tortura, un simbolo della brutalità del regime. In questo luogo si è svolta la tristemente nota “partita fantasma” tra Cile e URSS per le qualificazioni mondiali, con il Cile che ha segnato un gol a porta vuota dopo il rifiuto dell’Unione Sovietica di giocare in uno stadio usato per la repressione. Giocatori cileni come Carlos Caszely e Francisco Valdés hanno vissuto in prima persona quella realtà, con Caszely che ha compiuto un gesto di coraggioso dissenso rifiutando di stringere la mano al generale Pinochet durante una cerimonia ufficiale.Storie personali e legami con l’emigrazione
Accanto ai grandi eventi politici, si intrecciano storie personali che evidenziano altri legami tra calcio, Sudamerica e le sue radici. La storia della famiglia di Lionel Messi, ad esempio, risale all’emigrazione dalle Marche, in Italia, verso l’Argentina all’inizio del Novecento. La ricerca delle origini italiane di Messi, motivata anche dall’ottenimento della cittadinanza, mette in luce le difficoltà che spesso si incontrano nel ricostruire le vicende familiari legate ai grandi flussi migratori. Nonostante queste complessità, il celebre calciatore risulta iscritto all’anagrafe italiana dei residenti all’estero, un dettaglio che unisce la storia della sua famiglia a quella di milioni di emigrati italiani in Sudamerica.Ma la storia della famiglia Messi e dell’emigrazione italiana, per quanto interessante, come si lega logicamente al tema del potere politico trattato in precedenza?
Il capitolo, dopo aver esplorato i complessi legami tra calcio, politica e regimi autoritari, introduce la storia personale di Lionel Messi e le sue origini italiane. Questa sezione appare slegata dal filo conduttore principale sul ‘potere’. Non viene chiarito in che modo le vicende familiari legate all’emigrazione e l’ottenimento della cittadinanza italiana si inseriscano nell’analisi delle dinamiche di potere politico o sociale in Sudamerica. Per comprendere meglio possibili connessioni tra storie personali, migrazione e potere, sarebbe utile approfondire studi sulla sociologia delle migrazioni e sulla costruzione delle identità nazionali, magari leggendo autori che trattano di come le diaspore influenzino le relazioni internazionali o la politica interna dei paesi di origine e destinazione.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]