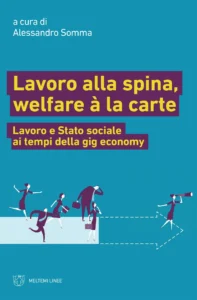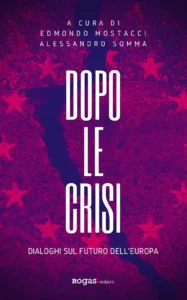Contenuti del libro
Informazioni
“Abolire il lavoro povero” di Alessandro Somma è un libro che ti prende e ti fa riflettere su un tema fondamentale: cosa significa lavorare oggi in Italia e come questo si lega alla nostra Costituzione italiana. Somma parte dall’idea che la Repubblica sia nata con un patto di cittadinanza basato proprio sul lavoro, inteso non solo come dovere ma come diritto a una vita dignitosa e base per la solidarietà e il welfare. Però, il libro mostra come questo patto sia stato messo sotto attacco, soprattutto con l’avvento del neoliberalismo e certi processi europei. Si è passati da un’idea di piena occupazione a una di semplice occupabilità, dove il lavoro diventa sempre più precario e malpagato, generando il fenomeno del lavoro povero. Viene analizzato anche il ruolo di misure come il reddito di cittadinanza, viste spesso come strumenti dello “Stato attivatore” che spinge ad accettare qualsiasi lavoro, piuttosto che garantire diritti. Il libro critica questa visione che sembra quasi “criminalizzare” la povertà e indebolire i lavoratori di fronte al capitale. Ma non è solo una critica: Somma propone anche una via d’uscita, parlando di democrazia economica, di come riequilibrare i rapporti di forza e rifondare quel patto sociale che la Costituzione aveva promesso. È un viaggio attraverso la storia economica e sociale del nostro paese, visto attraverso la lente del lavoro e dei diritti che sembrano sempre più lontani.Riassunto Breve
La Costituzione italiana fonda la Repubblica su un patto di cittadinanza basato sul lavoro, che implica il dovere di lavorare e il diritto alla sicurezza sociale e al welfare per una vita dignitosa. Il lavoro è centrale per la solidarietà e il progresso, garantendo libera scelta, retribuzione sufficiente e strumenti di lotta per i lavoratori come sindacati e sciopero. Lo Stato si impegna a promuovere la piena e buona occupazione con politiche economiche attive, indirizzando l’attività economica verso fini sociali. L’attuazione di questo patto ha avuto fasi alterne, con progressi negli anni Settanta, inclusa la tutela reale contro i licenziamenti e il riconoscimento dello sciopero politico. Il principio di parità sostanziale è cruciale per riequilibrare capitale e lavoro e disciplinare il conflitto sociale. Le crisi degli anni Settanta segnano il passaggio a un modello neoliberale, dove lo Stato garantisce il mercato e riduce la redistribuzione; l’integrazione sociale coincide con l’integrazione nel mercato. L’Europa unita e la moneta unica facilitano questa evoluzione, spingendo alla precarizzazione del lavoro, alla riduzione del welfare e concentrando la politica monetaria sulla stabilità dei prezzi. Questo altera il patto costituzionale, eliminando le garanzie in cambio del dovere di lavorare e limitando la partecipazione democratica per proteggere il mercato. Il lavoro perde valore etico, visto come “capitale umano”, e la tecnologia giustifica flessibilità e precarietà, generando insicurezza e povertà. Riforme legislative deregolamentano il lavoro, riducendolo a scambio di mercato. Welfare e strumenti per il diritto al lavoro vengono ridimensionati; la reintegrazione per licenziamento illegittimo è sostituita da indennizzi. Le politiche di piena occupazione sono abbandonate per lavoro povero e precario. Il neoliberalismo è incompatibile con la democrazia, richiedendo la limitazione del potere dei lavoratori e dei conflitti. La flessibilità e la confusione vita-lavoro neutralizzano la conflittualità, trasferendo costi sui lavoratori. La diffusione del lavoro povero evidenzia il fallimento del patto costituzionale. Si propone il reddito minimo garantito (RMG) o il reddito di base (RB). Il RMG è condizionato, legato alla disponibilità al lavoro e formazione, integrando salari bassi in un modello di “Stato sociale attivatore” che spinge i disoccupati nel mercato, focalizzandosi sull’occupabilità anziché sulla piena occupazione. Questo sostituisce il diritto al lavoro con il diritto di lavorare. Il RB è universale e incondizionato, sganciando il reddito dal lavoro, ma può essere usato in ottica neoliberale per smantellare il welfare. L’Europa promuove il RMG per combattere la povertà e promuovere l’occupazione, ma in un quadro di austerità che ne limita l’efficacia. L’Italia ha introdotto il RMG tardi con misure come il “reddito di cittadinanza”, configurato come “workfare” con forti condizionalità, rafforzando le ragioni del capitale. La disciplina del reddito di cittadinanza è stata inasprita, distinguendo occupabili e non occupabili, con benefici ridotti per i primi. Questi cambiamenti riflettono ostilità verso i percettori e una moralizzazione della povertà. Lo Stato sociale diventa punitivo e supporta il lavoro flessibile e povero, un ritorno a condizioni ottocentesche visibile nella gig economy con controllo algoritmico e mancanza di tutele, nonostante il riconoscimento giudiziario della subordinazione. Anche il welfare aziendale, incentivato, sostituisce il welfare universale e neutralizza il conflitto. La distinzione occupabili/non occupabili richiama divisioni vittoriane. Questi sviluppi neoliberisti si scontrano con i principi costituzionali che tutelano il lavoro e lo vedono come contributo sociale. Per ripristinare l’equilibrio democrazia-mercato, serve superare la dicotomia lavoro subordinato/autonomo e tutelare la parte debole, finanziando la sicurezza sociale sull’utilizzo dell’attività lavorativa altrui. Lo Stato neoliberale gestisce attivamente l’economia per il mercato, creando individui reattivi. La retorica tecnologica nasconde il legame lavoro-democrazia. Il patto sociale basato su lavoro e partecipazione è stato smantellato, separando richieste economiche e decisioni politiche. Per la buona occupazione, la politica deve governare la “fine del lavoro”. L’intervento statale è necessario, ma deve riequilibrare capitale e lavoro, portando alla democrazia economica con partecipazione diffusa, programmazione parlamentare e forme di proprietà diverse. La democrazia economica implica cambiare le politiche fiscali, tassando meno il lavoro e più patrimoni/rendite. La politica deve guidare il cambiamento tecnologico. La precarietà limita la mobilitazione. Lo Stato potrebbe agire come “datore di lavoro di ultima istanza” o promuovere lavori auto-organizzati, orientando lo sviluppo economico verso i consumi interni per la piena occupazione, con scelte partecipate. L’innovazione statale deve essere mediata dalla democrazia. La politica deve uscire dall’ortodossia neoliberale e affrontare le ambiguità Europa/livello nazionale. Politiche monetarie che privilegiano la stabilità dei prezzi hanno sbilanciato democrazia e mercato. Serve una nuova visione con partecipazione democratica centrale e conflitto equilibrato, rifondando il patto sociale su lavoro e dignità.Riassunto Lungo
1. Lavoro e Cittadinanza: Il Patto Fondativo della Repubblica
La Costituzione italiana lega strettamente l’essere cittadini al lavoro. È come un accordo: da una parte c’è il compito di lavorare, dall’altra il diritto di avere protezione sociale e accesso a servizi fondamentali per vivere dignitosamente. Nessuno può essere costretto a lavorare con la forza, ma non farlo può avere conseguenze, un punto discusso fin dall’Assemblea che ha scritto la Costituzione.Il Ruolo Centrale del Lavoro
Il lavoro non è solo un impegno personale, ma è visto come il cuore della Repubblica, la base della solidarietà tra le persone e un modo per far progredire tutta la società. La Costituzione assicura che ognuno possa scegliere liberamente il proprio lavoro e ricevere un compenso giusto per vivere. Riconosce anche gli strumenti importanti per i lavoratori, come i sindacati per organizzarsi e lo sciopero come mezzo di protesta. Prevede anche modi per i lavoratori di partecipare alle decisioni economiche e politiche del Paese, come attraverso il CNEL.Lo Stato e la Promozione dell’Occupazione
Un punto fondamentale di questo accordo è la promessa dello Stato di impegnarsi per garantire lavoro a tutti e che questo lavoro sia di buona qualità. Questo significa che lo Stato deve usare politiche economiche concrete, come investimenti pubblici e misure per distribuire meglio la ricchezza, un po’ come suggeriva l’economista Keynes. Anche se l’idea di un controllo totale sull’economia è stata discussa ma non accettata del tutto, preferendo un’azione di “coordinamento” o “programmazione”, la Costituzione chiede allo Stato di guidare l’economia, sia quella pubblica che quella privata, per raggiungere obiettivi utili a tutta la società.L’Evoluzione nel Tempo
L’applicazione di questo accordo è cambiata nel corso degli anni. Dopo un primo periodo in cui i principi più nuovi rimasero un po’ fermi, gli anni Settanta portarono importanti passi avanti. Ci fu più intervento dello Stato per creare lavoro e venne introdotta una protezione efficace contro i licenziamenti ingiusti. In quegli anni, la Corte Costituzionale riconobbe anche che lo sciopero fatto per motivi politici era legittimo, sottolineando quanto fosse importante il ruolo dei lavoratori nel decidere la direzione del Paese.La Parità Sostanziale e il Conflitto Sociale
Un principio cruciale è quello della parità sostanziale, che chiede allo Stato di eliminare gli ostacoli che impediscono a tutti di essere davvero uguali. Questo principio è visto come essenziale per creare un equilibrio più giusto tra chi possiede i mezzi di produzione (il capitale) e chi lavora (il lavoro). La sua importanza va oltre il rapporto tra Stato e cittadini: si applica anche alle dinamiche del mercato. Serve a capire come risolvere i contrasti di interesse e a rendere più forte la posizione dei lavoratori. Il conflitto tra diverse parti sociali, guidato da questo principio di parità sostanziale, non è visto solo come un problema, ma come uno strumento necessario per dare forma all’organizzazione economica della società e assicurare che i lavoratori partecipino attivamente alla vita democratica.Ma il “patto fondativo” tra lavoro e cittadinanza descritto nel capitolo regge ancora di fronte a un mondo del lavoro radicalmente cambiato e non pienamente analizzato nel testo?
Il capitolo illustra con chiarezza il legame costituzionale tra lavoro e cittadinanza e la sua evoluzione fino agli anni Settanta. Tuttavia, l’analisi si ferma prima di affrontare le profonde trasformazioni economiche e sociali degli ultimi decenni, che hanno visto l’aumento della precarietà, la disoccupazione strutturale, la globalizzazione e l’impatto delle nuove tecnologie. Questi fenomeni mettono in discussione l’effettiva applicabilità e tenuta di quel “patto” e della “promessa” statale di piena occupazione e lavoro dignitoso. Per valutare la validità attuale di questi principi, è cruciale approfondire la storia economica e sociale italiana post-anni ’70 e le analisi critiche del lavoro contemporaneo e del welfare state. Autori come Luciano Gallino o Zygmunt Bauman (per il contesto più ampio della modernità liquida) possono offrire spunti fondamentali per comprendere le sfide attuali a quel legame originario.2. Il Patto di Cittadinanza Sotto Attacco
Le crisi economiche degli anni Settanta, come quella energetica e la fine del sistema di cambi fissi tra le monete, hanno segnato un punto di svolta fondamentale. Queste crisi hanno offerto l’opportunità di superare il modello economico precedente, basato sulle idee di Keynes, per adottare un nuovo approccio: il neoliberismo. In questo nuovo modello, il ruolo dello Stato cambia radicalmente: non interviene più per ridistribuire la ricchezza in modo significativo, ma si limita a garantire il corretto funzionamento del mercato e della concorrenza. Di conseguenza, l’integrazione delle persone nella società viene fatta coincidere quasi esclusivamente con la loro integrazione nel mercato del lavoro.Il Ruolo dell’Europa Unita e della Moneta Unica
L’unificazione europea e l’introduzione della moneta unica hanno giocato un ruolo cruciale nell’imporre e diffondere questa evoluzione economica. La libera circolazione dei capitali all’interno dell’area europea ha messo i singoli paesi sotto una forte pressione competitiva. Per attrarre e trattenere gli investimenti, i governi sono stati spinti a rendere il lavoro più precario e meno remunerato, a ridurre le tasse per le imprese e a tagliare drasticamente i servizi di assistenza sociale, il cosiddetto welfare state. Parallelamente, la politica monetaria, gestita a livello centrale, si è concentrata quasi esclusivamente sull’obiettivo della stabilità dei prezzi, trascurando o addirittura impedendo l’adozione di politiche economiche che mirassero a garantire la piena occupazione.L’Alterazione del Patto di Cittadinanza
Questo processo di trasformazione economica ha alterato profondamente il fondamento del patto di cittadinanza così come era previsto dalla Costituzione, un patto basato sul lavoro come elemento centrale per l’acquisizione dei diritti. Le garanzie per i lavoratori sono state progressivamente smantellate, lasciando in primo piano solo il dovere di lavorare, ma senza le tutele corrispondenti. Per proteggere il funzionamento del mercato e l’accumulazione di capitale dai possibili conflitti sociali che potrebbero nascere dalle disuguaglianze nella distribuzione della ricchezza, la partecipazione democratica dei cittadini è stata di fatto limitata. In sostanza, si chiede alle persone di contribuire attraverso il loro lavoro, ma senza più garantire quei diritti fondamentali che dovrebbero essere intrinsecamente legati alla condizione di cittadino in una democrazia.La Nuova Visione del Lavoro
In questa nuova cornice neoliberale, il dovere di lavorare perde gran parte del suo valore etico e sociale. Il lavoratore non è più visto principalmente come parte attiva della società con diritti da tutelare collettivamente, ma piuttosto come un “capitale umano” da valorizzare o addirittura come un piccolo “imprenditore di sé stesso”, interamente responsabile del proprio successo o fallimento nel mercato competitivo. Le nuove tecnologie, invece di essere utilizzate per migliorare la qualità della vita e ridurre l’orario di lavoro, vengono spesso impiegate per giustificare e imporre una maggiore flessibilità e precarietà. Di conseguenza, il lavoro diventa sempre più instabile, insicuro e discontinuo, generando un aumento diffuso dell’insicurezza economica e della povertà, anche tra chi lavora regolarmente.Le Conseguenze delle Riforme Legislative
A partire dalla fine degli anni Novanta, una serie di riforme legislative ha accelerato ulteriormente questa tendenza alla deregolamentazione del mercato del lavoro. Il lavoro è stato ridotto sempre più a un semplice scambio tra domanda e offerta, equiparabile a una qualsiasi merce, favorendo così anche l’aumento delle pratiche lavorative non regolari e illegali. Parallelamente, i servizi di assistenza sociale e gli strumenti che un tempo servivano a rendere effettivo il diritto al lavoro, come la pianificazione economica o le tutele contro i licenziamenti ingiusti, sono stati notevolmente ridimensionati o eliminati. Ad esempio, la possibilità per un lavoratore di essere reintegrato al proprio posto dopo un licenziamento illegittimo è quasi scomparsa, sostituita nella maggior parte dei casi da un semplice risarcimento economico. Le politiche che un tempo miravano a creare occupazione piena e di qualità sono state abbandonate a favore di un mercato del lavoro caratterizzato da impieghi poveri e precari.Incompatibilità tra Neoliberismo e Democrazia
Questo modello neoliberale mostra una profonda incompatibilità di fondo con i principi della democrazia. Per garantire il funzionamento efficiente del mercato e l’accumulazione di capitale, è considerato necessario limitare il potere contrattuale dei lavoratori e contenere i conflitti sociali che potrebbero nascere dalle disuguaglianze economiche e sociali. La crescente flessibilità del lavoro e la tendenza a confondere sempre più i tempi dedicati al lavoro con quelli della vita privata, un fenomeno accentuato anche dall’uso dello smart working, contribuiscono a disinnescare la capacità dei lavoratori di organizzarsi collettivamente e a trasferire molti costi (di tempo, di organizzazione, di gestione) direttamente sulle loro spalle. La precarietà e la povertà lavorativa non sono accidenti di percorso, ma diventano la norma, confermando come il lavoro sia tornato, di fatto, a essere trattato semplicemente come una merce da comprare e vendere sul mercato.Il capitolo presenta l’unificazione europea e la moneta unica unicamente come veicoli dell’imposizione neoliberale; ma questa visione è completa, o ignora le complesse ragioni economiche e politiche della loro nascita e le diverse interpretazioni dei loro effetti?
Il capitolo offre una lettura molto specifica del ruolo dell’unificazione europea e della moneta unica, descrivendole principalmente come strumenti per imporre un modello economico neoliberale e smantellare il welfare. Questa prospettiva, pur evidenziando aspetti critici, rischia di trascurare la complessità delle motivazioni politiche ed economiche che hanno portato alla creazione dell’Unione e dell’Euro, nonché le diverse scuole di pensiero che ne hanno analizzato gli impatti, non sempre e solo negativi secondo altre interpretazioni. Per approfondire e contestualizzare meglio questo punto, sarebbe utile esplorare la storia dell’integrazione europea da diverse angolazioni (non solo economica), studiare le teorie economiche che hanno sostenuto la creazione della moneta unica (anche quelle che ne prevedevano benefici), e confrontarsi con autori che offrono analisi alternative o più sfumate sugli effetti dell’UE e delle politiche economiche post-anni ’70. Approfondire la storia economica del dopoguerra e le diverse correnti di pensiero economico (non solo Keynes e Neoliberismo) può fornire un quadro più completo.3. Lavoro povero e le risposte dello Stato attivatore
La diffusione del lavoro povero mostra che il patto sociale basato sulla Costituzione non funziona più come dovrebbe. Per affrontare questa situazione, si discute spesso di introdurre un reddito minimo garantito oppure un reddito di base.Il reddito minimo garantito: un aiuto condizionato
Il reddito minimo garantito è un sostegno economico che viene dato a determinate condizioni. Di solito, si richiede che la persona sia disponibile a cercare lavoro o a partecipare a percorsi di formazione. Questo aiuto serve a integrare il salario, se troppo basso, o a sostituirlo completamente, fino a raggiungere una somma considerata necessaria per vivere dignitosamente, superando la soglia di povertà relativa. Questa misura rientra in un modello chiamato “Stato sociale attivatore”, che ha lo scopo di spingere le persone disoccupate a entrare o rientrare nel mondo del lavoro. Un effetto di questo sistema è che le aziende possono permettersi di pagare stipendi bassi, sapendo che questi verranno poi integrati con soldi pubblici. L’obiettivo principale diventa l’occupabilità, cioè la capacità di una persona di trovare e mantenere un posto di lavoro sul mercato, piuttosto che garantire la piena occupazione per tutti. In pratica, il diritto al lavoro come inteso in passato viene sostituito dal diritto di essere in grado di lavorare.Il reddito di base: un sostegno universale e incondizionato
Il reddito di base funziona in modo diverso. È un aiuto economico dato a ogni individuo, senza chiedere nulla in cambio e indipendentemente dalla sua situazione lavorativa o economica. L’idea alla base è quella di separare il reddito dalla necessità di lavorare. Le proposte per un reddito di base hanno origini diverse: alcune nascono da critiche al sistema di proprietà e distribuzione della ricchezza, altre da visioni più legate al pensiero neoliberale. In quest’ultimo caso, il reddito di base è visto a volte come uno strumento per smantellare il sistema di welfare esistente e rendere il mercato del lavoro ancora più libero da regole. Se l’importo del reddito di base è troppo basso, non riesce a liberare le persone dalla pressione di accettare qualsiasi lavoro pur di sopravvivere. Anzi, in questa forma, potrebbe finire per rendere più stabile l’attuale sistema basato sulla precarietà.L’approccio dell’Europa e il caso italiano
L’Unione Europea promuove il reddito minimo garantito come uno strumento utile per combattere la povertà e l’esclusione sociale. Allo stesso tempo, lo vede come un modo per favorire l’occupazione. Questo approccio è in linea con i principi economici dominanti, che considerano l’inclusione sociale principalmente come l’inclusione nel mercato del lavoro. Le raccomandazioni europee parlano di garantire un reddito minimo “adeguato” per permettere una vita dignitosa. Tuttavia, queste indicazioni vengono viste con scetticismo da alcuni, perché le politiche di austerità e l’insistenza sulla competitività limitano di fatto le risorse che gli Stati possono dedicare a queste misure, riducendone l’efficacia reale. L’Italia ha adottato il reddito minimo garantito più tardi rispetto a molti altri paesi europei. Ha introdotto misure come il “reddito di inclusione” e, successivamente, il “reddito di cittadinanza”. Quest’ultimo ha avuto un effetto importante nel ridurre le disuguaglianze economiche, ma è stato configurato come uno strumento di “workfare”, cioè un sistema che lega l’aiuto economico a forti obblighi di ricerca e accettazione del lavoro. Queste condizioni sono molto importanti nel modello di Stato sociale attivatore, che si concentra sul rendere le persone “occupabili” (cioè pronte per il mercato del lavoro) piuttosto che garantire che ci sia lavoro per tutti (piena occupazione).Dal diritto al lavoro al mercato del lavoro
Questo passaggio dall’obiettivo della piena occupazione a quello dell’occupabilità riflette un modo di pensare di tipo neoliberale. Secondo questa visione, il mercato del lavoro è visto semplicemente come un mercato qualsiasi, dove l’incontro tra domanda e offerta definisce salari e livelli di occupazione. Viene meno l’idea che lo Stato possa intervenire in modo significativo per creare posti di lavoro o influenzare i salari, ad esempio sostenendo l’economia e la domanda interna. Si preferisce invece promuovere la flessibilità del lavoro e usare le condizioni legate agli aiuti sociali per spingere i lavoratori ad accettare lavori precari e con paghe basse. I costi sociali di questa precarietà vengono in parte coperti dai soldi raccolti con le tasse. Questo assetto rafforza la posizione di chi detiene il capitale a discapito delle aspettative e dei diritti dei lavoratori.Il capitolo afferma che lo Stato sociale “aiuta a diffondere” il lavoro precario e “punisce” i poveri. Ma questa è una causa o un effetto? E quali altre forze, oltre all’ostilità e al giudizio morale, plasmano il mercato del lavoro e le politiche di welfare?
Il capitolo presenta una tesi forte sulla responsabilità diretta dello Stato sociale nella diffusione della precarietà e nella “criminalizzazione” della povertà, attribuendo queste dinamiche principalmente a un clima di ostilità e a un giudizio morale. Tuttavia, la trasformazione del mercato del lavoro verso forme più flessibili e precarie è un fenomeno complesso, influenzato da una molteplicità di fattori globali, tecnologici ed economici che interagiscono con le politiche statali. Per comprendere meglio questa interazione e valutare la portata causale delle riforme di welfare, è utile approfondire la sociologia del lavoro, l’economia politica e la storia delle politiche sociali. Autori come Karl Polanyi, Richard Sennett e Gøsta Esping-Andersen offrono strumenti concettuali per analizzare il rapporto tra mercato, società e Stato, e per contestualizzare le attuali trasformazioni del lavoro e del welfare.5. Ripensare lo Stato e il Lavoro: Dalla Logica Neoliberale alla Democrazia Economica
Lo Stato, nella visione neoliberale, non si allontana dall’economia, ma la guida attivamente. Il suo scopo è sostenere il mercato e favorire la competizione, usando regole, tasse e investimenti pubblici. Questa gestione mira a dividere il potere economico e a formare persone che reagiscono in modo automatico alle richieste del mercato, senza un proprio progetto di vita definito. L’idea che i cambiamenti nell’economia dipendano solo dalla tecnologia è una narrazione tipica di questa visione. Serve a far sembrare il lavoro una semplice merce, nascondendo il suo legame profondo con la democrazia e la partecipazione dei cittadini.Il Patto Sociale Smantellato
Il legame forte tra lavoro e partecipazione democratica, che caratterizzava il patto sociale fino agli anni Settanta, è stato progressivamente indebolito. Sono state create strutture che separano le richieste economiche, spesso percepite come interne a un paese, dalle decisioni politiche, che invece sono sempre più prese a livello sovranazionale e in contesti poco aperti al dibattito pubblico.La Politica Deve Agire Sul Lavoro
Per poter tornare ad avere una buona occupazione, è fondamentale che la politica intervenga in modo deciso. Non si deve considerare la “fine del lavoro” come un destino inevitabile, ma come un aspetto politico che può e deve essere guidato. La partecipazione democratica non si limita al semplice voto, ma include il diritto di chi lavora di contribuire attivamente a definire le scelte politiche che riguardano l’intera società.Un Diverso Ruolo Dello Stato Nell’Economia
L’intervento dello Stato nell’economia è necessario, ma deve cambiare la sua natura. Oggi, spesso lo Stato interviene soprattutto per salvare il sistema neoliberale nei momenti di crisi. In queste situazioni, le perdite vengono rese pubbliche (socializzate), mentre i profitti rimangono privati. Questo tipo di intervento non rappresenta un nuovo modello economico, ma è solo una variante del capitalismo neoliberale.Verso La Democrazia Economica
Un cambiamento reale richiede che lo Stato aiuti a trovare un nuovo equilibrio nel rapporto tra capitale e lavoro. L’obiettivo è rendere il mercato un luogo dove le parti si confrontano alla pari. Questo porta alla realizzazione della democrazia economica. Questa idea, che ha radici storiche all’inizio del Novecento, promuove una partecipazione più ampia nelle decisioni economiche, una programmazione delle scelte decisa in Parlamento e forme di proprietà che coinvolgano diversi interessi, non solo lo Stato o i lavoratori.Strumenti Per La Democrazia Economica
La democrazia economica implica anche un ripensamento delle politiche fiscali. Significa ridurre le tasse sul lavoro e aumentarle su patrimoni e rendite, applicando una forte progressività, cioè facendo pagare di più chi ha di più. Vuol dire che la politica deve guidare i cambiamenti tecnologici, anziché accettare passivamente che portino a lavori meno stabili e più precari. La precarietà attuale limita la capacità dei lavoratori di organizzarsi e farsi sentire. Lo Stato potrebbe intervenire in modi diversi, per esempio agendo come “datore di lavoro di ultima istanza” o sostenendo la creazione di lavori auto-organizzati. Questo richiede che lo Stato orienti lo sviluppo economico verso i consumi interni, con l’obiettivo della piena occupazione, prendendo decisioni in modo partecipato. L’innovazione promossa dallo Stato deve sempre essere mediata e guidata dalla democrazia.Superare Gli Ostacoli Politici E Istituzionali
La politica deve cambiare le sue priorità e abbandonare le idee economiche consolidate del neoliberismo. È necessario anche affrontare le incertezze sul ruolo dell’Europa rispetto al livello nazionale. Il livello nazionale può essere lo spazio dove riattivare la democrazia. Politiche monetarie che danno priorità assoluta alla stabilità dei prezzi, considerate il “tempo dei capitalisti”, come la separazione tra il Ministero del Tesoro e la Banca d’Italia, hanno alterato l’equilibrio tra democrazia e mercato, favorendo quest’ultimo. Serve una nuova visione che metta al centro la partecipazione democratica. Questo permetterebbe un confronto equilibrato tra le diverse forze sociali, rifondando il patto sociale sulla centralità del lavoro e sulla dignità delle persone.Ma come si passa dalla teoria alla pratica?
Il capitolo delinea una visione di “democrazia economica” e propone strumenti come il “datore di lavoro di ultima istanza” per riequilibrare il rapporto capitale-lavoro. Tuttavia, il capitolo non approfondisce sufficientemente i modelli economici alternativi che supportano tali proposte, né le concrete sfide di implementazione in contesti complessi. Per comprendere meglio come queste idee si traducano in pratica e quali dibattiti le circondino, è utile esplorare la letteratura sull’economia post-keynesiana, la Modern Monetary Theory (MMT) per il concetto di ELR, e le diverse teorie della democrazia economica e della pianificazione democratica. Autori come Hyman Minsky, Stephanie Kelton, o Elinor Ostrom possono offrire prospettive più dettagliate sui meccanismi e le implicazioni di questi approcci.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]