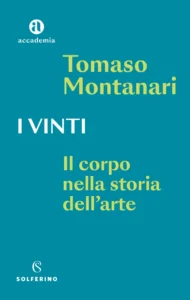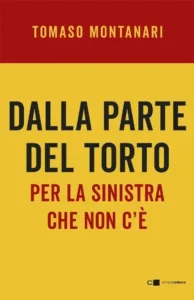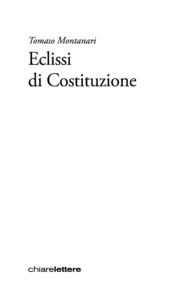1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“A cosa serve Michelangelo?” di Tomaso Montanari ti sbatte in faccia la storia assurda di un crocifisso ligneo comprato dallo Stato italiano per milioni, presentato come un Michelangelo giovanile, anche se un sacco di esperti avevano dubbi enormi sull’attribuzione. Il libro usa questo caso, ambientato tra Firenze e Roma, per smontare come funziona oggi il mondo dell’arte in Italia: il mercato che spinge attribuzioni dubbie, lo Stato che compra male, i media che fanno solo propaganda e spettacolo, e gli storici dell’arte che spesso restano in silenzio. Montanari critica forte l’idea dei “beni culturali” come merce da “valorizzare” per fare soldi o politica, e come questo abbia rovinato anche l’università. Ti fa capire che il nostro patrimonio culturale, fatto di opere d’arte e storia, non è roba da usare per le mostre-evento o da ridurre a intrattenimento, ma serve a farci crescere come persone. È un libro che ti fa pensare un sacco su cosa significa davvero l’arte e perché è fondamentale difenderla da chi la vuole solo sfruttare.Riassunto Breve
Un piccolo crocifisso di legno appare in una mostra a Firenze nel 2004, presentato come forse fatto da un giovane Michelangelo. L’opera è di un antiquario e alcuni esperti nel catalogo della mostra dicono che potrebbe essere di Michelangelo, confrontandola con altre sue opere. La Soprintendenza di Firenze la dichiara importante per la cultura per non farla vendere fuori dall’Italia. Però, molti altri esperti non sono d’accordo con l’attribuzione. Un’esperta dice che è di Andrea Sansovino. L’antiquario cerca di vendere l’opera, chiedendo prima 15 milioni di euro a una banca, poi abbassando il prezzo a 3 milioni. La banca non compra perché ha dubbi sull’attribuzione e sul prezzo. Nel 2007, l’antiquario offre l’opera al Ministero dei Beni Culturali per 18 milioni. Il comitato di esperti del Ministero consiglia di comprarla, ma a un prezzo molto più basso, visto che non si è sicuri di chi sia l’autore. Alla fine, nel 2008, lo Stato compra l’opera per 3 milioni e 250 mila euro. Un funzionario del Ministero che ha spinto per l’acquisto dice che il prezzo è giusto. L’acquisto viene pubblicizzato molto, l’opera viene mostrata al Papa e esposta in posti importanti come la Camera dei Deputati, dove viene definita bellissima. All’inizio, i giornali ne parlano bene. Dopo, però, altri importanti storici dell’arte criticano l’attribuzione, dicendo che è stata fatta per pubblicità e che l’opera è un pezzo fatto in serie da una bottega fiorentina. Si dice che l’acquisto è stato usato per scopi politici e mediatici. Viene fuori che la banca aveva rifiutato l’acquisto e che la Corte dei Conti apre un’indagine per danno ai soldi pubblici. Anche la Procura di Roma apre un’indagine per truffa. Molti esperti ripetono che l’opera non è di Michelangelo, ma un esempio di artigianato di alta qualità dell’epoca. Nel 2011, il crocifisso è conservato in una cassaforte a Firenze. La storia dell’arte funziona con ipotesi che vengono poi confermate o scartate dagli esperti. Nel caso del crocifisso, una campagna mediatica ha presentato come certa un’idea che non era stata verificata e che molti esperti non accettavano. Gli storici dell’arte, anche se non sono gli unici colpevoli, hanno una parte di responsabilità per non aver parlato pubblicamente. La mostra del 2004 e il suo catalogo, che promuovevano l’attribuzione, sembrano molto legati all’antiquario, facendo pensare più a un’operazione commerciale che scientifica. Il rapporto tra storia dell’arte e mercato, anche se la consulenza è normale, crea un problema tra la ricerca della verità e la promozione delle opere. Il mercato vuole risposte veloci, diverse dai tempi della ricerca scientifica. A differenza della medicina, la storia dell’arte non è trasparente sui soldi privati che riceve e su chi possiede le opere studiate. Molte pubblicazioni non vengono controllate da esperti indipendenti. Il catalogo del crocifisso non dice che è di parte. L’uso di analisi scientifiche nel catalogo sembra forzato e l’interpretazione storica di queste analisi è contestata. Non si è detto che l’opera era stata comprata per pochi soldi, preferendo una storia più affascinante. La mostra non ha permesso un confronto scientifico importante, esponendo l’opera solo con pezzi diversi, invece che con altri crocifissi simili. Questo confronto è fondamentale per capire la qualità e da dove deriva l’opera. Il silenzio pubblico degli esperti, anche se criticavano in privato, è influenzato dalle dinamiche interne del loro ambiente, dalla paura di rovinare i rapporti con i musei e dalla pressione dei media. Il comitato di esperti del Ministero, che doveva valutare l’acquisto, ha deciso basandosi solo sul catalogo e ascoltando chi proponeva l’acquisto, senza chiedere il parere di esperti indipendenti. Ha consigliato di comprare l’opera per un prezzo di mezzo, che non ha senso né per un vero Michelangelo né per un’opera di bottega, mostrando una gestione discutibile dei soldi pubblici. Il silenzio degli storici dell’arte in questo caso dipende anche dal fatto che la loro disciplina è divisa e difficile da influenzare le decisioni pubbliche. Il Ministero ha pensato che il silenzio significasse consenso. Però, altri casi dimostrano che l’intervento critico degli esperti può influenzare le decisioni e proteggere l’interesse di tutti. Il silenzio degli studiosi lascia spazio ad altri per raccontare la storia al pubblico. Dal 2008, i beni culturali, come il crocifisso comprato dal Ministero, vengono usati dal potere politico e religioso per farsi pubblicità, senza considerare la ricerca storica e l’educazione. L’acquisto del crocifisso, costato più di tre milioni di euro, ha avuto problemi, come accettare la valutazione del venditore e conflitti di interesse, ma il funzionario responsabile è stato promosso. Questa gestione dei beni culturali vede l’arte come uno strumento di marketing. Si pensa di usare le poche risorse per promuovere opere famose, ma questo ignora tutto il resto del patrimonio e nasconde i tagli ai fondi per la protezione. L’idea è trasformare la ricchezza artistica da un costo a una risorsa economica. Questa visione porta a creare una direzione generale per la “valorizzazione”, che da promuovere l’uso pubblico è diventata considerare i beni culturali come “giacimenti” da cui fare profitto. Un manager senza competenze artistiche viene messo a capo di questa direzione per “vendere” il patrimonio con eventi e pubblicità, concentrandosi solo su poche opere famose. Questa strategia, che sposta opere delicate per eventi commerciali, danneggia le opere e il loro significato, togliendole dal loro posto originale. L’uso delle opere d’arte per scopi politici è chiaro e fatto da tutti i partiti. L’immagine religiosa di opere come il crocifisso viene usata per avere l’appoggio della Chiesa cattolica, mescolando cultura e religione in modo strumentale. Questo succede anche mentre la Chiesa dice che il crocifisso ha valore culturale nelle scuole non religiose. Di fronte a questi problemi, la giustizia interviene con indagini. Se i giudici si concentrano sulle procedure e sui conflitti di interesse, possono emergere verità che il dibattito culturale non riesce a far vedere. L’acquisto di un crocifisso di legno attribuito a Michelangelo da parte dello Stato mostra come sta cambiando la gestione del patrimonio artistico. Le lettere che propongono l’acquisto dicono che l’opera può viaggiare per mostre internazionali, chiamandola un possibile “ambasciatore”. Questa importanza data alla facilità di trasporto e di esposizione mostra un cambiamento: le mostre influenzano le decisioni di acquisto, creando opere “da mostra”. Le mostre di arte antica non sono più solo eventi culturali o scientifici, ma sono diventate una grande industria dell’intrattenimento. Accanto a poche mostre basate sulla ricerca, ci sono molte mostre fatte per il marketing e per attirare molta gente. Opere famose vengono spostate per tour o affittate, a volte per pochi soldi rispetto al loro valore, per promuovere il turismo o il “made in Italy”. Questo modo di fare trasforma il patrimonio in una risorsa da sfruttare economicamente, come si faceva con le reliquie nei momenti difficili. Questa tendenza porta a esporre singole opere o parti di esse fuori dal loro contesto originale. Queste pratiche danneggiano l’integrità e il significato storico-artistico delle opere. Le istituzioni pubbliche, comprese le soprintendenze, spesso accettano queste iniziative, preferendo il successo di pubblico e i guadagni economici o politici alla conservazione, alla ricerca e alla funzione educativa dell’arte. L’obiettivo diventa “divertire” il pubblico, rendendo l’esperienza artistica un intrattenimento passivo, invece di stimolare il pensiero critico e la crescita culturale. Le mostre dovrebbero invece aiutare a capire le opere in modo profondo e personale, non ridurle a icone da consumare. I giornali e le televisioni nazionali parlano di storia dell’arte in modo superficiale e sensazionale. Nel caso dell’opera attribuita a Michelangelo, l’attenzione dei media si concentra solo sui momenti eclatanti come l’acquisto o le indagini, ignorando il dibattito scientifico sull’attribuzione. Questa mancanza di approfondimento succede anche quando giornali stranieri dedicano molto spazio al confronto tra esperti. La ragione principale è che il giornalismo culturale italiano vede la storia dell’arte come uno spettacolo, non come una disciplina intellettuale dove le idee si confrontano. Le notizie riguardano record di vendite, scoperte incredibili, furti o restauri, ma soprattutto mostre. Molti articoli sulle mostre sono, in realtà, pubblicità nascosta. Gli sponsor comprano pagine intere dove vengono pubblicati pezzi di cataloghi e commenti positivi. Le critiche sono quasi inesistenti. Questo succede perché spesso chi scrive le recensioni fa parte dello stesso ambiente accademico o istituzionale di chi organizza le mostre. Questa situazione è diversa da altri settori culturali come il cinema o il teatro, dove la critica è più presente. La storia dell’arte viene vista come una materia leggera, un argomento per passare il tempo, non qualcosa di serio come la scienza o la medicina. Questa idea si vede anche in libreria, dove i libri di storia dell’arte sono spesso messi vicino a quelli sul tempo libero. Per questo, articoli che presentano critiche fondate o che promuovono un dibattito intellettuale sulla storia dell’arte fanno fatica a essere pubblicati sui grandi giornali nazionali. Le obiezioni vengono a volte respinte dalle istituzioni come mosse fatte per interesse personale, invece di essere discusse nel merito. La storia dell’arte, nella comunicazione di massa, diventa così marketing e intrattenimento, perdendo il suo ruolo di stimolare il pensiero critico. L’introduzione del concetto di “beni culturali” ha sostituito l’idea di opere d’arte e testimonianze storiche, diventando una categoria più burocratica che intellettuale. Questo cambiamento si vede nelle università italiane con molti corsi di laurea in gestione dei beni culturali. Questi corsi vogliono formare “operatori dei beni culturali” per la protezione e l’industria culturale, ma sostituiscono materie umanistiche tradizionali come storia, filosofia e filologia con nozioni tecniche, legali ed economiche. La promessa di trovare più lavoro per chi studia materie umanistiche non si realizza; i laureati in beni culturali non trovano più lavoro, e a volte meno, rispetto a chi si laurea in storia dell’arte o lettere, e il lavoro è di qualità inferiore. Questi corsi hanno danneggiato le facoltà umanistiche, già in difficoltà, rendendole luoghi con poca selezione e qualità dell’insegnamento. Per la storia dell’arte, il danno è grande: chi vuole diventare storico dell’arte non si laurea più per forza in Lettere e non riceve una formazione umanistica completa che include storia, letteratura e lingue antiche. Questo porta a una preparazione non sufficiente per proteggere il patrimonio. La logica dei beni culturali influenza anche il Ministero, introducendo figure professionali poco chiare che si sovrappongono allo storico dell’arte, togliendogli compiti importanti come catalogare e pianificare i restauri. Esempi pratici mostrano eventi culturali importanti gestiti da persone non esperte, come restauratori o figure legate alla politica, a scapito della cura scientifica rigorosa. L’università, adottando il modello dei beni culturali, si allinea all’industria dell’intrattenimento culturale, rinunciando al suo ruolo di centro di sapere critico e indipendente. Non insegna agli studenti a distinguere tra cultura e intrattenimento, ma li prepara a gestire o promuovere eventi, sacrificando l’identità intellettuale dello studioso umanista per la “valorizzazione”. Questo rende gli esperti meno capaci di opporsi agli abusi sul patrimonio artistico. Il sistema attuale, fatto di mercato, politica e media, crea continuamente nuove “scoperte” artistiche che durano poco, come il caso del presunto “Michelangelo”, che vengono presto dimenticate. Questo succede perché la gente accetta queste mode temporanee senza pensare, mostrando una mancanza di senso critico. Questa situazione è legata al rapporto con l’arte contemporanea, che ha cambiato molto la funzione sociale e intellettuale dell’arte. L’arte si è separata dalla sua funzione e dal suo contenuto, diventando spesso una “cosa-che-tutti-possono-fare” e che richiede solo un giudizio personale come “mi piace” o “non mi piace”. Questo la rende una “splendida cosa inutile”, perdendo il legame diretto con la nostra vita. Il pubblico si avvicina all’arte contemporanea senza impegno, senza cercare di capire o giudicare. Questa superficialità si estende anche a come si guarda l’arte del passato, di cui si ignora la funzione originale e non si sa spiegare la bellezza se non in modo banale. L’idea che siano le mostre a rendere importanti le opere d’arte, invece del contrario, dimostra che il loro valore profondo è andato perso. Anche la storia dell’arte come disciplina è influenzata, accettando un relativismo che porta a non dare più giudizi storici e a diventare solo archeologia, perdendo la ricerca della verità e isolandosi dal pubblico. Per uscirne, bisogna tornare a capire a cosa serve il patrimonio artistico: non a fare soldi o divertire, ma a renderci più umani e civili. Gli storici dell’arte devono tornare a fare il loro lavoro, spiegando perché le opere del passato sono importanti per la nostra umanità e cultura. È necessario smettere di vedere i “beni culturali” come semplice intrattenimento e ricominciare a insegnare la storia dell’arte come disciplina umanistica e critica. Gli storici devono comunicare al pubblico, usando i media e le mostre, ma mostrando il valore oggettivo e l’utilità sociale della materia. È fondamentale far capire che le opere d’arte nei musei sono come animali in uno zoo: si vedono, ma non si conoscono veramente. La vera sfida è mostrare l’arte nel suo ambiente naturale, legata al paesaggio e alla storia. Bisogna distinguere l’arte contemporanea, nata per musei e mostre, dall’arte del passato, nata per servire la vita di una comunità, recuperando il legame tra stile e funzione. Vedere l’arte nei suoi contesti originali, come chiese o palazzi, mostra la sua complessità e i suoi legami, mostrandola come Storia viva. La storia dell’arte è l’unione di vecchio e nuovo che caratterizza il paesaggio italiano, un organismo vivo, non un museo sparso. Per salvare i musei, bisogna saper raccontare la vita passata delle opere. Non si deve pensare che l’arte sia più “facile” dei testi scritti; Giotto non è più facile di Dante. Le opere del passato parlano quando vengono rimesse nel contesto della storia della cultura, collegate alla letteratura, alla filosofia e alla storia di come sono state viste nel tempo. Il lavoro dello storico dell’arte è “resuscitare il passato”, dal punto di vista estetico, civile ed etico. Le istituzioni dovrebbero promuovere i monumenti permanenti con lo stesso impegno del marketing per le mostre temporanee, per ridare ai cittadini la conoscenza e il possesso della loro identità. Capire la distanza storica dall’arte del passato è cruciale. Un confronto tra renderla attuale e mantenerne la distanza storica dà profondità storica e funzione educativa. La cosa più importante è insegnare la storia dell’arte nelle scuole fin dalle elementari, perché l’identità nazionale si basa sulla lingua delle immagini quanto su quella parlata. La vicenda del “Michelangelo” dimostra come l’amore per l’arte possa essere usato in modo sbagliato per diseducare. Per evitare che l’Italia diventi un parco divertimenti e l’arte serva solo a interessi cinici, bisogna raccontare la vera storia dell’arte, rendendola necessaria per la vita interiore.Riassunto Lungo
1. Il Crocifisso conteso e l’acquisto di Stato
Una mostra a Firenze nel 2004 ha presentato un piccolo crocifisso di legno, suggerendo che potesse essere un’opera giovanile di Michelangelo. Il crocifisso apparteneva a un antiquario. Alcuni studiosi, nel catalogo della mostra, hanno sostenuto questa idea, confrontando l’opera con altri lavori più conosciuti dell’artista. La Soprintendenza di Firenze ha deciso di dichiarare l’opera di interesse culturale, un passo necessario per evitare che venisse venduta fuori dall’Italia.I primi dubbi e la vendita mancata
Non tutti gli esperti hanno accolto con favore l’attribuzione a Michelangelo. Un’esperta di crocifissi fiorentini, in particolare, l’ha respinta, suggerendo invece che l’autore potesse essere Andrea Sansovino. Nonostante i dubbi, l’antiquario ha cercato di vendere l’opera. L’ha offerta a una banca per 15 milioni di euro, riducendo poi rapidamente la richiesta a 3 milioni. La banca, però, non ha proceduto all’acquisto, proprio a causa delle incertezze sull’attribuzione e sul prezzo richiesto.L’acquisto da parte dello Stato
Nel 2007, l’antiquario ha proposto l’opera al Ministero dei Beni Culturali, questa volta per 18 milioni di euro. Il gruppo di esperti del Ministero ha dato parere favorevole all’acquisto, ma a condizione che il prezzo fosse molto più basso, adeguato all’attribuzione non certa. La trattativa si è conclusa nel 2008. Lo Stato italiano ha acquistato il crocifisso per 3 milioni e 250 mila euro. Un funzionario del Ministero, che aveva sostenuto l’operazione, ha dichiarato che il prezzo pagato era giusto.La promozione e le polemiche
Dopo l’acquisto, l’opera è stata promossa con grande risalto sui mezzi di comunicazione. Il crocifisso è stato mostrato al Papa ed esposto in luoghi importanti per le istituzioni, come la Camera dei Deputati, dove è stato definito di “bellezza suprema”. All’inizio, la stampa ha parlato dell’acquisto in modo largamente positivo. Tuttavia, in seguito, sono emerse forti critiche da parte di importanti storici dell’arte. Hanno definito l’attribuzione a Michelangelo una mossa pubblicitaria e l’opera un semplice prodotto di alta qualità uscito da una bottega fiorentina, non un pezzo unico di un maestro. È stata denunciata l’eccessiva influenza della politica e dei media nella gestione dell’acquisto.Le indagini e le conferme degli esperti
La notizia del precedente rifiuto da parte della banca e l’avvio di un’indagine da parte della Corte dei Conti per verificare se ci fosse stato un danno per le finanze pubbliche hanno ulteriormente alimentato il dibattito. Anche la Procura della Repubblica di Roma ha aperto un’indagine per truffa. Diversi studiosi hanno continuato a sostenere con forza che l’opera non è di Michelangelo, ma rappresenta un esempio dell’ottima qualità artigianale molto diffusa a Firenze in quel periodo. Nel gennaio 2011, il crocifisso è stato conservato in una cassaforte a Firenze, in attesa di ulteriori sviluppi o decisioni sulla sua collocazione definitiva.Se l’attribuzione del crocifisso a Michelangelo era così dibattuta e una banca lo aveva già rifiutato a un prezzo simile proprio per i dubbi, perché lo Stato italiano ha deciso di acquistarlo per oltre tre milioni di euro?
Il capitolo evidenzia una notevole discrepanza tra il consenso scientifico sull’attribuzione dell’opera e la decisione di acquisto da parte dello Stato, sollevando interrogativi sulla razionalità del processo decisionale, soprattutto in relazione al prezzo pagato e al precedente rifiuto da parte di un’istituzione privata per motivi analoghi. Per approfondire questa problematica, è utile studiare i criteri e le metodologie dell’attribuzione nell’ambito della storia dell’arte, le dinamiche del mercato e della valutazione delle opere d’arte, e le procedure amministrative e le responsabilità nella gestione dei beni culturali da parte delle istituzioni pubbliche.Capitolo II: Il Silenzio degli Storici e il Mercato dell’Arte
La storia dell’arte progredisce attraverso lo sviluppo e la verifica di ipotesi. Nel caso di un Crocifisso attribuito a Michelangelo, un’ipotesi che non era stata verificata e che la maggior parte degli esperti aveva tacitamente scartato è stata presentata al pubblico come una certezza attraverso una campagna mediatica. Gli storici dell’arte, pur non essendo gli unici coinvolti, hanno avuto una parte di responsabilità in questa situazione a causa del loro silenzio pubblico.Un Caso Specifico: Il Crocifisso Conteso
Una mostra tenutasi nel 2004 e il suo catalogo hanno promosso attivamente l’attribuzione del Crocifisso. Il catalogo rivelava uno stretto legame con l’antiquario che possedeva l’opera, sollevando dubbi sulla vera natura dell’evento: era scientifica o piuttosto commerciale? Le analisi tecniche (come quelle sul legno o sull’anatomia) presentate nel catalogo per supportare l’attribuzione apparivano forzate, e la loro interpretazione storica è stata contestata da altri studiosi. Anche la provenienza dell’opera, acquistata per una somma bassa, è stata tenuta nascosta, preferendo raccontare una storia più affascinante. La mostra stessa ha impedito un confronto scientifico fondamentale esponendo l’opera solo con pezzi di stile diverso, invece che accanto ad altri crocifissi simili già noti. Un confronto diretto è essenziale per valutare la qualità e l’origine di un’opera.Storia dell’Arte e Mercato: Un Rapporto Complesso
Questo caso mette in luce il rapporto stretto e a volte problematico tra la storia dell’arte e il mercato. Sebbene sia legittimo per gli storici offrire consulenze al mercato, questo crea un potenziale conflitto tra la ricerca della verità storica e l’interesse a promuovere la vendita dei beni. Il mercato richiede risposte rapide e definitive, tempi che non coincidono con quelli necessari per una ricerca scientifica approfondita. A differenza di discipline come la medicina, la storia dell’arte spesso non è trasparente riguardo ai finanziamenti privati ricevuti o alla proprietà delle opere che vengono studiate. Molte pubblicazioni non vengono sottoposte a un controllo indipendente prima della pubblicazione. Il catalogo dedicato al Crocifisso, ad esempio, non dichiarava apertamente la sua parzialità o il suo legame commerciale.Le Ragioni del Silenzio degli Esperti
Il silenzio pubblico degli studiosi, anche quando in privato esprimevano critiche, è influenzato da dinamiche interne al mondo accademico. Esiste il timore di compromettere i rapporti con le istituzioni museali, che sono fondamentali per la ricerca e l’accesso alle opere. C’è anche la pressione generata dall’attenzione dei media su casi di alto profilo. Questi fattori possono rendere gli esperti riluttanti a esprimere pubblicamente i loro dubbi o le loro obiezioni, anche quando ritengono che l’attribuzione o la gestione di un’opera non siano corrette.La Decisione del Ministero
Una conseguenza diretta del silenzio degli storici è stata la decisione presa dal Comitato tecnico-scientifico del Ministero, incaricato di valutare un possibile acquisto. Questo comitato ha basato il suo parere unicamente sul catalogo che promuoveva l’attribuzione e sull’audizione delle persone che proponevano l’acquisto. Non sono stati consultati esperti indipendenti per avere un parere terzo. Il comitato ha consigliato l’acquisto per una cifra intermedia, che non era giustificata né per un’opera autentica di Michelangelo né per un’opera di produzione seriale. Questo dimostra una gestione discutibile dei fondi pubblici in assenza di un’analisi critica esterna.L’Importanza della Voce Critica
Il silenzio degli storici dell’arte in questa vicenda affonda le radici nella frammentazione della disciplina e nella difficoltà che gli studiosi incontrano nell’influenzare le decisioni pubbliche. Il Ministero ha interpretato questa mancanza di voci critiche pubbliche come un tacito assenso all’attribuzione. Tuttavia, altri casi dimostrano che l’intervento pubblico di un esperto può avere un impatto significativo sulle decisioni e contribuire a proteggere l’interesse generale. Un esempio è il caso della Madonna delle due corone, dove un esperto ha contestato pubblicamente un’attribuzione a Donatello. Quando gli studiosi scelgono di non parlare, lasciano spazio ad altri, spesso legati a interessi commerciali, per definire ciò che il pubblico crede sulla storia dell’arte e sulle singole opere.Se il Ministero ha basato la sua decisione unicamente sul catalogo di parte, la colpa è del ‘silenzio’ degli storici o di un processo decisionale lacunoso a monte?
Il capitolo lega strettamente la decisione del Ministero al silenzio degli storici, suggerendo che l’assenza di voci critiche abbia lasciato campo libero. Tuttavia, sorge il dubbio se il problema risieda unicamente nella mancanza di “voce” esterna, o piuttosto in un processo decisionale interno al Ministero già di per sé carente, che si è basato acriticamente su una fonte di parte senza cercare attivamente pareri indipendenti. Per approfondire questa dinamica, sarebbe utile esaminare i meccanismi della pubblica amministrazione, le normative sugli acquisti di beni culturali e gli studi sulla sociologia delle istituzioni e dei processi decisionali collegiali.2. La Cultura Diventa Merce e Propaganda
Dal 2008, il modo in cui il patrimonio culturale viene gestito è cambiato. Non è più visto solo per il suo valore storico ed educativo, ma viene usato come strumento di pubblicità e propaganda, spesso ignorando la ricerca e l’educazione.L’Arte Come Strumento Economico e di Marketing
Questa nuova visione considera l’arte e i beni culturali come una risorsa economica, un “giacimento culturale” o “petrolio d’Italia” da cui ricavare profitto. L’idea è quella di trasformare la ricchezza artistica da un costo a una fonte di guadagno. Questo porta alla creazione di una direzione generale con lo scopo di “valorizzare” il patrimonio, affidata a manager senza specifiche competenze artistiche, con l’obiettivo di “vendere” l’arte attraverso eventi e pubblicità, concentrandosi solo sulle opere più famose.Esempi Concreti di Questa Strategia
Un esempio di questa gestione è l’acquisto del Crocifisso “di Michelangelo” da parte del Ministero dei Beni Culturali. Quest’opera è stata usata per farsi pubblicità, nonostante l’acquisto, costato oltre tre milioni di euro, presentasse diverse irregolarità, come l’accettazione della perizia del venditore e conflitti di interesse. Nonostante ciò, il funzionario responsabile è stato promosso. Questa visione si basa sull’idea di concentrare le poche risorse su opere famose per consegnarle alle generazioni future, ignorando però il patrimonio diffuso e nascondendo i tagli ai fondi per la tutela. Un altro esempio è lo spostamento di opere delicate come il David di Donatello per eventi commerciali. Questa pratica danneggia l’opera stessa e la sua percezione, sradicandola dal suo contesto culturale originale.L’Uso Politico e Religioso dell’Arte
L’uso delle opere d’arte per scopi politici è evidente e coinvolge diverse parti. In particolare, l’iconografia religiosa, come quella del Crocifisso, viene usata per ottenere l’appoggio della Chiesa cattolica. Questo mescola scopi culturali e religiosi in modo strumentale, anche nel momento in cui la Chiesa rivendica il valore culturale del crocifisso nelle scuole laiche.Il Ruolo della Magistratura
Di fronte a questi problemi, il potere giudiziario a volte interviene con indagini. Se i giudici si concentrano sui procedimenti e sui conflitti di interesse piuttosto che sull’attribuzione delle opere, possono emergere verità che il dibattito culturale pubblico non riesce a far venire alla luce.Ma siamo sicuri che il declino delle facoltà umanistiche e le difficoltà lavorative dipendano solo dalla nascita dei corsi in ‘beni culturali’?
Il capitolo espone una critica forte e puntuale, ma l’analisi delle cause appare forse un po’ unidirezionale. Le trasformazioni dell’università italiana e del mercato del lavoro negli ultimi decenni sono fenomeni complessi, influenzati da riforme strutturali, cambiamenti economici globali e nuove esigenze sociali, che vanno oltre la sola introduzione di specifici percorsi di studio. Per comprendere appieno il contesto e valutare l’impatto reale dei corsi in ‘beni culturali’, sarebbe utile approfondire la storia delle riforme universitarie in Italia, le analisi sociologiche sull’evoluzione delle professioni culturali e le dinamiche generali del mercato del lavoro per i laureati umanistici. Questo permetterebbe di inquadrare meglio il fenomeno e discernere quali criticità siano specifiche di questi corsi e quali siano invece sintomi di problemi più ampi del sistema.3. Ritrovare il senso perduto dell’arte
Il sistema attuale, fatto di mercato, politica e media, crea continuamente nuove “scoperte” artistiche effimere, come il caso del presunto “Michelangelo”, che finiscono presto dimenticate. L’opinione pubblica accetta acriticamente questi idoli temporanei, mostrando una mancanza di senso critico. Questo è legato al rapporto con l’arte contemporanea, che ha profondamente cambiato la funzione sociale e intellettuale dell’arte. L’arte si è separata dalla sua funzione e dal suo contenuto, diventando spesso una “cosa-che-tutti-possono-fare” che richiede solo un giudizio soggettivo come “mi piace” o “non mi piace”. Questo la rende una “splendida superfluità”, perdendo il legame diretto con la nostra esistenza. Il pubblico si avvicina all’arte contemporanea con disimpegno, senza cercare di capire o giudicare. Questa superficialità si estende anche alla ricezione dell’arte del passato, di cui si ignora la funzione originale e non si sa spiegare la bellezza al di là del conformismo. L’idea che siano le mostre a “valorizzare” le opere d’arte, invece del contrario, mostra che il loro valore profondo è sfuggito.Riscoprire il valore e il ruolo dell’arte
Anche la storia dell’arte come disciplina è influenzata, adottando un relativismo che porta a rinunciare al giudizio storico e a trasformarsi in archeologia, perdendo la ricerca della verità e isolandosi dal grande pubblico. Per trovare una via d’uscita, bisogna tornare a comprendere a cosa serve il patrimonio artistico: non a produrre ricchezza o divertimento, ma a renderci più umani e civili. Gli storici dell’arte devono tornare a fare il loro lavoro, spiegando perché le opere del passato sono importanti per la nostra umanità e cultura. È necessario abbandonare l’idea dei “beni culturali” come semplice intrattenimento e riprendere a insegnare la storia dell’arte come disciplina umanistica e critica. Gli storici devono comunicare al pubblico, usando media e mostre, ma mostrando il valore oggettivo e l’utilità sociale della materia. È fondamentale far capire che le opere d’arte nei musei sono come animali in uno zoo: si vedono, ma non si conoscono veramente. La vera sfida è mostrare l’arte nel suo ambiente naturale, legata al paesaggio e alla storia. Bisogna distinguere l’arte contemporanea, nata per musei e mostre, dall’arte del passato, nata per servire la vita di una comunità, recuperando il legame tra stile e funzione. Vedere l’arte nei suoi contesti originali, come chiese o palazzi, rivela la sua complessità e la sua rete di relazioni, mostrandola come Storia viva. La storia dell’arte è l’intreccio di vecchio e nuovo che segna il paesaggio italiano, un organismo vivo, non un museo diffuso. Per salvare i musei, bisogna saper evocare la vita passata delle opere. Non si deve credere che l’arte sia più “facile” dei testi scritti; Giotto non è più facile di Dante. Le opere del passato parlano quando vengono ricollocate nella storia della cultura, incrociate con letteratura, filosofia e la storia della loro ricezione. Il mestiere dello storico dell’arte è la “resurrezione del passato”, estetica, civile ed etica. Le istituzioni dovrebbero promuovere i monumenti permanenti con lo stesso sforzo usato per il marketing delle mostre temporanee, per restituire ai cittadini la conoscenza e il possesso della loro identità. La consapevolezza della distanza storica dall’arte del passato è cruciale. Un equilibrio tra attualizzazione e distanza restituisce profondità storica e funzione educativa. La condizione fondamentale è l’insegnamento della storia dell’arte nelle scuole fin dalle elementari, perché l’identità nazionale si basa sulla lingua figurativa quanto su quella parlata. L’episodio del “Michelangelo” dimostra come l’amore per l’arte possa essere distorto per diseducare. Per evitare che l’Italia diventi Disneyland e l’arte serva solo interessi cinici, bisogna raccontare la vera storia dell’arte, rendendola necessaria per la vita interiore.Siamo sicuri che l’unica ‘vera’ funzione dell’arte sia renderci ‘più umani e civili’?
Il capitolo propone una visione specifica della funzione dell’arte, legandola strettamente a un miglioramento etico e civile. Ma è davvero questa l’unica, o la principale, funzione che l’arte ha avuto nel corso dei millenni e nelle diverse culture? Questa definizione rischia di essere riduttiva, ignorando i molteplici ruoli che l’arte ha svolto, da quello rituale a quello politico, da quello decorativo a quello puramente estetico o espressivo. Non sempre l’obiettivo primario dell’artista o del committente era “renderci più umani” nel senso inteso oggi. Per approfondire questa complessità e capire come l’arte si è intrecciata con la vita delle comunità in modi diversi, è fondamentale esplorare la storia delle funzioni dell’arte in contesti specifici, attingendo a discipline come l’antropologia dell’arte, la sociologia dell’arte e la storia culturale. Leggere autori che hanno studiato il ruolo dell’arte nelle società antiche o non occidentali può offrire prospettive illuminanti che vanno oltre la visione proposta dal capitolo.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]