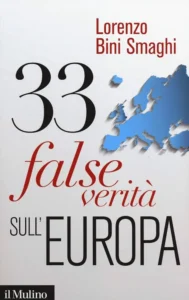1. La costruzione europea tra élite, democrazia e sfide decisionali
L’Unione Europea nasce da un’idea di alcune figure chiave, ma il suo sviluppo e il passaggio di poteri dagli Stati membri alle istituzioni europee avvengono sempre in modo democratico e pacifico. Ogni volta che i paesi cedono parte della loro sovranità, è necessario il consenso unanime di tutti. Questo consenso si ottiene rispettando le regole di ogni nazione, che possono prevedere un voto in Parlamento o un referendum popolare. Anche per riprendere poteri o per uscire dall’Unione, serve l’accordo degli altri Stati. Il fatto che alcuni paesi come Norvegia o Irlanda abbiano votato contro l’adesione in un referendum non mette in discussione la democraticità del processo, ma conferma che è possibile esprimere un parere contrario. In Italia, per esempio, l’adozione dell’euro fu approvata dal Parlamento e la maggior parte delle persone era favorevole, secondo i sondaggi del 1998, anche se alcuni avvertivano delle possibili difficoltà future.La struttura democratica dell’Unione
La struttura democratica dell’Unione Europea è un sistema misto che cambia nel tempo. La sua legittimità viene sia direttamente dai cittadini, che eleggono il Parlamento Europeo, sia indirettamente dai governi nazionali, che formano il Consiglio. Questo tipo di organizzazione è più solido rispetto ad altre realtà internazionali. Il Parlamento Europeo ha ottenuto sempre più poteri negli anni, arrivando a decidere insieme al Consiglio su molte leggi importanti. La Commissione Europea, a volte criticata perché i suoi membri non sono eletti direttamente, è nominata dai capi di governo nel Consiglio Europeo. Tuttavia, deve ottenere la fiducia del Parlamento, che ha già dimostrato di poter rifiutare i candidati proposti. Si discute spesso di un “deficit democratico”, ma il processo è visto come un cammino che porta avanti, non un motivo per tornare indietro.Velocità decisionale e sfide
Molti pensano che l’Europa sia lenta a prendere decisioni, ma non sempre la colpa è delle sue istituzioni. La Banca Centrale Europea, per esempio, ha agito molto velocemente durante i momenti di crisi economica. La lentezza si verifica spesso nei settori dove l’Unione non ha il potere esclusivo di decidere e deve aspettare l’accordo unanime di tutti gli Stati membri per poter agire o creare nuovi strumenti. Nonostante queste difficoltà, durante le crisi economiche sono state fatte riforme importanti, come la creazione del Fondo salva Stati e il rafforzamento del controllo sulle banche. La lentezza dipende anche dalla resistenza dei governi nazionali a cedere parte dei loro poteri. Questo crea situazioni contraddittorie, come chiedere aiuti all’Europa ma non voler accettare regole comuni. Le richieste di riportare certe decisioni solo a livello nazionale rischiano di indebolire il mercato unico europeo. Permetterebbero ai singoli Stati di fare leggi che favoriscono le proprie imprese a scapito della concorrenza e degli altri paesi.Affermare che il ‘deficit democratico’ sia solo un ‘cammino che porta avanti’ non rischia di minimizzare le critiche sostanziali alla legittimità dell’Unione?
Il capitolo, pur riconoscendo l’esistenza di un dibattito sul ‘deficit democratico’, lo inquadra come una fase evolutiva positiva (‘un cammino che porta avanti’). Tuttavia, questa prospettiva non esaurisce la complessità della questione. Molti studiosi di scienze politiche e diritto costituzionale mettono in discussione la natura e l’entità di tale deficit, analizzando le tensioni tra legittimità basata sull’input (elezioni, partecipazione) e quella basata sull’output (efficacia delle politiche), o esplorando il ruolo dei parlamenti nazionali e la complessità del processo decisionale. Per approfondire, è utile esplorare le diverse teorie sull’integrazione europea e sulla legittimità delle istituzioni sovranazionali, leggendo autori che hanno analizzato criticamente questi temi.2. L’Euro, la Sovranità e le Sfide della Crescita
Adottare una moneta comune significa che i paesi membri condividono la sovranità sulla moneta. Questa sovranità viene esercitata insieme attraverso la Banca Centrale Europea. Di conseguenza, ogni singolo paese rinuncia alla possibilità di usare la politica monetaria o il tasso di cambio per correggere le differenze di inflazione o di competitività rispetto agli altri. Questa perdita di flessibilità era ben nota fin dall’inizio dell’unione monetaria. L’obiettivo era ridurre l’instabilità dei cambi tra le valute e i costi legati alle differenze nei tassi di interesse. Tuttavia, in alcuni paesi, come l’Italia, i costi di produzione e i prezzi sono aumentati più velocemente rispetto ad altri. Questo ha causato una perdita di competitività che oggi richiede aggiustamenti difficili e pesanti.Disciplina di Bilancio e Sovranità Fiscale
Un altro vincolo imposto dall’unione monetaria è la disciplina di bilancio. Questa disciplina è necessaria per evitare che i problemi finanziari di un paese creino instabilità per tutta l’area dell’euro. La sovranità sul bilancio nazionale si riduce quando un paese non riesce più a trovare chi finanzi il suo debito sui mercati finanziari. Questo è successo durante la crisi del 2011 a paesi come Italia, Grecia, Irlanda e Portogallo. Questa situazione non è una conseguenza diretta dell’euro, ma deriva dall’incapacità di un paese di gestire le proprie finanze pubbliche in modo da mantenere la fiducia dei mercati.Le Politiche Economiche Nazionali e la Crescita
La sovranità su altre politiche economiche importanti per la crescita economica rimane invece in gran parte nelle mani dei singoli paesi. Queste politiche riguardano aree fondamentali come il mercato del lavoro, l’innovazione tecnologica, il sistema di assistenza sociale (welfare) e l’istruzione. La bassa crescita che si osserva in alcuni paesi, come l’Italia a partire dagli anni ’90, è legata a problemi strutturali interni e al fatto che non sono state realizzate le riforme necessarie. Ad esempio, i paesi che hanno investito meno nello sviluppo digitale e informatico mostrano generalmente una crescita più lenta. L’euro non ha tolto ai paesi la possibilità di decidere in questi settori chiave per la crescita, ma questa possibilità non è sempre stata sfruttata in modo efficace.Uscire dall’Euro: Un Recupero di Sovranità?
L’idea di recuperare piena sovranità uscendo dall’euro è in realtà molto complessa. Prima dell’euro, per molti paesi, la sovranità monetaria era già limitata perché le loro politiche monetarie dovevano seguire quelle della Germania e del suo marco. Entrando nell’euro, questi paesi hanno invece ottenuto una voce nelle decisioni della Banca Centrale Europea. Avere una propria moneta nazionale non garantisce automaticamente il controllo sul suo valore rispetto alle altre valute, perché questo valore è largamente deciso dai mercati finanziari internazionali. Svalutare la propria moneta può aiutare la competitività, ma solo se ci sono determinate condizioni: una banca centrale indipendente, un mercato del lavoro flessibile e finanze pubbliche sotto controllo. Inoltre, la svalutazione non è una soluzione che si può usare ripetutamente per stimolare la crescita o finanziare il debito pubblico senza causare un aumento generale dei prezzi (inflazione) e la fuga di capitali dal paese. Le proposte di uscire dall’euro con l’obiettivo di permettere allo Stato di finanziarsi stampando moneta implicano un ritorno a pratiche non compatibili con un mercato europeo integrato e richiederebbero l’introduzione di controlli sui movimenti di capitale, il che equivarrebbe di fatto a un’uscita dall’Unione Europea stessa.Crescita: Oltre la Moneta Unica
Confrontare la crescita economica tra i paesi che usano l’euro e quelli che non lo usano è difficile. Ci sono moltissimi fattori che influenzano la crescita, diversi dalla sola moneta. Le performance economiche variano notevolmente anche tra i paesi che fanno parte dell’area euro. La crescita di un paese dipende da elementi come la capacità di adattarsi ai cambiamenti (flessibilità strutturale), l’accesso al credito per imprese e famiglie, le scelte di politica fiscale (tasse e spesa pubblica) e gli investimenti in ricerca e sviluppo. I paesi extra-euro che mostrano una crescita forte spesso possiedono queste caratteristiche o stanno vivendo un periodo di recupero economico. L’idea che i paesi con performance inferiori crescerebbero molto di più semplicemente abbandonando l’euro è quindi un’illusione.Affermare che uscire dall’euro sia un’illusione per la crescita non ignora forse le argomentazioni di chi vede nella sovranità monetaria uno strumento fondamentale, seppur rischioso, per la politica economica nazionale?
Il capitolo, nel liquidare l’idea di recuperare sovranità uscendo dall’euro come un'”illusione”, non approfondisce a sufficienza le argomentazioni di quelle scuole di pensiero economico che considerano la sovranità monetaria uno strumento cruciale per la politica economica di uno Stato, capace di offrire opzioni diverse rispetto ai vincoli di una moneta non sovrana. Per comprendere meglio questo dibattito e le diverse prospettive sulla relazione tra moneta, debito pubblico e crescita, sarebbe utile esplorare approcci economici alternativi a quelli prevalenti, leggendo autori come Warren Mosler, Stephanie Kelton o Yanis Varoufakis.3. La costruzione imperfetta dell’Eurozona
L’unione monetaria europea è stata creata prima di una vera unione politica. Questo è un percorso unico nella storia moderna, dove Stati sovrani si uniscono pacificamente con una moneta comune. Solitamente, la moneta e il governo vanno di pari passo. La cooperazione monetaria in Europa è cresciuta dopo la guerra, superando sistemi precedenti dove i singoli paesi avevano già meno controllo sulla propria moneta. Con l’euro, i paesi hanno rinunciato definitivamente a questo controllo. Questo ha portato vantaggi come cambi stabili e tassi di interesse simili, ma ha anche tolto uno strumento importante per affrontare le crisi economiche che colpiscono i paesi in modo diverso.L’architettura iniziale e i suoi limiti
All’inizio, l’unione monetaria non aveva meccanismi centrali per gestire le crisi. Si pensava che l’economia si sarebbe integrata abbastanza da non averne bisogno, o che sarebbe stato politicamente difficile crearli senza problemi urgenti. L’integrazione europea spesso procede in modo pratico: le crisi dimostrano che le soluzioni nazionali non bastano e spingono i paesi a cedere potere all’Europa. L’Eurozona non era l’area ideale per una moneta unica perché i mercati non erano flessibili e non c’erano trasferimenti di denaro tra paesi ricchi e poveri per compensare. Gli economisti avevano segnalato queste debolezze, ma l’euro fu scelto perché considerato migliore del vecchio sistema, dominato dalla Germania e non più adatto a un’economia sempre più integrata e aperta ai movimenti di capitale. L’euro ha evitato problemi legati alle oscillazioni dei cambi e ha accelerato l’integrazione economica. Lo svantaggio principale è stata la perdita della possibilità di svalutare la moneta per affrontare gravi shock economici. Le crisi, come quella greca, hanno mostrato le lacune iniziali, ma hanno anche portato alla creazione di strumenti di aiuto e controllo che mancavano. Errori nella costruzione includono l’eccessiva fiducia in regole semplici per i bilanci pubblici e il non aver considerato abbastanza i problemi nel settore privato, come il debito di banche o famiglie.L’esperienza italiana
Il tasso per convertire la lira italiana in euro (1.936,27 lire per euro) fu fissato in base al valore di mercato a metà del 1998 e al rispetto di certi obiettivi economici (cambio stabile, inflazione bassa, tassi di interesse bassi). Questo serviva a evitare manipolazioni e garantire un cambio giusto. Non era possibile fissare il cambio a 1.000 lire per euro perché avrebbe rotto il legame con l’unità monetaria europea precedente (l’ecu) e reso troppo complicato calcolare i tassi per tutti i paesi. Il tasso scelto per la lira la rendeva più debole rispetto ai livelli prima del 1992, il che aiutava le esportazioni italiane. Gli aumenti dei prezzi dopo l’arrivo dell’euro sono stati causati più dalla mancanza di concorrenza e controlli interni che dal tasso di cambio. I problemi economici che l’Italia ha avuto in seguito dipendono soprattutto dal fatto che imprese e cittadini non si sono adattati abbastanza bene alle regole di un’area monetaria unita. La costruzione europea è un processo in corso e non perfetto, che va avanti superando le crisi invece di smantellare ciò che è stato costruito.Affermare che ‘stimolare solo la spesa interna’ porti inevitabilmente a inflazione e rendite non è forse un po’ troppo categorico, ignorando le condizioni in cui tale stimolo viene attuato?
Il capitolo lega in modo molto stretto e causale la politica di stimolo della domanda interna a esiti negativi come l’inflazione, la scarsa crescita della produttività e la perdita di competitività. Tuttavia, questa relazione è oggetto di ampio dibattito in economia. La validità e gli effetti di una politica di stimolo dipendono fortemente dal contesto economico specifico: ad esempio, se l’economia opera al di sotto del suo potenziale, uno stimolo può non generare inflazione ma favorire la ripresa. Il capitolo presenta questa politica come intrinsecamente sbagliata, senza esplorare le diverse condizioni in cui potrebbe essere applicata o le possibili combinazioni con altre riforme. Per approfondire questa complessità, è utile studiare i principi della macroeconomia, con particolare attenzione alle teorie sulla domanda aggregata e gli effetti delle politiche fiscali in diversi scenari economici. Confrontare il pensiero di economisti che enfatizzano il ruolo della domanda, come John Maynard Keynes, con quello di scuole di pensiero che pongono maggiore accento sull’offerta e la produttività può aiutare a comprendere meglio le sfumature di questo dibattito.12. L’Italia al Centro del Destino Europeo
L’Europa di oggi non soddisfa le aspettative dei cittadini e ha difficoltà a gestire le crisi attuali. Per affrontare le sfide globali, i paesi europei devono lavorare più uniti, perché da soli sono spesso troppo piccoli. Purtroppo, questo processo di unione è lento, frenato dalla mancanza di fiducia tra gli stati, peggiorata dalla crisi economica.Gli ostacoli all’integrazione europea
Ritrovare la fiducia è essenziale per far ripartire l’economia. Servono nuove iniziative per accelerare sia la ripresa che l’integrazione. Già nel 2012, un importante rapporto indicava aree chiave come l’unione delle banche e l’unione economica e fiscale. Ci sono stati dei passi avanti, ad esempio nella supervisione delle banche, ma alcuni meccanismi, come quello per risolvere le crisi bancarie, funzionano male. Questo succede perché la poca fiducia porta a decisioni complicate prese dai governi nazionali invece che a livello europeo. L’unione in settori come l’energia è ancora più indietro, con i governi che preferiscono decidere da soli. L’unificazione fiscale è molto lontana, perché ogni paese vuole mantenere il controllo sul proprio bilancio e sulle tasse, e questo richiede un livello di unione e fiducia molto profondo.Il ruolo cruciale dell’Italia
Il futuro dell’Europa dipende molto dall’Italia. L’Italia è fondamentale per la sua importanza economica, essendo la terza economia dell’area euro, ma anche per la sua crisi economica grave e duratura. Questa crisi è fatta di crescita bassa, molta disoccupazione e un sistema economico che non riesce a sbloccarsi. L’Italia è troppo grande per fallire da sola, ma anche troppo grande perché altri paesi possano semplicemente salvarla. La crescente sfiducia verso l’Europa in Italia nasce dal fatto che non tutti capiscono quanto sia grave la crisi, non c’è accordo sulle cause e sulle soluzioni, e si tende a dare la colpa a fattori esterni, compresa l’Europa.I problemi interni e le riforme necessarie
Le analisi fatte a livello internazionale mostrano che i problemi dell’Italia sono soprattutto interni. Per superarli, servono cambiamenti profondi per eliminare ciò che impedisce la crescita e la creazione di posti di lavoro. La credibilità dell’Italia in Europa dipende da quello che il paese fa al suo interno. È indispensabile un programma serio di riforme strutturali in settori chiave come il lavoro, la concorrenza, la giustizia, la burocrazia e la lotta alla corruzione. Queste riforme servono per allineare l’Italia ai livelli degli altri paesi europei.Riforme fiscali e credibilità
Per tornare a essere competitivi, è necessario un intervento specifico sulle tasse che riguardano il lavoro, come l’eliminazione dell’IRAP. Questa misura, anche se costosa per le casse dello stato, deve essere mirata e accompagnata da riforme concrete per essere considerata seria e sostenibile nel tempo. I soldi per coprire il costo possono venire in parte da altre tasse e tagli alle spese, e in parte da un aumento temporaneo del debito pubblico. Questo aumento sarebbe accettato dagli altri paesi europei solo se basato su riforme vere che aumentino la capacità di crescita dell’Italia e migliorino la gestione del debito.Le conseguenze della mancata riforma: l’esempio del 2011
Gli eventi dell’estate del 2011, con la lettera inviata dalla Banca Centrale Europea (BCE) a Italia e Spagna, dimostrano cosa succede quando mancano le riforme. La BCE chiese riforme strutturali per poter intervenire e comprare i titoli di stato italiani e spagnoli, calmando così i mercati finanziari. L’Italia non fece le riforme richieste, concentrandosi solo su misure fiscali. Questo portò a nuove tensioni sui mercati e al cambio di governo. Quell’esperienza portò la BCE a decidere che in futuro avrebbe aiutato i paesi solo se avessero seguito programmi di riforme concordati.L’Italia riformata per un’Europa più forte
Un’Italia che si riforma e diventa credibile può influenzare l’Europa, spingendo per una maggiore unione, ad esempio migliorando l’unione bancaria o creando un unico mercato dell’energia. La capacità dell’Italia di rendere l’Europa più forte dipende dalla sua volontà di cambiare al proprio interno.Se, come sostiene il capitolo, i problemi dell’Italia sono “soprattutto interni”, non è forse riduttivo ignorare il ruolo delle dinamiche europee e globali nel determinare sia la crisi che le possibili soluzioni?
Il capitolo pone una forte enfasi sulla responsabilità interna dell’Italia per la sua crisi economica, basandosi su “analisi internazionali”. Tuttavia, questa prospettiva rischia di semplificare eccessivamente un quadro complesso, trascurando l’impatto di fattori esterni come la struttura stessa dell’unione monetaria europea, le politiche di austerità promosse a livello comunitario o le crisi finanziarie globali. Per ottenere una visione più completa e bilanciata, sarebbe utile approfondire lo studio della macroeconomia internazionale e dell’economia politica dell’integrazione europea. Autori come Paul Krugman o Joseph Stiglitz offrono prospettive critiche sulla governance della zona euro che possono arricchire la comprensione delle cause della crisi italiana, affiancando l’analisi dei pur innegabili problemi strutturali interni.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]