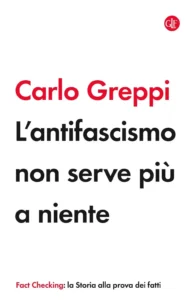1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“25 aprile 1945” di Carlo Greppi non è solo la cronaca di una data, ma un viaggio intenso dentro gli ultimi, cruciali giorni della Resistenza italiana nel Nord Italia. Il libro ti porta a Milano, Genova, Torino, nel cuore dell’insurrezione partigiana che portò alla Liberazione. Scoprirai le figure chiave del CLNAI e del Corpo Volontari della Libertà (CVL), come Raffaele Cadorna, Ferruccio Parri (Maurizio) e Luigi Longo (Italo), uomini con visioni diverse ma uniti contro il nazifascismo. Vedrai le tensioni politiche tra i partiti, le difficoltà nel coordinare le forze, i rischi della clandestinità e gli arresti che minacciarono il comando. È la storia di un movimento che, nonostante le sfide interne e i rapporti complessi con gli Alleati, trovò la forza per la spinta finale, culminata nell’incontro decisivo all’Arcivescovado di Milano il 25 aprile 1945. Un racconto avvincente che non dimentica il sacrificio e l’importanza della memoria di quel momento fondamentale per la storia d’Italia.Riassunto Breve
La Resistenza nel Nord Italia si organizza dopo il settembre 1943 per combattere l’occupazione nazista e la Repubblica Sociale Italiana. Diverse forze politiche si uniscono nel Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI) a Milano, creando un comando militare, il Corpo Volontari della Libertà (CVL). Figure centrali sono il generale Valenti (Raffaele Cadorna), inviato dal Sud per il coordinamento militare, Maurizio (Ferruccio Parri) del Partito d’Azione, e Italo (Luigi Longo) del Partito Comunista, che ricoprono ruoli di vice. Nonostante l’obiettivo comune, esistono forti tensioni interne, specialmente sulla guida militare, con Alleati e partiti moderati che favoriscono Valenti, mentre Maurizio e Italo, rappresentanti delle formazioni partigiane più numerose e politicamente orientate, rivendicano il controllo e diffidano dei militari tradizionali. La vita dei leader è segnata dalla clandestinità, dal rischio e dalla difficoltà di coordinare forze eterogenee. Il comando del CVL affronta problemi di collegamento, mancanza di fondi e difficoltà nei rapporti con gli Alleati, che a volte sembrano frenare l’azione partigiana, come con il proclama Alexander. Italo reagisce a questo proclama spingendo per l’intensificazione della lotta e la guerriglia. La situazione si complica con arresti importanti: Maurizio viene catturato nel gennaio 1945, e Palombo, uomo chiave per informazioni e collegamenti, nel febbraio 1945, distruggendo parte dell’organizzazione. Tentativi audaci di liberare Maurizio falliscono, portando all’arresto di Franchi (Edgardo Sogno). Nonostante le perdite, la spinta per l’unificazione delle forze continua. Il movimento cresce fino a centinaia di migliaia di uomini. La leadership partigiana, in particolare Italo, preme per un’insurrezione popolare immediata, emettendo direttive per attaccare i presidi nazifascisti e liberare le città con l’ultimatum “Arrendersi o perire”. Il 25 aprile 1945, un incontro cruciale a Milano tra rappresentanti della Resistenza (Marazza, Lombardi, Valenti) e capi fascisti (Mussolini, Graziani) nell’Arcivescovado vede la richiesta di resa incondizionata. La discussione si interrompe quando si scopre che i tedeschi stanno trattando segretamente con gli Alleati, spingendo Mussolini alla fuga. L’insurrezione generale scatta, guidata dai partigiani, che liberano le città del Nord prima dell’arrivo alleato. Il CLNAI decide la condanna a morte di Mussolini e dei gerarchi. La liberazione avviene grazie all’azione diretta del movimento partigiano, con grande sacrificio. Nel dopoguerra, emergono divisioni politiche tra i leader, in particolare tra Longo e Cadorna, con polemiche sul passato e visioni diverse sul futuro. Nonostante le divergenze, i protagonisti sottolineano l’importanza dell’unità antifascista raggiunta durante la lotta. La memoria della Resistenza diventa oggetto di dibattito politico, ma la lotta è vista come fondamentale per la nascita della democrazia italiana, rappresentando un riscatto morale e politico. La ricostruzione storica si basa sulle testimonianze dirette dei protagonisti, come le memorie di Cadorna, Parri e Longo, che documentano le sfide, le tensioni e i momenti cruciali, come l’insurrezione e l’incontro nell’Arcivescovado. Le loro figure rimangono simboli della lotta per la libertà e i valori democratici.Riassunto Lungo
1. Le anime in lotta per il Nord
Negli ultimi giorni della guerra, il Nord Italia vive un momento decisivo. Le città sono attraversate da insurrezioni popolari che segnano la fase finale della lotta contro l’occupazione nazista e il regime fascista della Repubblica Sociale Italiana. Un evento cruciale in questo contesto avviene a Milano il 25 aprile 1945: un incontro all’Arcivescovado tra i rappresentanti del regime ormai al collasso e i capi della Resistenza. La richiesta dei partigiani è perentoria: la resa senza condizioni e la consegna immediata di tutte le armi. Questo incontro è il culmine di mesi di preparazione e scontri, un passo fondamentale verso la liberazione del paese.Le forze della Resistenza
La lotta per la liberazione nel Nord è guidata e coordinata da organismi specifici. Il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI) è il principale riferimento politico, unendo diverse anime della Resistenza: il Partito d’Azione, il Partito Comunista, la Democrazia Cristiana, il Partito Liberale e il Partito Socialista. Il braccio armato del CLNAI è il Corpo Volontari della Libertà (CVL), che ha la sua sede operativa a Milano. Queste strutture sono essenziali per organizzare le azioni militari e politiche su un vasto territorio, garantendo un minimo di unità tra forze molto diverse tra loro.I volti della guida
Al vertice di questa complessa macchina organizzativa ci sono figure di grande rilievo, ognuna con un ruolo e una storia specifici. Il generale Valenti, il cui vero nome è Raffaele Cadorna, viene inviato dal Sud per portare la sua esperienza militare nel coordinamento delle operazioni partigiane. Accanto a lui operano Maurizio, alias Ferruccio Parri, esponente di spicco del Partito d’Azione, e Italo, noto come Luigi Longo o Comandante Gallo, una delle figure più importanti del Partito Comunista. Questi uomini rappresentano le diverse anime politiche e militari che compongono il fronte della Resistenza nel Nord.Tensioni e visioni diverse
Nonostante l’obiettivo comune di sconfiggere il nemico nazifascista, la Resistenza non è un blocco monolitico. Esistono forti tensioni interne e visioni differenti, soprattutto per quanto riguarda la guida militare e il futuro assetto politico dell’Italia. Gli Alleati e i partiti più moderati all’interno del CLNAI favoriscono un comando militare affidato a Valenti, una figura legata all’esercito tradizionale. Al contrario, Maurizio e Italo, che rappresentano le formazioni partigiane più numerose e politicamente connotate, rivendicano un maggiore controllo politico sulle operazioni e guardano con diffidenza ai militari di carriera. Questa divergenza sulla struttura di comando e sulla necessità di garanzie politiche genera dibattiti intensi e non facili equilibri.La vita nella clandestinità
La quotidianità di questi leader è fatta di clandestinità, rischio costante e immense difficoltà operative. Si muovono nell’ombra, usando nomi di battaglia e cambiando continuamente nascondigli per sfuggire alla repressione. Devono stabilire contatti segreti, gestire le scarse risorse disponibili e coordinare azioni militari e politiche su un territorio vastissimo e ostile. Non affrontano solo il nemico esterno, ma anche i conflitti interni tra le diverse componenti della Resistenza e le differenti idee su come dovrà essere l’Italia liberata. L’insurrezione del 25 aprile è il punto di arrivo di questo percorso durissimo, il momento in cui anni di lotta segreta e dinamiche complesse portano alla spinta finale per riconquistare la libertà.Il capitolo descrive le “insurrezioni popolari” come segnale della fase finale, ma poi si concentra quasi esclusivamente sulla struttura di comando e sui leader. Quanto queste insurrezioni furono realmente “popolari” nel senso di spontanee o guidate dal basso, e quanto furono invece una diretta conseguenza della pianificazione del CLNAI e del CVL?
Il capitolo, pur riconoscendo le “insurrezioni popolari”, dedica la maggior parte dello spazio alla descrizione della struttura di comando e dei suoi vertici. Questo approccio rischia di non rendere pienamente conto della complessità del fenomeno insurrezionale, che non fu solo il risultato di direttive dall’alto. Per comprendere meglio quanto l’insurrezione del 25 aprile fu un movimento radicato nella popolazione e quali furono le sue dinamiche non strettamente legate alla catena di comando militare o politica, è utile approfondire la storia sociale della Resistenza. Un autore fondamentale per esplorare le diverse dimensioni di quel periodo, inclusa la partecipazione popolare, è Claudio Pavone.2. Sfide al Vertice Partigiano
La Resistenza nasce spontaneamente dal collasso del settembre 1943. Soldati, ufficiali, professionisti e operai si uniscono per combattere e lavare una vergogna nazionale. Le prime bande si formano nelle valli, portando alla creazione dei Comitati di Liberazione Nazionale, uniti nel CLN di Milano. Questo organismo si dà un comando militare, il Corpo Volontari della Libertà (CVL), guidato da Valenti, con Maurizio e Italo come vice. Il comando del CVL è un’organizzazione complessa, con uffici per i rifornimenti alleati, le informazioni, la propaganda e l’assistenza. Nonostante le difficoltà di collegamento e la mancanza di fondi, la sezione operazioni, il “piccolo comando”, si riunisce regolarmente e prende le decisioni operative più importanti. Valenti cerca di rafforzare l’organizzazione reclutando ufficiali rifugiati in Svizzera e integrando l’organizzazione Franchi per i collegamenti, anche se questa si rivela meno metodica del previsto.Le sfide del Comando
Il lavoro del comando è complicato dalle tensioni politiche tra i partiti, come quella tra Valenti e Somma. I finanziamenti, in gran parte dalla Svizzera, coprono solo una parte dei bisogni necessari. Una missione al Sud per definire i rapporti con gli Alleati e il governo incontra difficoltà. Queste difficoltà culminano nel proclama Alexander, che sembra invitare alla smobilitazione invernale delle forze partigiane. Italo reagisce al proclama con una circolare che ne ribalta il senso, chiamando all’intensificazione della lotta e a scendere al piano per la guerriglia. Sottolinea la necessità di organizzazione, decisione e solidarietà nazionale, anche forzando i ceti più ricchi a contribuire alla causa.I colpi subiti dal Comando
La situazione si aggrava con gli arresti. Maurizio, di ritorno da una missione, viene catturato il 2 gennaio 1945 insieme alla moglie Ester a causa di coincidenze sfortunate e dell’arresto di un contatto. Nonostante inizialmente non sia riconosciuto, un poliziotto italiano lo identifica come Ferruccio Parri, e Maurizio decide di confermare la sua identità. Anche Valenti è a rischio, avvertito da Radio Londra di fare attenzione. Palombo, l’uomo di fiducia di Valenti per lo stato maggiore e la rete informativa, viene catturato l’8 febbraio con diversi ufficiali e l’archivio del comando, distruggendo gran parte dell’organizzazione di informazione e collegamento.Tentativi di liberazione e nuove perdite
Mentre il comando subisce questi colpi, Franchi e Stefano mettono in atto un’audace azione per liberare Maurizio dall’Albergo Regina. Si fingono ufficiali tedeschi per ingannare le guardie. Il piano fallisce quando vengono scoperti. Stefano viene ferito, e Franchi, per evitare rappresaglie su Maurizio e altri prigionieri, decide di arrendersi. Viene identificato da Saevecke, comandante delle SS a Milano.La lotta continua
Nonostante le perdite e le difficoltà subite, Italo e Valenti continuano a lavorare per l’unificazione delle forze partigiane, riconoscendo l’importanza di un fronte comune, anche se mantengono visioni diverse. La situazione sul campo resta critica, con l’organizzazione partigiana in crisi nelle campagne e nelle città. Ma l’appello del Comando Generale del 5 febbraio 1945 lancia un segnale forte: chiama tutti i patrioti e gli italiani alla lotta finale contro nazisti e fascisti, sentendo imminente l’ora della resa dei conti.Quanto le “tensioni politiche tra i partiti”, appena accennate nel capitolo, hanno realmente compromesso l’unità e l’efficacia del Comando Volontari della Libertà?
Il capitolo menziona le difficoltà del comando dovute alle tensioni politiche, citando l’esempio di Valenti e Somma, ma non approfondisce la natura e l’estensione di questi conflitti. Questa lacuna impedisce di valutare appieno quanto le divisioni interne abbiano inciso sulla capacità operativa e decisionale del vertice partigiano. Per comprendere meglio questo aspetto cruciale, è necessario esplorare la complessa rete di rapporti tra i partiti antifascisti e le loro diverse visioni strategiche e politiche all’interno della Resistenza. Approfondire la storia politica del periodo e leggere autori che hanno analizzato le dinamiche interne del CLN e del CVL, come Pavone o Battaglia, può fornire il contesto necessario per rispondere a questa domanda.3. La Spinta Finale
Il movimento partigiano nel Nord Italia cresce in modo significativo, arrivando a contare centinaia di migliaia di uomini. Questa forza si organizza in un Comando militare con strutture presenti in tutte le regioni settentrionali. Diverse forze politiche partecipano attivamente a questa lotta, tra cui spiccano comunisti, azionisti, socialisti e democratici cristiani. Nonostante l’obiettivo comune, emergono tensioni interne, in particolare tra i capi militari e i rappresentanti dei partiti politici. Queste difficoltà portano anche a dimissioni importanti, come quella del generale Valenti, evidenziando le sfide di coordinamento e visione all’interno del movimento.Il Significato della Lotta e le Direttive
Anche se figure chiave vengono catturate o allontanate, la lotta per la liberazione non si ferma. Per molti italiani, questa battaglia non è solo uno scontro militare contro l’occupante nazifascista, ma rappresenta un profondo riscatto morale e politico per la nazione. Intanto, gli Alleati inviano messaggi che suggeriscono prudenza, invitando i partigiani a limitare le loro azioni in attesa dell’offensiva finale delle truppe alleate. Tuttavia, la leadership partigiana, spinta in particolare dal Partito Comunista con la figura di Italo (Longo), preme per un’insurrezione popolare immediata, credendo che l’azione diretta sia fondamentale per la liberazione.L’Insurrezione e la Liberazione
In risposta a questa spinta, vengono emesse direttive precise che chiamano all’attacco contro i presidi nazifascisti rimasti e alla liberazione delle città del Nord Italia. L’ordine è chiaro e perentorio: “Arrendersi o perire”, un ultimatum rivolto alle forze occupanti. Il 25 aprile 1945 segna un momento cruciale. A Milano, si tiene un incontro decisivo nell’Arcivescovado, mediato dal Cardinale Schuster, tra i rappresentanti della Resistenza (Marazza, Lombardi, Valenti) e i capi fascisti (Mussolini, Graziani). I partigiani chiedono la resa incondizionata delle forze fasciste. La discussione si interrompe bruscamente quando emerge la notizia che i tedeschi stanno già negoziando una resa separata e segreta con gli Alleati. Sentendosi tradito da questa rivelazione, Mussolini abbandona l’incontro nel tentativo di fuggire.Le Conseguenze dell’Incontro
La fuga di Mussolini e la consapevolezza della situazione precipitano gli eventi. L’insurrezione generale, già pianificata, scatta con forza, guidata in prima linea dai partigiani. Le città del Nord Italia vengono rapidamente liberate grazie all’azione coordinata e decisa delle forze della Resistenza italiana. Il CLNAI (Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia) prende decisioni drastiche, tra cui la condanna a morte di Mussolini e dei principali gerarchi fascisti. L’esecuzione di questa sentenza viene affidata a uomini ritenuti di massima fiducia all’interno del movimento partigiano. La liberazione del Nord Italia si compie così grazie all’azione diretta e determinante del movimento partigiano, che ha saputo organizzarsi e agire nel momento decisivo.Davvero l’eredità della Resistenza è così univoca e condivisa come suggerisce il capitolo, o la ‘memoria contesa’ implica divisioni ben più profonde e durature?
Il capitolo introduce il concetto di “memoria contesa”, ma poi descrive l’eredità della Resistenza in termini di valori condivisi come libertà e democrazia, suggerendo una visione forse troppo unitaria. Per comprendere appieno la natura di questa “contesa”, è necessario esplorare la complessa storiografia della Resistenza e l’uso politico della sua memoria nel dopoguerra. Le divisioni non furono solo tra capi militari, ma rifletterono profonde differenze politiche e ideologiche che hanno plasmato il dibattito pubblico per decenni. Approfondire la storia politica dell’Italia repubblicana e la storiografia della Resistenza, leggendo autori che hanno analizzato le diverse interpretazioni e i conflitti sulla sua eredità, è fondamentale per cogliere la reale portata della “contesa”.5. Voci e Memorie della Liberazione
La storia della Liberazione è raccontata dalle voci di chi l’ha vissuta. Molte testimonianze dirette di protagonisti della Resistenza e delle giornate dell’insurrezione sono fondamentali per capire cosa è successo. Si usano ampie citazioni da libri scritti da loro dopo la guerra e documenti dell’epoca, come ordini, messaggi radio e telegrammi. Si dà più peso alle parole di chi ha combattuto il fascismo, perché le fonti fasciste spesso cercano di giustificarsi. Queste testimonianze permettono di capire non solo gli eventi, ma anche gli stati d’animo di quel periodo cruciale.I Protagonisti della Liberazione
Al centro di questa storia ci sono figure come Raffaele Cadorna (Valenti), Ferruccio Parri (Maurizio) e Luigi Longo (Italo). Accanto a loro, emergono altri nomi importanti: Achille Marazza, Riccardo Lombardi, Sandro Pertini, Leo Valiani e Edgardo Sogno (Franchi). I loro ricordi e i loro scritti sono essenziali per capire cosa è successo e come si sentivano le persone in quei giorni. Si vedono chiaramente le difficoltà nel mettere d’accordo le diverse forze antifasciste. C’erano anche problemi pratici, come la mancanza di armi.I Momenti Chiave dell’Insurrezione
Vengono raccontati i momenti più importanti, come l’insurrezione scoppiata nelle città del nord, specialmente a Genova, Torino e Milano. Si riportano gli inviti a combattere, come l’ordine di sciopero generale e il famoso proclama “Arrendersi o perire!”. Un fatto centrale è l’incontro avvenuto a Milano, nell’Arcivescovado, tra i rappresentanti del CLNAI e Mussolini. Durante quell’incontro, a Mussolini fu chiesta la resa senza condizioni. Le diverse testimonianze su questo evento raccontano la stessa cosa, anche se ci sono piccole differenze sui dettagli.Le Sfide Interne e il Dopoguerra
Si parla anche delle difficoltà e delle tensioni tra i gruppi della Resistenza. C’erano diverse idee su come interpretare il Proclama Alexander. Vengono descritti i rapporti tra i capi partigiani e gli Alleati. Viene raccontato l’arresto di Ferruccio Parri e i tentativi fatti per liberarlo. Dopo la Liberazione, questi protagonisti si impegnano a costruire la nuova Italia. Anche se mantengono opinioni diverse, a volte anche in disaccordo, su quello che è successo e su quello che succederà. Le loro figure restano un simbolo della lotta per la libertà.È davvero possibile comprendere appieno la complessità della Liberazione dando “più peso” solo alle voci di una parte?
Il capitolo dichiara esplicitamente di privilegiare le fonti antifasciste, motivando questa scelta con la presunta tendenza delle fonti fasciste a giustificarsi. Tuttavia, un approccio storico rigoroso richiede l’analisi critica di tutte le fonti disponibili, valutandone i bias intrinseci ma senza scartarle a priori. Ignorare o sottovalutare le testimonianze e i documenti provenienti dal fronte fascista, anche se viziati da tentativi di auto-assoluzione, impedisce di cogliere la totalità del quadro storico, le motivazioni dell’altra parte, le dinamiche interne della Repubblica Sociale Italiana e la natura profonda del conflitto civile. Per un’analisi più completa, sarebbe utile confrontarsi con la storiografia che ha esplorato anche il versante della Repubblica Sociale Italiana e le esperienze di chi si trovò dall’altra parte del fronte, oltre ad approfondire le diverse correnti storiografiche sulla Resistenza stessa. Autori come Claudio Pavone, Renzo De Felice, o studi più recenti che analizzano la guerra civile da prospettive multiple, potrebbero offrire spunti per una visione più articolata.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]