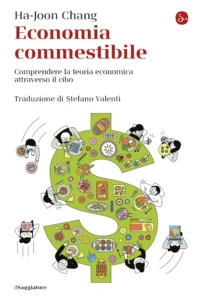Contenuti del libro
Informazioni
RISPOSTA: “23 cose che non ti hanno mai detto sul capitalismo” di Ha-Joon Chang è un libro che ti fa vedere il mondo dell’economia con occhi completamente diversi, sfatando un sacco di miti che ci hanno sempre raccontato. Chang, un economista sudcoreano, ci porta in un viaggio attraverso la storia economica, dimostrando che il “libero mercato” di cui tanto si parla è in realtà un’invenzione politica, plasmata da decisioni che favoriscono alcuni a discapito di altri. Dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna, passando per i “miracoli economici” asiatici come la Corea del Sud, l’autore smonta l’idea che il protezionismo sia sempre un male, mostrando come le nazioni oggi più ricche abbiano usato proprio queste strategie per crescere. Si parla di come la globalizzazione non abbia reso il capitale “senza nazione” come si crede, e di come la vera rivoluzione non sia stata internet, ma invenzioni come la lavatrice che hanno cambiato la vita delle persone. Il libro affronta anche il tema della razionalità limitata, spiegando perché le regole e la pianificazione, sia statale che aziendale, siano fondamentali in un mondo complesso, e come la finanza, troppo veloce e speculativa, stia danneggiando l’economia reale. Chang critica anche la “trickle-down economics”, dimostrando che la ricchezza non cola verso il basso, ma si concentra in poche mani, e che la vera sfida per i paesi in via di sviluppo non è la mancanza di imprenditori, ma l’assenza di organizzazione collettiva e infrastrutture. È una lettura che ti spinge a pensare criticamente al capitalismo, mettendo in discussione le idee preconfezionate e proponendo un approccio più equo e umano all’economia.Riassunto Breve
L’idea di un mercato completamente libero è un’illusione, poiché ogni mercato è definito da regole e confini stabiliti da decisioni politiche, non da leggi naturali. Ciò che viene scambiato, chi può partecipare e come avvengono gli scambi sono tutti aspetti modellati da scelte politiche, spesso così integrate nella nostra cultura da passare inosservate. La percezione della libertà di un mercato dipende dai valori di chi lo osserva: ciò che oggi è considerato una protezione necessaria, come le norme sul lavoro minorile o ambientali, in passato era visto come un ostacolo alla libertà di mercato. Anche concetti come “salario equo” sono soggettivi e frutto di dibattiti politici e morali.I salari, contrariamente alla credenza popolare, non sono determinati unicamente dalla produttività individuale, ma sono influenzati dai controlli sull’immigrazione. La limitazione della libera circolazione delle persone crea disparità salariali tra paesi ricchi e poveri, poiché i lavoratori dei paesi più poveri non possono competere liberamente con quelli dei paesi più ricchi. Questo protezionismo, mascherato da principio di mercato, permette a molti lavoratori nei paesi sviluppati di guadagnare più di quanto la loro produttività giustificherebbe. Inoltre, la gestione aziendale, spesso presentata come orientata all’interesse degli azionisti, si concentra in realtà sul profitto a breve termine, trascurando gli investimenti a lungo termine e il benessere degli altri soggetti coinvolti (stakeholder). Questa enfasi sul “valore per gli azionisti” ha portato a tagli del personale, minori investimenti e, in ultima analisi, a una minore sostenibilità delle imprese e dell’economia.Le innovazioni tecnologiche, sebbene trasformino la comunicazione e l’accesso alle informazioni, non sempre hanno un impatto sociale ed economico paragonabile a quello di invenzioni del passato, come la lavatrice, che ha liberato tempo e permesso alle donne di entrare nel mondo del lavoro, modificando profondamente la struttura familiare e sociale. L’idea che internet abbia “finito la distanza” è un’esagerazione se confrontata con la riduzione drastica dei tempi di comunicazione offerta dal telegrafo nel XIX secolo. L’eccessiva fascinazione per le nuove tecnologie può portare a decisioni politiche ed economiche errate, come la trascuratezza del settore manifatturiero o l’eccessiva enfasi sul “digital divide” a scapito di necessità più basilari.La priorità data al controllo dell’inflazione negli ultimi decenni, pur portando a una stabilità dei prezzi, non ha reso l’economia mondiale più stabile. Al contrario, ha favorito un aumento delle crisi finanziarie e una maggiore precarietà del lavoro. Le politiche neoliberiste, focalizzate sulla riduzione dell’inflazione, sulla liberalizzazione dei mercati finanziari e sulla flessibilità del lavoro, hanno beneficiato principalmente i detentori di attività finanziarie, ma hanno anche contribuito a una crescita economica più lenta e a una maggiore instabilità generale. L’ossessione per la bassa inflazione ha mascherato problemi più profondi legati all’occupazione e alla crescita reale. L’idea che l’egoismo sia l’unica motivazione umana che guida le azioni economiche è una semplificazione eccessiva; le persone sono mosse anche da onestà, lealtà e senso del dovere. Sistemi economici basati esclusivamente sull’egoismo rischiano di fallire perché ignorano la complessità della natura umana.Le politiche liberiste, spesso presentate come la chiave per la ricchezza dei paesi in via di sviluppo, non sono state la strada seguita dalle nazioni oggi più ricche per raggiungere il loro status. Storicamente, paesi come la Gran Bretagna e gli Stati Uniti hanno prosperato grazie a un mix di protezionismo, sussidi e intervento statale per proteggere e sviluppare le proprie industrie nascenti. L’idea che il capitale sia diventato “senza nazione” a causa della globalizzazione è un mito; le imprese transnazionali tendono a mantenere le attività strategiche nel loro paese d’origine, e la nazionalità del capitale influenza le decisioni aziendali. La nozione di un’economia “postindustriale” nei paesi ricchi è fuorviante; il settore industriale rimane cruciale per la produzione economica, e la deindustrializzazione è spesso dovuta a un aumento della produttività nel manifatturiero rispetto ai servizi.L’idea che gli Stati Uniti abbiano il tenore di vita più alto al mondo è un’illusione dovuta alla forte disuguaglianza nella distribuzione del reddito. Molti americani vivono in condizioni precarie, e il costo più basso di alcuni servizi è spesso il risultato di salari bassi e condizioni di lavoro svantaggiose. Gli americani lavorano significativamente di più rispetto ai cittadini di altri paesi ricchi per ottenere un reddito pro capite inferiore, se rapportato alle ore lavorate. La stagnazione africana degli ultimi decenni è attribuibile alle politiche di libero mercato imposte tramite gli “Structural Adjustment Programs” (SAP), che hanno danneggiato l’industria locale e aumentato la dipendenza dalle materie prime, piuttosto che a fattori “strutturali” come clima o geografia. La teoria che lo Stato sia incapace di fare scelte imprenditoriali valide è smentita da numerosi esempi di successo in paesi come la Corea del Sud, dove la collaborazione tra settore pubblico e privato ha portato a risultati economici notevoli.L’idea che rendere i ricchi ancora più ricchi porti benefici a tutti (“trickle-down economics”) non ha funzionato; la ricchezza tende a concentrarsi in poche mani. Le retribuzioni dei manager americani sono sproporzionatamente elevate rispetto ai loro colleghi in altri paesi sviluppati e rispetto ai loro predecessori, senza un aumento proporzionale della produttività. I manager sono protetti da conseguenze negative grazie al potere economico e politico accumulato, che usano per diffondere l’ideologia del libero mercato. La convinzione che la povertà nei paesi in via di sviluppo sia causata dalla mancanza di spirito imprenditoriale è errata; le persone in questi paesi sono spesso molto intraprendenti per necessità, ma la loro intraprendenza individuale non si traduce in sviluppo economico a causa della mancanza di organizzazione collettiva e infrastrutture. Il microcredito si è rivelato inefficace nel promuovere lo sviluppo a lungo termine. Ciò che distingue i paesi ricchi è la loro capacità di organizzare lo spirito imprenditoriale in modo collettivo attraverso grandi aziende, cooperative, sistemi educativi e finanziari avanzati, e collaborazione tra imprese.L’idea che i mercati debbano essere lasciati liberi perché gli attori economici sono razionali e conoscono i propri interessi ignora la nostra razionalità limitata. Il mondo è così complesso che la nostra capacità di comprenderlo e gestirlo è circoscritta. Fallimenti di fondi di investimento gestiti da premi Nobel o la crisi finanziaria del 2008 dimostrano come l’ipotesi di razionalità assoluta sia fallace. In questi casi, le regole imposte dal governo non funzionano perché il governo è più informato, ma perché limitano la complessità delle scelte, riducendo la possibilità di errori. Le routine e le regole aiutano a gestire la complessità. Pertanto, le regolamentazioni non sono sempre un ostacolo, ma possono essere necessarie proprio perché la nostra capacità di giudizio è limitata. L’istruzione, sebbene arricchisca la vita individuale, ha un impatto diretto limitato sulla crescita economica; la vera prosperità nazionale risiede nella capacità di organizzare le persone in imprese ad alta produttività, supportate da istituzioni solide. Non tutto ciò che è vantaggioso per una singola impresa lo è anche per l’economia nel suo complesso; regole ben concepite possono proteggere risorse comuni e migliorare la produttività collettiva a lungo termine.La pianificazione economica è intrinseca alle economie capitaliste moderne, sia a livello governativo che aziendale. L’uguaglianza di opportunità non è sufficiente per garantire una società giusta ed efficiente; è necessario un certo grado di uguaglianza nei risultati, specialmente in termini di reddito familiare, per permettere a tutti di sfruttare appieno le opportunità. Uno stato sociale ben strutturato può incoraggiare l’apertura al cambiamento e l’assunzione di rischi, offrendo una rete di sicurezza che permette ai lavoratori di affrontare con maggiore serenità le transizioni professionali e le ristrutturazioni industriali, favorendo così il dinamismo economico.I mercati finanziari, con la loro crescente efficienza e rapidità, hanno creato problemi all’economia reale, generando instabilità e rendendo difficile per le imprese ottenere il “capitale paziente” necessario per la crescita a lungo termine. È necessario ridurre l’efficienza dei mercati finanziari attraverso strumenti come una tassa sulle transazioni finanziarie o restrizioni alle acquisizioni ostili per rallentare i flussi finanziari e trovare un equilibrio che permetta alle aziende di investire nel lungo termine. L’eccessiva influenza degli economisti liberisti ha portato a risultati negativi, tra cui minore crescita, maggiore instabilità e disuguaglianza. Le politiche economiche di successo sono state spesso guidate da professionisti con competenze diverse dall’economia. È fondamentale abbandonare l’idea che i mercati liberi siano sempre la soluzione ottimale e riconoscere i limiti della razionalità umana. La ricostruzione dell’economia mondiale richiede un ripensamento dei principi fondamentali, promuovendo un sistema che valorizzi la cooperazione e la responsabilità sociale, oltre all’interesse personale, e che garantisca pari opportunità. È necessario dare maggiore importanza alla produzione di beni materiali e trovare un equilibrio tra finanza e attività reali, supportando un ruolo più attivo dello Stato e favorendo i paesi in via di sviluppo.Riassunto Lungo
1. Il Mercato Non È Libero, Ma Politico
La natura politica delle regole di mercato
L’idea che esista un “libero mercato” oggettivamente definito è un mito. Ogni mercato opera secondo regole e confini che sono il risultato di decisioni politiche, non di leggi naturali. Queste regole, che definiscono cosa si può scambiare, chi può partecipare e come avvengono gli scambi, sono spesso così radicate nella nostra cultura che non le notiamo più, come le corde che sorreggono i maestri di kung fu nei film. La percezione della “libertà” di un mercato dipende dai valori di chi lo osserva. Ad esempio, la regolamentazione del lavoro minorile o le norme ambientali, considerate oggi necessarie, furono in passato viste come violazioni della libertà di mercato. Allo stesso modo, la definizione di cosa costituisca un salario “equo” o condizioni di lavoro “umane” è soggettiva e legata a dibattiti politici e morali, non a dati economici assoluti.L’influenza delle politiche migratorie sui salari
Anche i salari, contrariamente a quanto si crede, non sono determinati principalmente dalla produttività individuale, ma dai controlli sull’immigrazione. La limitazione della libera circolazione delle persone crea un divario salariale tra paesi ricchi e poveri, poiché i lavoratori dei paesi più poveri non possono competere liberamente con quelli dei paesi più ricchi. Questo protezionismo, mascherato da principio di mercato, fa sì che molti lavoratori nei paesi sviluppati guadagnino più di quanto la loro produttività giustificherebbe.La focalizzazione sul profitto a breve termine
Inoltre, la gestione delle aziende, spesso presentata come finalizzata all’interesse degli azionisti, si concentra invece sul profitto a breve termine, a scapito degli investimenti a lungo termine e del benessere degli altri stakeholder. Questa enfasi sul “valore per gli azionisti” ha portato a tagli del personale, a una minore attenzione agli investimenti e, in ultima analisi, a una minore sostenibilità delle imprese e dell’economia nel suo complesso.Verso una maggiore consapevolezza economica
Comprendere che l’economia è intrinsecamente politica e che i confini del mercato sono negoziabili è fondamentale per costruire una società più giusta, dove le decisioni economiche tengano conto non solo del talento individuale, ma anche del contesto storico e delle azioni collettive.Se il mercato non è libero ma politico e i salari sono influenzati dalle politiche migratorie, non si dovrebbe forse riconoscere che la “competizione” tra lavoratori, spesso additata come causa di salari bassi, è in realtà una competizione artificialmente limitata da decisioni politiche, e che quindi la vera “libertà” di mercato implicherebbe la libera circolazione delle persone?
Il capitolo suggerisce che la percezione della libertà di mercato è legata a decisioni politiche e che la limitazione della circolazione delle persone distorce i salari. Tuttavia, non approfondisce le implicazioni di questa affermazione sulla definizione stessa di “competizione” e “libertà” nel contesto economico. Per comprendere meglio queste dinamiche, sarebbe utile approfondire i concetti di economia politica, studiando autori come Karl Marx per un’analisi critica delle strutture di potere nel capitalismo, e Amartya Sen per una prospettiva sui diritti umani e la libertà come capacità. Un’analisi delle teorie sulla globalizzazione e sulle disuguaglianze internazionali potrebbe fornire ulteriore contesto.2. Innovazioni Trasformative e la Vera Stabilità Economica
L’Impatto Reale delle Invenzioni
Si tende a pensare che le innovazioni più recenti, come internet, siano le più rivoluzionarie. Tuttavia, tecnologie del passato hanno avuto un impatto sociale ed economico ben più profondo. La lavatrice, ad esempio, insieme ad altri elettrodomestici, ha liberato moltissimo tempo, soprattutto per le donne, permettendo loro di entrare nel mondo del lavoro e modificando radicalmente la struttura della famiglia e della società. L’idea che internet abbia eliminato le distanze o creato un mondo senza confini è spesso un’esagerazione, specialmente se confrontata con la drastica riduzione dei tempi di comunicazione offerta dal telegrafo nel XIX secolo, che rappresentò un salto qualitativo molto più significativo. La continua fascinazione per le nuove tecnologie, come internet, porta a decisioni politiche ed economiche che trascurano settori fondamentali, come quello manifatturiero, o che pongono un’eccessiva enfasi sul “digital divide” a scapito di bisogni più urgenti nei paesi in via di sviluppo.La Falsa Promessa della Stabilità dei Prezzi
Negli ultimi decenni, la priorità data al controllo dell’inflazione, pur avendo portato a una stabilità dei prezzi, non ha reso l’economia mondiale veramente più stabile. Anzi, questo approccio ha favorito un aumento delle crisi finanziarie e una maggiore precarietà lavorativa. Le politiche economiche focalizzate sulla riduzione dell’inflazione, sulla liberalizzazione dei mercati finanziari e sulla flessibilità del lavoro hanno portato benefici soprattutto a chi possiede attività finanziarie. Allo stesso tempo, però, hanno contribuito a una crescita economica più lenta e a un’instabilità generale più marcata. L’ossessione per la bassa inflazione, spesso presentata come la chiave per la prosperità, ha in realtà mascherato problemi più seri legati all’occupazione e alla crescita reale. Questo dimostra che la sola stabilità dei prezzi non è sufficiente a garantire una vera stabilità economica.La Complessità della Motivazione Umana
L’idea che l’egoismo sia l’unica forza motrice dietro le azioni economiche umane è una semplificazione eccessiva. Sebbene l’interesse personale giochi un ruolo importante, le persone sono spinte anche da altre motivazioni fondamentali, come l’onestà, la lealtà e il senso del dovere. I sistemi economici che si basano esclusivamente sull’egoismo rischiano di fallire proprio perché ignorano questa complessità della natura umana. Le aziende e le società che, invece, riconoscono e valorizzano queste altre motivazioni, come dimostrano alcuni modelli di gestione aziendale, ottengono risultati migliori. La moralità non è semplicemente un’illusione creata da meccanismi nascosti di ricompensa e punizione, ma una componente essenziale del comportamento umano. Ignorarla porta a un sistema economico inefficiente e a risultati peggiori.Se l’impatto del telegrafo è stato “drasticamente più significativo” di internet, perché il capitolo non approfondisce le implicazioni di questa affermazione storica, lasciando il lettore a chiedersi quali siano le vere metriche di paragone e il contesto mancante per valutare la “vera stabilità economica” in relazione a queste innovazioni?
Il capitolo presenta un interessante parallelo tra l’impatto di tecnologie passate e presenti, ma la sua argomentazione sulla superiorità del telegrafo rispetto a internet, in termini di “salto qualitativo” e “vera stabilità economica”, necessita di un’analisi più approfondita. Per comprendere appieno la portata di tale affermazione e le sue implicazioni, sarebbe utile esplorare discipline come la storia della tecnologia e l’economia dello sviluppo, magari consultando lavori che analizzano l’impatto a lungo termine delle infrastrutture di comunicazione, come quelli che potrebbero essere associati al pensiero di studiosi che hanno analizzato la diffusione delle reti e l’impatto sociale delle innovazioni tecnologiche.3. Lezioni dalla Storia: Protezionismo, Industria e Nazionalità del Capitale
Le politiche economiche delle nazioni ricche
Le politiche liberiste, spesso presentate come la chiave per la ricchezza dei paesi in via di sviluppo, in realtà non sono state la strada seguita dalle nazioni oggi più ricche per raggiungere il loro status. Storicamente, paesi come la Gran Bretagna e gli Stati Uniti hanno prosperato grazie a un mix di protezionismo, sussidi e altre forme di intervento statale per proteggere e sviluppare le proprie industrie nascenti. Questo approccio, che oggi viene sconsigliato ai paesi in via di sviluppo, era considerato fondamentale per permettere alle industrie di crescere e diventare competitive a livello globale.La nazionalità del capitale nell’era globale
L’idea che il capitale sia diventato “senza nazione” a causa della globalizzazione è un mito. Le imprese transnazionali, pur operando a livello internazionale, tendono a mantenere le attività strategiche e di ricerca e sviluppo nel loro paese d’origine. La nazionalità del capitale influenza le decisioni aziendali, spesso privilegiando il paese d’origine per ragioni economiche, storiche e persino morali. Le acquisizioni estere, ad esempio, non sempre portano a una vera transnazionalizzazione, ma spesso a un controllo centralizzato nel paese d’origine.Il ruolo persistente dell’industria
La nozione di un’economia “postindustriale” nei paesi ricchi è fuorviante. Sebbene la percentuale di occupati nell’industria manifatturiera sia diminuita, il settore industriale rimane cruciale per la produzione economica. La deindustrializzazione è principalmente dovuta a un aumento della produttività nel settore manifatturiero rispetto ai servizi, che ha portato a una diminuzione relativa dei prezzi dei prodotti industriali. Questo fenomeno, sebbene possa indicare dinamismo, comporta rischi per la crescita della produttività complessiva e per la bilancia dei pagamenti, specialmente per i paesi in via di sviluppo che non dovrebbero saltare la fase di industrializzazione. Le economie che sembrano basarsi sui servizi, come Svizzera e Singapore, hanno in realtà solide fondamenta industriali.Se la pianificazione è così fondamentale per le economie complesse, perché il capitolo non affronta le criticità e i fallimenti storici della pianificazione centralizzata, limitandosi a un’affermazione generica sulla sua pervasività nel capitalismo moderno?
Il capitolo sembra dare per scontato che la pianificazione, sia governativa che aziendale, sia intrinsecamente benefica e funzionale senza un’analisi critica delle sue potenziali inefficienze, distorsioni o dei rischi di eccessiva burocratizzazione. Inoltre, l’affermazione che i paesi con sistemi di welfare più robusti tendano ad avere una crescita maggiore necessita di un contesto più ampio, considerando le diverse variabili economiche e sociali che influenzano la crescita. Per approfondire la comprensione delle complessità della pianificazione economica, sarebbe utile esplorare le teorie economiche che analizzano i fallimenti del mercato e le diverse forme di intervento statale, magari consultando autori come Friedrich Hayek per una prospettiva critica sulla pianificazione, e John Maynard Keynes per le teorie sull’intervento statale. Per quanto riguarda il legame tra stato sociale e crescita economica, un’analisi più approfondita delle politiche di welfare e del loro impatto sulla produttività e sull’innovazione potrebbe beneficiare dalla lettura di studi comparativi sui modelli di welfare europei e nordamericani, magari con riferimento a lavori di economisti come Amartya Sen.8. Finanza Veloce, Economia Lenta e Necessità di Equilibrio
L’impatto della velocità finanziaria sull’economia reale
I mercati finanziari, sempre più veloci ed efficienti, hanno creato sfide per l’economia vera e propria. Se da un lato la liberalizzazione finanziaria ha permesso di muovere le risorse più rapidamente, dall’altro ha causato instabilità, come si è visto nella crisi del 2008. La velocità con cui il denaro si sposta nel mondo della finanza rende difficile per le aziende trovare il “capitale paziente”, quello necessario per crescere nel tempo. Questa differenza di tempi tra finanza ed economia reale porta a instabilità nel breve periodo e rallenta la crescita della produttività nel lungo termine, perché gli investimenti che richiedono tempo vengono sacrificati per ottenere profitti immediati.Strategie per rallentare la finanza e favorire investimenti a lungo termine
Per risolvere questo problema, è utile ridurre l’efficienza dei mercati finanziari. Si possono usare strumenti come una tassa sulle transazioni finanziarie, limitare le acquisizioni ostili, vietare le vendite allo scoperto e aumentare i requisiti di margine. Questi metodi aiutano a rallentare i movimenti di denaro. L’obiettivo non è fermare la velocità della finanza, ma trovare un equilibrio che permetta alle aziende di investire per il futuro, mantenendo allo stesso tempo la necessaria fluidità.Critica all’eccessiva influenza delle teorie economiche liberiste
Inoltre, l’eccessiva influenza degli economisti liberisti negli ultimi trent’anni ha portato a risultati negativi, come una crescita più lenta, maggiore instabilità e aumento delle disuguaglianze. Le politiche economiche che hanno avuto successo, come quelle dei paesi asiatici durante il loro periodo di forte crescita, sono state spesso guidate da professionisti con competenze diverse dall’economia, come ingegneri e avvocati. Questo dimostra che una conoscenza specialistica dell’economia, specialmente se orientata al liberismo, non garantisce automaticamente il successo.Necessità di un approccio più cauto e di una regolamentazione efficace
È fondamentale abbandonare l’idea che i mercati liberi siano sempre la soluzione migliore e riconoscere i limiti della razionalità umana. La complessità del mondo finanziario è diventata tale da superare la nostra capacità di gestirla, portando a crisi. Serve un approccio più prudente, che valuti i benefici a lungo termine dei nuovi strumenti finanziari, proprio come si fa per la sicurezza dei prodotti di uso quotidiano.Ripensare il capitalismo per un futuro più equilibrato e cooperativo
La ricostruzione dell’economia mondiale richiede un ripensamento dei principi fondamentali. Il capitalismo, pur essendo il sistema migliore tra quelli disponibili, necessita di una regolamentazione più efficace. È importante promuovere un sistema che valorizzi la cooperazione e la responsabilità sociale, oltre all’interesse personale, e che garantisca pari opportunità, soprattutto ai più giovani. Bisogna dare maggiore importanza alla produzione di beni materiali, trovare un equilibrio tra finanza e attività economiche reali, supportare un ruolo più attivo dello Stato e favorire i paesi in via di sviluppo.Se la soluzione è rallentare la finanza, perché l’efficienza dei mercati finanziari è stata perseguita per decenni come un obiettivo desiderabile, e quali sono le prove concrete che dimostrano che “rallentare” la finanza porterebbe effettivamente a un maggiore “capitale paziente” e non a una semplice inefficienza dannosa?
Il capitolo suggerisce che la velocità della finanza sia la causa primaria dei problemi economici, proponendo come soluzione una sua riduzione attraverso misure specifiche. Tuttavia, manca un’analisi approfondita del dibattito accademico che ha sostenuto per lungo tempo l’efficienza dei mercati come motore di crescita e allocazione ottimale delle risorse. Inoltre, non vengono fornite evidenze empiriche solide che dimostrino il nesso causale tra la riduzione della velocità finanziaria e l’aumento del “capitale paziente”, né si chiarisce come distinguere una sana “fluidità” da un’eccessiva volatilità. Per comprendere meglio questo aspetto controverso, sarebbe utile approfondire gli studi sull’impatto delle transazioni finanziarie sull’economia reale e le teorie alternative sulla stabilità finanziaria. Autori come Hyman Minsky, con la sua teoria del “ciclo finanziario”, o economisti che hanno studiato l’impatto delle regolamentazioni finanziarie, potrebbero offrire prospettive illuminanti.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]